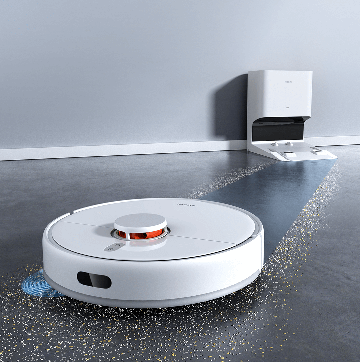Non credo ci sia bisogno di ricordare ai lettori qual è stato l’argomento più discusso in questi primi scampoli di villeggiatura, ma nel caso qualcuno si fosse distratto lo rimettiamo nero su bianco: l’anniversario dell’allunaggio. Ecco, a distanza di 50 anni ancora ci si scervella sull’autenticità o meno dell’evento, come se non si fosse detto abbastanza. Al di là del fattore mediatico/ polemico che ancora funziona alla grande, solo una certezza rimane: la colonna sonora di quel lancio fu la musica dei Pink Floyd.
Che i suoni della band simbolo della psichedelia, sdoganata al mainstream pur rimanendo senza compromessi, fossero parto di uno spazio siderale è fuor di dubbio. Un cosmo che è sia interno che rivolto all’esterno, partendo dal basso per slanciarsi in alto come una navicella interstellare, e che ben trova una summa nel lato b di un disco che, per molti, avrebbe potuto anche siglare la giusta fine della band in maniera magistrale, in bellezza. E che ha il sapore sonoro proprio di quella Moonhead eseguita dai nostri eroi, in forma di jam session, durante la diretta della conquista della luna.
Stiamo parlando di Ummagumma, che compie 50 anni proprio come l’allunaggio e a risentirlo è davvero qualcosa di indigesto, una allucinazione totale e perversa in cui la non musica diventa la cifra principale di un manifesto esistenziale - più che musicale - di un altro pianeta o satellite che dir si voglia. A conti fatti è “semplicemente” un laboratorio per mostrare le capacità individuali dei singoli elementi, un po’ come il White album dei Beatles, con la differenza ovvia di un approccio che del pop non ne vuole sapere.
Tra questi singoli elementi spicca un nome: Richard Wright. il tastierista (che il 28 luglio avrebbe compiuto gli anni), da sempre figura introversa e defilata, con l’epopea in quattro parti di Sysyphus (nome che è tutto un programma: evoca il mito di Sisifo, condannato a spingere un enorme masso fino alla cima di un monte in un loop spietato, senza mai poterci riuscire) tira fuori dal subconscio della band degli incubi sonori tipici da “volo dal balcone”, soprattutto dopo aver assunto determinate sostanzine. Wright nei Floyd è sempre stato apparentemente in ombra ma in realtà assoluto protagonista: sia per i suoni che riusciva a tirare fuori dal suo organo in un periodo in cui ancora i synth erano oggetto di lusso, sia per il modo di muovere le dita sui tasti, con quegli esperimenti sulle scale frigie che hanno fatto la storia (un esempio per tutti, la spettrale Careful with that axe Eugene).
E poi anche egregio autore/cantante di canzoni stuporose, basti pensare alla struggente Remember a day: qualità che, una volta persa la leadership carismatica di Syd Barrett, portarono i discografici a puntare sul suo cavallo per rimettere in pista la band, cercando di trasformarlo nel principale autore e frontman. Non se ne fece nulla perché i Pink Floyd divennero a tutti gli effetti un’entità unica (cosa che viene metaforizzata, Barrett a parte, anche con la figura tragica di Pink in The Wall, album del quale tra l’altro ricorre il quarantennale), ma Wright continuò ad essere unico ed essenziale nei suoi contributi, che rivelano un'anima fratturata e indecisa tra il melodramma cosmico e la canzone, intesa come racconto che scorre via e che non necessariamente deve rimanere nella memoria.
E infatti ad un certo punto Wright si blocca: dopo Wish you were here, album che segna in modo simbolico la fine della band in quanto ad affiatamento e l’inzio effettivo della leadership di Waters, non riuscirà e non vorrà dare più contributi al gruppo, tanto che per i suoi problemi di droga verrà messo alla porta proprio durante le registrazioni di The Wall, rimanendo nel progetto esclusivamente come turnista. Nel 1978 però, forse come uno sfregio alla band o – se vogliamo credere alle sue dichiarazioni del tempo - come un tentativo di risorgere dal torpore, scrive un album passato in sordina, ovvero Wet Dream.
Un disco che ha la caratteristica di suonare cupo nonostante – o forse proprio per questo motivo – si evochino desideri di evadere verso ampi spazi per staccare la spina e ritrovare sé stessi, nello specifico spazi marini come evocati nella esplicita Waves. È un lavoro che sembra volutamente demodé, in cui le formule dal nostro sperimentate in The dark side of the moon – ovvero gli slow con inserti di solo sax e determinate progressioni armoniche in cui la melanconia la fa da padrona – sono qui riprese come una specie di salvagente a cui attaccarsi al largo mentre l’oceano è in piena.
Nonostante gli evidenti difetti, primo dei quali il fatto che nessun pezzo suona veramente originale, è un disco che lavora di sottofondo e in punta di piedi: si sente che Wright l’ha scritto solo per sé. Una specie di versione “in sordina” di quel capolavoro che era Pacific Ocean Blue di Dennis Wilson, uscito l’anno prima: ma visto in termini di autoterapia, funziona. Lo metti sul giradischi e ti lasci cullare, come se si ascoltasse il suono delle onde sulla battigia, senza nessun tipo di pretesa se non il puro ascolto.
Nell’incipit del disco però questa mia affermazione viene sfatata : nell’introduttiva Mediterrean C vi troviamo infatti un riff che poi verrà preso in prestito da Waters per il brano d’apertura di The wall, ovvero In the flesh?. Anche se Wright non sarà accreditato: quasi un modo per riportarlo in seno ai compagni. Perché poi, finita l’avventura del muro, Wright viene estromesso definitivamente dalla band con The final cut: ci vorranno un po’ di anni prima che la band si riformi, orfana di un Waters sempre più autoritario, con a capo il più morbido David Gilmour.
In mezzo a questo limbo temporale, Wright nell’84 sembra risorgere dalle ceneri pubblicando un album controverso, osando come non aveva osato neanche in quel famoso Ummagumma: col quale troviamo molti punti in comune. Infatti, nonostante le critiche entusiastiche dell’epoca e il successo commerciale in un certo senso inspiegabile guardandolo dalla nostra prospettiva d’oggi, gli autori dicono di Ummagumma che è stato praticamente un esperimento fallito, che sarebbe stato meglio non fosse mai uscito dal cassetto.
Ecco, la stessa cosa Wright disse di un lavoro che sta per essere ristampato dopo anni di attesa: il suo nome è Identity, esce con la ragione sociale di ZEE ed è un’inedita collaborazione tra l’ex Floyd e il cantante dei Fashion, Dave Harris. Che sia una combo assurda è già evidente: l’uno è un reduce della psichedelia da stadio, l’altro esponente minore della scena new romantic, che ad ogni modo manteneva alcuni elementi tratti dalla psichedelia, soprattutto nell’uso dell’effettistica e delle melodie oniriche. In questo progetto tutto sommato chi osa di più è Wright, che si compra un Fairlight, all’epoca strumento avveniristico e innovativo in quanto primo campionatore in assoluto in commercio, e lo usa in tutte le sue potenzialità mettendosi alle spalle la sua comfort zone di “ex fricchettone”, vestendo i panni della anfetaminica gioventù eighties e dei suoi gusti di plastica.
Il risultato non esalterà la critica, che anzi lo massacrerà: il pubblico ancora peggio, lo ignorerà forse anche a causa di una promozione non all’altezza dovuta a dei problemi legali con la EMI. Eppure riascoltandolo ora, si sente nei brani quella tensione alla vaporwave e all’HD di oggi, una devozione all’artificiale, una genuflessione alla tecnologia che per la prima volta diventa centrale nella poetica del tastierista. Anthem come Confusion presentano una potenza d’espressione mai più ritrovata nella produzione del Wright floydiano: le critiche che vogliono il disco come una versione scrausa dei Depeche Mode che all’epoca sembravano già oltre (ma col senno di poi lo erano solo in superficie, come dimostra il loro ritorno alle chitarre elettriche), non hanno capito che il campo d’azione è principalmente il pop, visto dalle angolazioni sfasate che oggi potremmo riscontrare nei riff dei College, o nella glacialità di alcune produzioni Orange Milk, o addirittura nell’andazzo meccanico e psicofarmacologico della trap.
È anche il disco in cui l’aspetto black si fa più sentire, Harris infatti cadenza sapientemente entrando in un territorio che i Floyd sfioravano solamente, spostando la lancetta dal gospel/blues al r&b digitale che verrà. Dave Harris ricorda che Wright stava rivedendo tutte le sue certezze musicali – una delle quali, evidentissima e inaspettata, è la decisione di smettere di cantare – e insieme passavano nottate intere a programmare l’infernale macchina. Fu proprio un amico in comune a metterli in contatto, perché Richard era in cerca di qualcuno per formare una nuova band dopo il suo licenziamento dai Floyd.
In quel momento probabilmente la conclusione di quella esperienza era per Wright, finalmente, una liberazione, il suo nuovo inizio. Il remissivo che alza la testa, l’artista pieno di problemi tra matrimoni falliti, droga e depressione, che nonostante questo e anzi proprio grazie a questo finalmente dà uno slancio titanico alla sua opera. Chiudendo con il passato, sembra il protagonista di una favola a lieto fine. E invece, come da copione, sono proprio i fan a scagliarsi contro il loro beniamino. In particolare i fan dei Floyd reagiscono a Identity come i fan di Miles Davis quando il trombettista passa al periodo elettrico. L’unica differenza è che Miles se ne frega, mentre Wright comincia a pentirsi di aver fatto questo passo, considerandolo improvvisamente più lungo della gamba.
Nelle dichiarazioni successive, colpito da un luddismo di ritorno, dirà che la colpa dell’insuccesso fu l’utilizzo del Fairlight: in questo, forse per non andare contro la memoria del tastierista, gli fa coro Harris. Ma le nuove generazioni invece dimostrano di capire il disco, il quale parla la loro lingua: dal 2005, nel momento di massima diffusione dei blog musicali con abbondante divulgazione di musica elettronica, finalmente quel mitico album dalla minimale copertina sci fi che sembrava un segreto per pochi eletti diventa di tutti: con lo sviluppo delle nuove tendenze sonore che del Fairlight sono il naturale aggiornamento (vedi James ferraro e co.) si comincia a richiedere a gran voce la ristampa del disco.
E dunque, finalmente sarà possibile ascoltare nella purezza digitale allora impossibile da ottenere roba come Voices o Strange Rhytms, due esempi di come i Floyd se capitanati da Wright avrebbero potuto superare il rock “datato” di Waters e Gilmour, passando dall’alterazione di coscienza umana a quella della macchina. E ci saranno anche un paio di inediti che si annunciano succosi. Unico neo, che poi è grande come un buco nero, il fatto che il nostro Wright, scomparso nel 2008, non potrà godersi il successo di questa operazione, che forse lo avrebbe fatto ricredere sulla necessità di rifugiarsi in quella “division bell” (o meglio, quella “broken china”) dove nulla in fondo si muoveva. Un fatto è sicuro, da Ummagumma a Zee, wright è stato l’unico a vincere veramente fra i Pink Floyd proprio perché ha perso.
Come dice Fernando Pessoa nella raccolta Una sola moltitudine: “Conformarsi è sottomettersi, e vincere è conformarsi, essere vinto ( …. ) vince solo chi non riesce mai, è forte solo chi desiste sempre. La cosa migliore, la più regale, è abdicare”. Wright non è arrivato sulla luna, insomma: ma la luna è sicuramente arrivata nei solchi della sua musica.