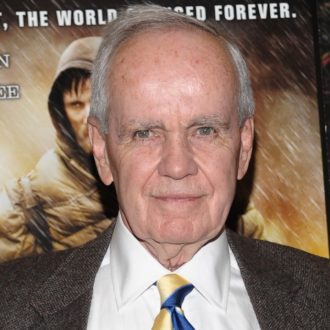Il #MeToo lesbico che non ti aspetti e che sconvolge i piani femministi. Scrivi (e guardi) TAR e leggi Leone d’Oro 2022. Siamo solo all’inizio di Venezia 79 ma l’imperioso, provocatorio, sinistro terzo lungometraggio di Todd Field (era il pianista in Eyes Wide Shut, ricordate?) è lì pronto a mostrare cosa significhi oggi autorialità in quel di Hollywood. Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, TAR (rigorosamente in maiuscolo) è incentrato sul raffinato tran tran quotidiano tra Berlino e New York di Lydia Tàr (Cate Blanchett), considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra, nonché la prima donna a dirigere la più grande orchestra sinfonica tedesca. Come viene spiegato nella lunga e posata intervista iniziale su un palco teatrale da parte del giornalista del New Yorker, Tar è professionalmente puntuale e instancabile, compresi gli Oscar, i Grammy, gli Emmy e i Tony awards vinti a poco più di cinquant’anni. Allieva risoluta di Leonard Bernstein, Tar non fa di certo la schizzinosa rispetto alle questioni di genere e di identità: preferisce senza alcuna polemica farsi definire “Maestro” senza declinare orribilmente con la A finale. “Non ho nulla di cui lamentarmi”, dice lei sul tema. E via l’elenco delle decine di donne ad altissimi piani nel mondo della musica sinfonica. Impachettate in una decina di minuti di intervista introduttiva (il film dura quasi tre ore) un po’ di nozioni sulla funzione totalizzante e cruciale del direttore d’orchestra (mano sinistra e mano destra) sul palco, Tar si congeda dall’ufficialità narrativa e l’opera di Field assume i connotati di un inquieto e insinuante thriller che all’austera dimensione pubblica della professionista mescola un persistente privato con zone d’ombra.
Nulla è mai esplicitato con didascalismo nel lavoro del regista statunitense. Certo è chiaro: Lydia che vive a Berlino con il primo violino dell’orchestra (Nina Hoss) e la loro bimba, e che lavora tra i due continenti spostandosi con un jet privato e una giovane segretaria con ambizioni al seguito, è una figura fieramente dispotica. Tutte le donne che la attorniano (di uomini in questo film ce ne sono pochini e o sono vecchi decrepiti o viscidi imitatori dal talento assente) dipendono emotivamente, sentimentalmente ed economicamente da lei. Lydia, isolata tra appartamenti berlinesi dove suonare e stanze d’albergo eleganti e prive di fronzoli, fa e disfa gerarchie orchestrali, lista dei solisti, ma anche la selezione di nuovi talenti con borse di studio. In uno di questi master iperspecializzati (“oramai non ha più senso offrirlo solo a donne”, spiega in una colazione di lavoro) alla Juilliard di New York s’impone in un quasi monologo di dieci minuti (sul piano sequenza che lo accompagna ci torniamo dopo) dove distrugge le velleità antimisogine di un giovanissimo concorrente omosessuale. Lei che è lesbica prima spiega di non considerare il lato privato di un Mahler o di un Bach prima di eseguire le loro sinfonie e poi di fronte all’indecisione del ragazzo eccola prorompere: “il narcisismo delle piccole differenze porta al più noioso dei conformismi”. Ma anche: “la tua anima l’hanno creata i social media?”. Così se l’episodio sembra delineare l’arbitrarietà incontrovertibile del “Maestro” e la sua imposizione derivante da atti maschili (guida l’auto come in Formula1, fa boxe, minaccia banalmente la compagna bulletta di scuola della figlia dicendo “io sono suo padre e se continui ti faccio del male”) ecco che iniziano a percepirsi per lei i primi scricchiolii.
Dapprima le mail segrete, mai cancellata dalla segretaria, di Krista, una musicista rifiutata sia professionalmente che sessualmente da Lydia; poi da strani suoni provenienti dalla stanza vicina al suo appartamento berlinese o urla femminili nel parco in cui fa jogging; infine dalla scomparsa di oggetti preziosi tra cui un suo spartito firmato. La situazione precipiterà quando Krista si suiciderà divulgando pubblicamente il comportamento irrispettoso e sfuggente di Lydia ben oltre il leggio. Field opta per una tesissima e rarefatta messa in scena dove vige la regola di lunghi e lenti piani sequenza in interni levigati e intonsi, dove lembi di oscurità hanno sempre mezzo grado in più rispetto alle parti di campo illuminate delle luci. A tutto ciò va aggiunto un impianto di partiture ed esecuzioni sinfoniche che paiono sfuriate e frustate per lo spettatore. Nonché la presenza mostruosa, tirannica, totale (non c’è sequenza in cui è assente) della Blanchett: tutta completi mascolini, pantaloni con la piega, camicie con polsini cadenti e giacche avvolgenti, e un marcato trucco per stressare all’inverosimile l’incipienza di rughe e stanchezza sul suo viso. TAR pone infine al centro del discorso la violenta, inequivocabile iniqua tirannia del potere, uomo o donna che sia al posto di comando. L’emozione unica derivante da un’interpretazione artistica individuale vale di più del deprecabile comportamento morale del singolo/a? In TAR ovviamente non ci sono risposte, ma “come in Bach” solo molte, insinuanti, sospese domande. Da segnalare: il film inizia al contrario con i titoli di coda.
Articolo Successivo
Venezia 79, Bardo l’ipertrofico autobiopic di Inarritu tra messicani che odiano i gringos e onirismi felliniani