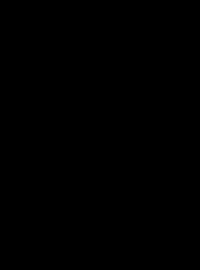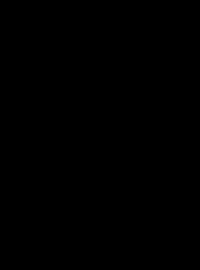1982, così dal Bernabeu l'Italia uscì dagli anni di piombo
Racconta Claudio Gentile, ex difensore della Nazionale italiana ai mondiali di Spagna82, che la notte dell’11 luglio, subito dopo aver vinto il titolo contro la Germania Ovest, Sandro Pertini fu il primo a comprendere il valore politico di ciò che era accaduto e volle sottolinearlo alla squadra nell’euforia dei festeggiamenti
di Giuseppe Lupo
6' di lettura
Racconta Claudio Gentile, ex difensore della Nazionale italiana ai mondiali di Spagna82, che la notte dell’11 luglio, subito dopo aver vinto il titolo contro la Germania Ovest, Sandro Pertini fu il primo a comprendere il valore politico di ciò che era accaduto e volle sottolinearlo alla squadra nell’euforia dei festeggiamenti. «Voi non vi rendete conto di quel che avete fatto per il vostro Paese» disse, intendendo rimarcare che non si trattava “solo” di un risultato calcistico, ma che anzi, sotto il punteggio solenne di 3 a 1, si nascondesse qualcosa di ben più sostanzioso, a conferma che lo sport, quando si professa in forma di leggenda, assume un valore antropologico e riesce perfino a cambiare il corso degli eventi. A furia di ritrasmetterla in tv, Italia-Germania dell’82 è diventata patrimonio di una memoria transgenerazionale assai più radicata dell’altra, la partita del famoso 4 a 3 di Messico70, essendo quest’ultima rimasta nell’alone di un’impresa esclusivamente calcistica, priva della forza necessaria per assurgere, come invece è accaduto per quella dell’82, a mito di un immaginario che agisce sull’intera collettività, anche in chi, non essendo ancora nato, non può avere conoscenza diretta. Un fenomeno di questo tipo è piuttosto raro, ma è proprio degli eventi di cui ciascuno, da spettatore, possiede soltanto una parzialità, la sua, che poi però, sommandosi alle parzialità degli altri, diventa casa comune, territorio dove tutti parlano all’unisono e con il medesimo linguaggio. La notte del Bernabeu possiede l’occorrente per trasformarsi in paradigma della Storia: un successo clamoroso e inaspettato, il sentimento patriottico di un riscatto, la sconfitta dei rivali di sempre, i tedeschi, su cui era facile cucire addosso il vestito del nemico proprio in virtù di un Presidente partigiano e antifascista che era lì, testimone presente, e faceva sentire la sua contagiosa partecipazione. Ma la liturgia della vittoria – Dino Zoff che innalza la coppa al cielo, poi la passa ai compagni per il giro di campo in mezzo ai flash che compaiono come lucciole tra lo svolazzo dei tricolori sugli spalti –, quell’invisibile filo rosso che, volente o nolente, riallacciava il discorso all’ultimo mondiale vinto, nel 1938, a Parigi, non avrebbero potuto assumere i contorni di quel «voi non vi rendete conto» se fosse mancato l’apporto di Pertini che rappresentava, in chiave non soltanto simbolica, l’anello di congiunzione tra il mero fatto sportivo e le traiettorie socio-economiche che la nazione stava per imboccare, anzi ne accelerò gli esiti proprio grazie a quell’affermazione. Pertini è un personaggio irrinunciabile per chi volesse tentare una qualsiasi interpretazione di quella notte e incarna le ragioni per cui ancora oggi non saremmo in grado di distinguere le chiavi di lettura, molteplici e stratificate, senza riesumare il corredo di immagini che riguardano la sua vitalità sugli spalti del Bernabeu: la pipa nella mano destra, l’irrequietezza in tribuna avendo di fianco un assai più compunto re Juan Carlos, i gesti eloquenti che suggerivano ai presenti “non ci prendono più!” quando Altobelli segnò il terzo goal. Ce li ricordiamo, quei suoi atteggiamenti, perché sono diventati passaggi iconici di una identità. E ci ricordiamo anche quelli del giorno successivo: il volo di ritorno verso Roma, la partita a carte sui tavolinetti dell’aereo, i rimproveri a Dino Zoff, colui il quale aveva innalzato la coppa con la fascia di capitano al braccio e che, a parere di Pertini, aveva compromesso la partita a scopone contro la coppia formata da Bearzot e Causio. Qualcosa di imprevedibile continuava a dettare le sequenze di un teatro laico e mitologico. L’anziano Presidente della Repubblica sembrava avesse dimenticato qualsiasi protocollo istituzionale per fare posto alla militanza del tifoso e impersonificò in maniera del tutto inedita, impetuosa e sanguigna com’era stata la sua gioventù politica, il ruolo di capo dello Stato, mostrando un modo d’essere italiani che il mondo non conosceva ancora: vincenti a dispetto di ogni pronostico, intraprendenti nel sovvertire i ruoli che gli stereotipi assegnavano, vivi dopo il tunnel del terrorismo e l’attacco allo Stato democratico. Pertini va messo in controluce con Bearzot, l’altro vecchio con la pipa, diverso per temperamento e per il modo di gestire le emozioni, ma anch’egli bravo a condurci nelle stanze di un’altra Italia. Sull’onda dell’emozione sarebbe nata non tanto e non solo la narrazione di un trionfo, ma i suoi riverberi nel tempo, una sorta di irrinunciabile epopea festosa dove non ci sarebbe mai stato spazio per i distinguo faziosi: il solito, antico tarlo che perseguita noi italiani da sempre e per il quale sono talmente rari i momenti che ci vedono tutti insieme d’accordo da suscitare meraviglia. I fotogrammi di quella notte, se anche ci impegnassimo, non riusciremmo a dimenticarli perché rappresentano il patrimonio genetico di quel che siamo diventati negli anni a seguire, come comunità di appartenenza e di destino. Certo, in quei momenti non risultava chiaro a nessuno che i giorni del Mundial avrebbero modificato il volto del Paese, ma alla luce di quel che accadde dopo sappiamo che aiutarono a farci acquisire prestigio in seno all’Europa (questo voleva intendere Pertini ripetendo «voi non vi rendete conto»), si frapposero positivamente nei rapporti con le altre nazioni e addirittura, per quanto possa apparire eccessivo pronunciarlo, cambiarono il corso della nostra Storia. Negare tale evidenza sarebbe come affermare la totale estraneità di quella partita dall’epilogo di un Novecento che si esprimeva con i linguaggi di un Occidente sempre più finanziario: spregiudicatezza, disimpegno, individualismo. Era questa l’aria che si cominciava a respirare nella porzione di mondo di cui facevamo parte e anche dentro i nostri confini, tanto nel chiuso delle mura domestiche quanto nei palazzi della politica, dalla notte dell’11 luglio si svegliò un’Italia più scanzonata, più arrembante, forse più ludica e incline al divertimento, leggera di quella leggerezza che Calvino stava per trattare nella prima delle Lezioni americane (1988, ma scritte nell’85) e che guidò le scelte generazionali di chi all’inizio degli anni Ottanta compiva i primi passi nel mondo degli adulti. Ora che di quella leggerezza è rimasta solo la celebrazione della memoria – niente più che un ricordo svaporato nei problematici decenni che seguirono fino al presente gravido di incertezze – è giusto approfittare della ricorrenza del quarantennale per fare un consuntivo, verificare fino a che punto si è spinto quel «voi non vi rendete conto» pronunciato da Pertini, misurarne il grado di penetrazione nel carattere del Paese. Osservandola bene, quella data chiuse e aprì un’epoca, fece da introduzione e congedo, perfettamente omologa con un’altra data-archetipo: il 12 dicembre 1969, giorno della strage di piazza Fontana, a Milano. Così come la bomba nella Banca Nazionale dell’Agricoltura concluse il lungo riverbero incominciato con l’irruzione dello sviluppo tecnologico in un Paese in larga parte ancora premoderno e si portò dietro conseguenze a catena (macchiò la stagione dell’incanto, accompagnò l’Italia nella spirale degli anni di piombo e del terrorismo), la vittoria contro la Germania segnò una linea di cesura con il tempo precedente e, ammesso che coincida la nozione di Novecento con quella di modernità e di ideologia, battezzò una sorta di postmoderno antelitteram. La percezione è talmente limpida da riuscire perfino a circostanziare il momento di inizio: non il goal di Pablito (che sbloccò lo zero a zero) e nemmeno quello di Altobelli (che chiuse la partita), ma quello di Marco Tardelli, il secondo, il raddoppio, un gran tiro da fuori area seguito da una testarda e strepitosa corsa a pugni stretti sul prato del Bernabeu. È in quel momento che iniziano gli anni dell’insostenibile leggerezza, come avrebbe indicato un titolo del celebre romanzo di Milan Kundera (in libreria nel 1984, ma scritto nell’82). L’urlo liberatorio di Tardelli incarnò il desiderio di un popolo che si era stancato del sangue e voleva dimenticare le stragi, la violenza, gli estremismi politici che avevano costellato, con il suo album di bare immortalate nel bianco e nero dei giornali, il passato più recente. Senza volerlo, la corsa fanciullesca del nostro calciatore fu un manifesto di discontinuità, ebbe il valore progettuale di gridare al mondo che anche in Italia, come nel resto dell’Occidente, ci si cominciava ad allontanare dalla grigia pesantezza ideologica che aveva condizionato gran parte del secolo, dando inizio a quella stagione del minimalismo, passata alla Storia con il nome di riflusso, in anticipo rispetto ai giorni in cui a Berlino sarebbe stato abbattuto il Muro. Tutto lascia intendere che nell’urlo di Tardelli si stesse congedando da noi quel Novecento che per troppo tempo avevamo subito come un fardello oppure eravamo noi, attraverso le sue gambe, a fuggire dal secolo, a volercelo lasciare alle spalle obbedendo a una regola sovrana: ora che abbiamo vinto, dobbiamo divertirci! Alla luce di quel che avvenne nella scala di immagini in bianco e in neri su cui la Storia strimpella la sua musica come sopra un immenso pianoforte, non è necessario derubricare sotto forma di risorsa insperata o di occasione mancata gli anni della Milano da bere, dei paninari e degli yuppies, dell’edonismo reganiano – ennesime etichette con cui fu incasellato il decennio che dal Mundial portò alle inchieste di Mani pulite –, però è sicuro che anche il tempo successivo ha assunto valore di metafora. Attribuire all’esultanza di un goal i crismi di un orientamento storico-antropologico può sembrare una forzatura interpretativa. Ma è chiaro che ogni nazione cerca le sue effigi per raccontarsi, volti e gesti a cui attribuire precisi significati. Soprattutto cerca la via meno scontata e banale per consegnarsi alla Storia senza attendere il suo giudizio o subirne l’autorità, in nome di una non meno identificata sfida tra esistenze individuali e coscienza nazionale.