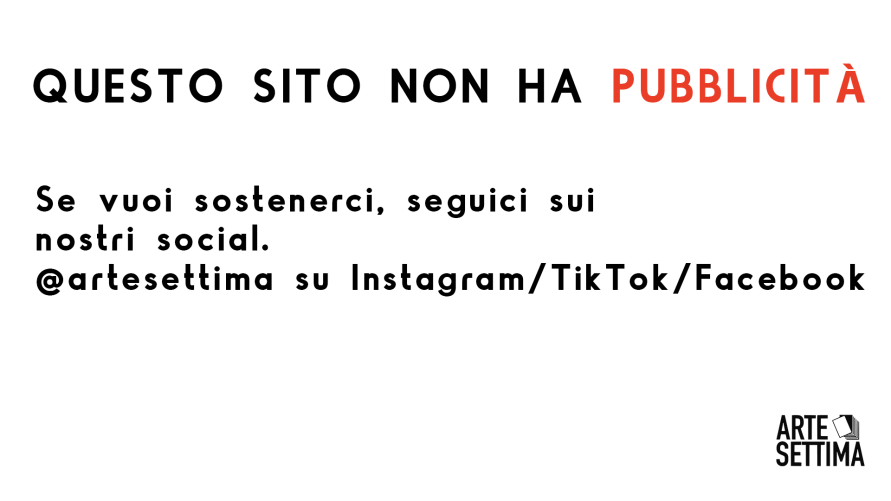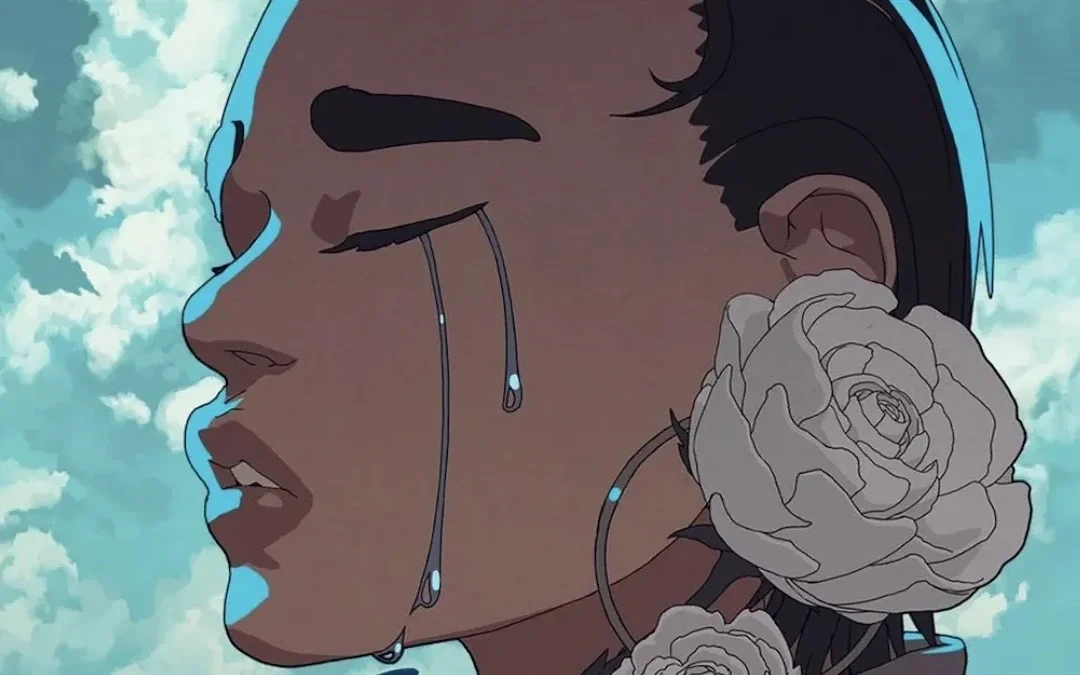Quando Pier Paolo Pasolini diresse Uccellacci e uccellini, nel 1966 aveva alle spalle alcune opere già note nel panorama cinematografico italiano, ma soprattutto una prospettiva di fondo entro cui strutturare la sua produttività. L’autore, infatti, chiuse con La ricotta quella fase epico-lirica del poema popolare aperta con Accattone col quale l’autore aveva iniziato a percorrere quella linea nazional-popolare molto vicine alle idee di Antonio Gramsci.
Il processo che ha portato Pasolini a maturare le riflessioni presenti in Uccellacci e uccellini, passa, tuttavia, dai Il Vangelo secondo Matteo. Qui notiamo un momento in cui il filone ideologico pasoliniano non rientrava in una fedeltà storica e filologica, mendiante un metodo che procedesse per ricostruzione (esempio, il mondo ebraico). Osserviamo un cambio di prospettiva più sostitutiva: il mondo ebraico di duemila anni fa diventava l’Italia meridionale degli anni ’60 con la sua vita arcaica, pastorale, pre-industriale, preistorica.
Il Vangelo secondo Matteo è solo esternamente un film che ha una fisionomia tipica di un’opera cattolica, dal momento che in realtà non è un lavoro di un cattolico praticante. La stessa figura di Cristo scelta da Pasolini non ha dei lineamente moribidi o uno sguardo dolce, come nell’iconografia ufficiale. Il suo è un Gesù ambiguo e sconcertante, il cui volto esprime forza e decisione.

Pier Paolo Pasolini sul set di Il Vangelo secondo Matteo
Ciò che è evidente è che il Vangelo secondo Matteo costituisce un elemento che di fatto attraversa tutta la storia di Pasolini: ovvero, una adesione realistica all’oggetto in questione. E, allo stesso tempo, pone un problema religioso che non è privato, bensì oggettivizzato nella fede, nel mito. A ben vedere, è lo stesso procedimento (o rovesciamento) tenuto presente dallo scrittore nel costruire le storie dei romanzi coi parlanti romani o friulani.
Il Vangelo secondo Matteo può essere collocato, col suo fondo favoloso e col suo racconto ideologico, nella linea nazional-popolare gramsciana. E la scelta della sostituzione, poc’anzi accennata, è il segno clamoroso e appariscente del realismo del film. Con ciò è possibile intendere l’opera come documento immediato e riconoscibile, quanto mai necessario, utile a riportare tutto il mondo antico e passato alle esperienze contemporanee.
È mendiante il realismo che il regista cerca di demistificare ogni situazione storica. È sempre con realismo che l’autore cerca di piegare, in un processo razionale, la conoscenza irrazionale, che nel caso del film è la morte. E non riuscendovi, Pasolini sfrutta al meglio un mezzo principale che reputa idoneo sebbene la sua prospettiva personale risulti lontana: la religione.
Tutte queste posizioni e scelte ideologiche, come lo spiegare l’irrazionale mediante il razionale, si concludono proprio con Uccellacci e uccellini. L’irrazionale, in questo caso, diviene proprio l’ideologia, la quale deve fare i conti con un realismo esasperante, ai limiti quasi del cinismo che investe l’intera vicenda.

Uccellacci e uccellini
Il film è una favola allegorica, interpretata da Totò e Ninetto Davoli. I due vestono i panni di un padre e di un figlio che vagano per le periferie e le campagne circostanti di Roma. Tuttavia, durante il loro cammino si imbattono in un corvo. Questo decide di scortarli per tutto il tragitto, decidendo di narrare una storia: quella di Ciccillo e Ninetto. Entrambi sono due frati che hanno il compito di evangelizzare i falchi e i passeri, e per quanto il loro tentativo vada a buon esito, non riusciranno a mettere fine alla loro rivalità.
Il resto del film si svolge mediante una serie di visioni, medianti i quali i protagonisti incontrano diversi individui: alcuni proprietari terrieri che ordinano ai due di allontanarsi dalla loro proprietà; una famiglia che vive in una condizione degradata; un gruppo di attori d’itineranti di “spettacoli volanti”; i partecipanti al primo convengno dei dantisti dentisti. In tutto questo, il corvo li parla in tono intellettualistico e altisonante, finché, a conclusione del film, Totò e Ninetto, stanchi delle sue chiacchiere saccenti e moraliste, lo uccidono e lo mangiano.
In Uccellacci e uccellini subentra un discorso che ruota attorno al Potere, il quale assume una chiara connotazione sia nella simbologia dei falchi che uccidono i passeri, sia nei due protagonisti, il padre Totò e il figlio Ninetto, che ammazzano il corvo e lo mangiano. E vige, pertanto, una duplicità di fondo: da un lato il Potere è investito del suo cinismo che si riversa nella classe più povera; dall’altro lato il Potere uccide l’ideologia (il corvo, appunto) e lo mangia (l’ideologia diventa praxis).

Totò e Ninetto Davoli
Pasolini stesso ha sempre affermato che la figura del corvo ha attraversato diverse fasi:
«Prima si trattava di uno spirito saggio, un sapiente, in fondo un semplice moralista […]. Poi da moralista è passato a filosofo. A questo punto è intervenuta l’idea di fare del racconto un film. Il filosofo ha dovuto quindi precisarsi».
(pier Paolo Pasolini)
Questo corvo-filosofo è stato in un primo momento concepito come un saggio reale alla ricerca, mediante la sua libertà scandalosa e anarchica, di una realtà non sistematica delle cose ma assoluta ed empirica. Una specie di saggio e poeta che non aveva nulla da perdere, un Socrate sublime e ridicolo, che poi sarebbe stata l’immagine stessa di Pasolini.
Totò e Ninetto proseguono per le loro strade, con perfetta innocenza, col loro candido cinismo, col loro agire secondo un’intima verità. Lo scopo del corvo è quello di insegnare loro a essere quello che i due protagonisti sono per definizione. E nella concenzione originale del film, stando a quanto afferma lo stesso Pasolini, il corvo non sarebbe stato mangiato, quindi assimilato.
Se pensiamo a quella specie di angelo-messaggero che incontriamo in Teorema, possiamo supporre che forse il regista aveva in mente un altro corvo che giungesse a dare coscienza delle cose. Il corvo doveva apparire ideologicamente ben definito nel tempo e nella storia. Pertanto, divenendo metafora irrazionale dell’autore, ovvero ideologia, diventa a sua volta autobiografico per vestire i panni del realismo tanto ambito.

Il corvo
Solo così Pasolini poteva dar voce al duplice marxismo che avvertiva sulla propria identità. Un marxismo innestato come una norma innocente, paligenesi non tuttavia matta ma ragionata, su una incrinatura della norma, sul trauma. E un marxismo aperto a tutti i possibili sincretismi, contaminazioni e regressi, restando fermo sui suoi punti più saldi, di diagnosi e di prospettiva.
Per questo, alla fine, prevale la contraddizione tra passione e ideologia. E per tale motivo, il corvo viene, a conclusione della pellicola, divorato: sia perché aveva concluso il suo mandato, sia perché gli uccisori assimilano la parte utile della sua linfa vitale. Importante appare, allora, per chiarire l’idea di Pasolini, la frase di Mao che lo scrittore ha apposta come epigrafe al racconto del corvo:
«Dove vanno gli uomini? Saranno nel futuro comunisti o no? Mah! Probabilmente non saranno né comunisti Né non comunisti… Essi andranno, andranno avanti, nel loro immenso futuro prendendo dall’ideologia comunista quel tanto che può essere loro utile, nell’immensa complessità e confusione del loro andare avanti».
(Il corvo – Uccellacci e uccellini).
Uccellacci e uccellini
Se abbiamo presente il continuo camminare camminare (quasi fosse una favola) di Totò e Ninetto, e se si nota la simbolica segnaletica stradale che appare nel film sul loro itinerario senza meta, non possiamo non pensare a quei due cartelli (verso Istanbul il primo a 4253 Km, verso Cuba il secondo a 13.257 Km) come un’indicazione di fuga liberatoria dall’Occidente e dalla sua ideologia.
A questo punto è impossibile non identificare il corvo con l’ideologia marxista in un momento storico (gli anni ’50) in cui stava per essere superata. Pasolini stesso ha affermato:
«Dovevo precisare questo punto nella contraddizione, se il marxismo del corvo coincide col mio marxismo, poiché io sono in evoluzione, e sono cosciente prima di ogni altra cosa della crisi del marxismo degli anni cinquanta, egli non può avere una storia conclusa, non può essere così chiaramente superato e quindi mangiato. Se invece il marxismo del corvo non coincide con il mio, allora il corvo diventa un personaggio del tutto oggettivo, che dice cose che io non condivido più. È un personaggio noioso e antipatico».
(Pier Paolo Pasolini)
L’essere mangiato, quindi, ispira alla fine due sentimenti equivalenti: il senso piacevole di liberazione della sua ossessione ideologica che vuol spiegare tutto e sempre, e la compassione per la sua brutta fine.
È il superamente di un’ideologia marxista e il tentativo di Pasolini di cercare in Freud ciò che Marx non era riuscito a spiegare.
Leggi anche: Salò o le 120 giornate di Sodoma – Cinque chiavi di lettura