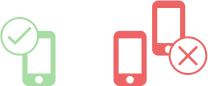Sean Penn: «Io non lascio mai, vengo lasciato e ho imparato ad ammettere gli sbagli. Chavez ed El Chapo? Non chiedo scusa»
«Ci ho messo tanto prima di iniziare a riconoscere gli errori. Nelle relazioni sentimentali è utile, ti aiuta a non ripeterli». Il regista si racconta a pochi giorni dall'uscita nelle sale americane del film "Asphalt City". «La parola "vincere" non ha molto senso durante una guerra quando ci sono così tanti morti e distruzione»
Incontriamo Sean Penn al quinto piano di un hotel di Cannes durante lo scorso Festival. Indossa jeans e una t-shirt aderente, ha un fisico che non si arrende al tempo, né ai tempi che stiamo vivendo. I bicipiti si animano quando muove le mani, anche di poco, per far roteare tra le dita il pacchetto di sigarette, che non fumerà, non durante l'intervista almeno. Alle nostre spalle, fuori dalla camera, le guardie del corpo. Davanti a noi, alle spalle di Penn, le finestre incorniciano un mare nuvoloso, azzurro-grigio come gli occhi dell'attore. Brillano sul volto abbronzato, sotto una fronte segnata da rughe profonde, alcune tirate su dagli angoli dell'arco sopraccigliare, altri ai lati degli occhi. Come se ridesse spesso con amarezza. Quando ascolta, fissa l'interlocutore negli occhi. Quando parla, ha lo sguardo fuori fuoco, a cercare le parole, che escono dalla bocca con lentezza, come digrignate dai molari in fondo. Sembra tutto sotto controllo, tranne la gamba, che ha spesso un lieve dondolìo che a volte fa tintinnare gli oggetti sul tavolino di cristallo. Tra cui le bottigliette di superalcolici da minibar, chiuse.
L'occasione dell'incontro è il film in cui è tornato a recitare, dopo anni in cui è per lo più dietro la macchina da presa. Si chiama Asphalt City, esce ora negli Stati Uniti e in Italia in autunno (distribuito da Vertice 360), e racconta la vita di due paramedici a bordo di un'ambulanza, che prestano servizio notturno nei bassifondi di New York. Penn veste i panni di un veterano di lungo corso, con la vita familiare andata in frantumi e una tendenza all'iperattivismo nichilista, che svernicia l'idealismo del giovane collega, studente di Medicina, interpretato da Tye Sheridan, attratto, disgustato e a suo modo ispirato dal vecchio collega.
Il film mette in scena il collasso del sistema sanitario pubblico, dove la scelta tra la vita e la morte è quotidiana, spietata e crudele, tra costi e benefici che sfiorano l'omissione di soccorso, mentre il delirio di onnipotenza è figlio della paura di non poter fare la differenza. Le luci e le ombre si sovrascrivono, senza mescolarsi, luci al neon e asfalto umido, sirene intermittenti e mosche nere, come nel titolo del libro da cui è tratto il film, Black flies.
Perché ha scelto di tornare alla recitazione con questo film molto cupo?
«Stavo girando Il tuo ultimo sguardo, nel 2016, in Sudafrica, sulla guerra civile liberiana, e Adèle Exarchopoulos, che è nel film, mi parlava di Johnny Mad Dog di Jean-Stéphane Sauvaire. "Devi vederlo L'INCONTRO assolutamente". Aveva ragione, mi ha colpito come un pugno, avevo voglia di mettermi al lavoro con lui. Tra l'altro mi aveva pure scritto anni fa, quando ero in giuria, per lavorare assieme, ma avevo perso il messaggio, e comunque non era il momento. Io non funziono bene se non sono completamente coinvolto. Il film è molto cupo e io venivo da un momento della mia vita in cui avevo bisogno di ricaricarmi. In quel momento, non ero carico. Lui insisteva, io gli dicevo di no, in ogni modo, anche così: "Va bene, lavorerò con te, ma quello che a un certo punto succede al personaggio va fatto subito e con una vera pistola carica". Volevo lavorare con lui, ma non potevo. Poi è passato altro tempo, mi sono ricaricato, abbiamo iniziato a girare».

Asphalt City
Il nuovo film con Sean Penn esce ora negli Usa e in Italia ad autunno, distribuito da Vertice 360
Perché aveva smesso di recitare?
«Erano 15 anni che non mi godevo la recitazione. Da Milk di Gus Van Sant, l'ultimo film che ho apprezzato. Anche se mi arrivavano buone proposte, recitando mi sentivo molto infelice. Così mi sono fermato. Poi ho accettato due progetti. Asphalt City, e un film con Dakota Johnson, Daddio, di Christy Hall, scritto con cura su tutto ciò che ci preoccupa oggi riguardo alla politica della sessualità. Uomo anziano, donna più giovane, sono estranei, lui è un tassista, la prende sul taxi, il film è il loro tragitto in taxi. Sul set c'erano quasi solo donne, era scritto e diretto da una donna e questo mi ha permesso di esplorare angoli a cui non mi sarei mai avvicinato se fosse stato diretto da un uomo. Non dovrebbe essere così, perché tutti dovrebbero poter dirigere qualsiasi cosa, ma Christy mi ha dato le parole per esprimere ciò che ci è vietato dire in questi giorni e mi ha permesso di contro-argomentare i suoi ragionamenti. Abbiamo avuto conversazioni per accertarci che, nonostante partissimo da posizioni molto diverse, alla fine eravamo d'accordo e ci riferivamo alla stessa cosa. Con Daddio ho avuto la migliore esperienza che abbia mai avuto recitando (sorride, ndr ), neanche da giovane mi sono divertito tanto. Forse perché poco prima ho recitato in Asphalt City, che sulla carta è il massimo: Jean-Stéphane Sauvaire alla regia, c'è Tye Sheridan, David Ungaro alla fotografia... ma ero sotto pressione, mi preoccupavo per Jean-Stéphane, aveva un'ambizione molto alta, come era giusto». Qual è l'elemento più importante in una storia? «Da artista dovrei manifestare una consapevolezza che preferisco non dichiarare, quindi parlo da spettatore. Il pubblico non sa mai quando gli si sta mentendo, ma è perfettamente consapevole di quando gli si sta raccontando la verità. Cito E.L. Doctorow: "La responsabilità dell'autore è di comprendere i tempi in cui vive". Se c'è questa forza motrice nell'arte, non importa di cosa si tratti, né in che epoca esatta si svolga, non deve essere lo stesso. Non mi interessa se la storia viene cambiata o se Napoleone cambia idea su qualcosa... Sono interessato a qualsiasi cosa, almeno nel suo nucleo, che dia qualcosa su cui poter lavorare in questo senso. Qualcosa di vero per il tempo in cui si vive».
Ci è sempre riuscito?
«A volte sento di esserci riuscito. Altre di aver fallito. Oggi è difficile realizzare un film per come l'hai pensato, i finanziamenti, il cast... Ma non voglio cadere, come pure ho fatto, nella cultura del lamento, come quelli che picchiano il pugno sul tavolo, bevono vodka e dicono che il cinema è morto, che è tutto finito. I registi che lo fanno dovrebbero vergognarsi, di fronte a film così freschi e nuovi di come Asphalt City di Stephen, che ha questa immunità creativa, come se non si confrontasse con le sciocchezze, non si auto-censurasse... Più ci si allontana dalla cultura del lamento più hai energia per sognare e creare cose originali».
Oggi c'è una grande offerta con lo streaming...
«Sono riluttante, la ragazza di cui mi sono innamorato anni fa è lo schermo del cinema, amo l'esperienza condivisa con gli sconosciuti di guardare un film, che quando finisce non sei più uno sconosciuto con il resto del pubblico, come un viaggio in taxi, alla fine del quale non si è più due sconosciuti, e si sta bene anche senza parlare. Non posso lasciare quella ragazza, è mia moglie, di cui sono innamorato. E beh, non intendo la moglie vera. Io non ho mai lasciato, mi è successo l'opposto, mi han lasciato, io non lascio, certo, sono una persona con cui è impossibile vivere... ma è un'altra storia».
Il suo personaggio di Asphalt City è duro con sé stesso, ammette i propri errori. Pure lei fa così?
«So già a cosa lei sta pensando. Penso si riferisca a due errori in particolare. Uno è politico, l'altro personale e riguarda famiglia, mogli, amanti ... Diciamo che sono diventato bravo nelle relazioni, ma ci ho messo molto tempo per iniziare ad ammettere i miei errori, e alla fine questo mi ha anche portato a commetterne di meno. Se rimani saldo nelle tue convinzioni, finisci per essere più cauto e per scusarti meno. Poi, ci sono un paio di punti critici nel mio passato da giornalista e attivista politico globale...»
Hugo Chávez?
«Era mio amico, gli volevo bene. Quando ha preso il potere, l'80% del suo Paese non aveva un'identità, accesso alle cure mediche o all'istruzione, né un lavoro. E lui ha cambiato le cose. E io l'ho visto. Non perché mi dicessero cosa vedere, ma perché ho trascorso molto tempo lì. E il Paese lo amava... Quindi ho scritto e detto alcune cose a suo favore. E poi, sa, alcuni leader dovrebbero governare come fanno i marines. Sono i primi ad arrivare, fermano l'emorragia e si allontanano. Io sono un fervente sostenitore delle istituzioni, sono molto grato per l'esistenza della CIA, ma in Sudamerica sono state fatte cose tremendamente sbagliate, come in Cile, e c'è una ragione per essere paranoici. Così, se gli Usa ti stanno puntando, in ogni parte del mondo un leader sceglierà persone in cui ha fiducia anche se non sono le migliori, i più competenti, per i lavori da svolgere e per le istituzioni».

Sean Penn con il presidente del Venezuela Hugo Chávez a Caracas nel 2007
E poi cosa è successo?
«Poi lui ha fatto il referendum (per abolire il limite costituzionale al numero di mandati, ndr) e gli dissi che non avrei scritto più su di lui. Oggi penso che quello è stato un grosso errore. Ma Chávez è una persona denigrata, in modo sbagliato. Diciamo che non devi essere una persona terribile per essere come Nicolás Maduro, basta essere un pessimo manager senza carisma. Ecco il Venezuela oggi. Ma non ho da chiedere scusa al riguardo».
L'hanno criticata anche per l'intervista a Joaquín Guzmán Loera, il narcotrafficante...
«Sì, mi hanno accusato di aver celebrato El Chapo, ma non l'ho mai fatto, semplicemente alcuni hanno deciso di attaccarmi dicendolo. Mio cugino è nella DEA, l'anti-narcotici, e non celebrerò mai qualcuno che fa a pezzi neonati con una motosega. L'intervista è stato un grosso malinteso. Ciò di cui veramente mi pento, ora, è di non essere sul fronte ucraino, ad aiutare».
Lei si trovava in Ucraina prima dell'invasione russa, per girare Superpower , un documentario su Zelensky, da ex comico a politico. Poi gli eventi l'hanno trasformato in un leader militare. Ho letto che ha dato uno dei suoi Oscar a Volodymyr Zelensky. Quale?
«Quello di Mystic River, perché quello di Milk è rotto e non volevo dargli uno rotto.» Ha anche detto che lo riprenderà solo se l'Ucraina dovesse vince la guerra. Ci crede? «"Vincere" non ha molto senso quando così tante persone muoiono: con tanta distruzione, nessuno vince davvero. Ma credo, con tutto me stesso, che l'Ucraina può dominare questo conflitto militare. Con il giusto supporto, avrebbero potuto farlo già, e Putin sarebbe già politicamente fregato, e potrebbe succedere ancora. Nel peggiore dei casi, lui mantiene la Crimea, va in profondità, continua a bombardare parti di Kiev e altri luoghi, distruggendo le rotte navali. Può continuare per anni. Ma alla fine, con o senza il nostro aiuto, gli ucraini domineranno. Ora non so come stia andando».

L’attore Sean Penn, a sinistra, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev, novembre 2022
Lei è per i diritti gay, era contro la guerra in Iraq, aiuta nei Paesi funestati da catastrofi naturali... Qual è la filosofia del suo attivismo?
«Mi concentro su questioni che non hanno abbastanza visibilità. E io voglio attrarre l'attenzione per sensibilizzare persone come me, o persone che non possono permettersi di viaggiare dove io vado, perché possano avere le informazioni che non hanno, di contesti che non conoscono».
In Asphalt City c'è dolore, disperazione, ma pure resistenza e persino redenzione. In uno stesso giro, si perde una persona cara e se ne salva un'altra. C'è un lutto che ricorda con forza nella sua vita? E un momento di redenzione?
«Sul lutto non posso rispondere, è qualcosa che mi ha sopraffatto. Posso parlare di un momento di miseria e disperazione, e forse di redenzione. Ad Haiti, tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011. Dopo il terremoto, ero tra i volontari. Io e un mio amico di scuola lavoravano in un ospedale provvisorio e avevamo donato un'ambulanza. Se il nostro centro era troppo pieno, trasferivamo i pazienti altrove. La nostra base era vicino all'ospedale da campo, e a un campo profughi. Avevo imparato che, nonostante i progressi nel trattamento delle malattie infettive, la chiave è una buona comunicazione con i medici locali. Portavo sempre con me una radio. Un giorno, ricevetti una chiamata da una dottoressa americana dell'ospedale da campo. Era sotto choc. Mi chiese se fossi vaccinato contro la difterite, e di seguirla. Pensava che un ragazzo di 14 anni appena ricoverato avesse la difterite. I sintomi erano simili a quelli dell'influenza, ma la lingua era grigia, segno di difterite. I medici locali insistevano sul fatto che non poteva essere difterite».
Perché?
«Non c'era stato un caso dichiarato di difterite ad Haiti da 30 anni. C'era appena stato un terremoto, non potevano affrontare anche il primo caso di difterite. Il destino non può colpirti così! Decisi di credere alla dottoressa americana, così io e un volontario haitiano trascorremmo la giornata girando per gli ospedali dell'isola, con la sirena, nel traffico, cercando un posto dove curare il ragazzo. C'erano tre ospedali che potevano accogliere pazienti con malattie infettive, ma niente, dicevano che non poteva essere difterite. Un'odissea di undici ore, il ragazzo stava peggiorando. Gli parlavamo, ma rispondeva sempre meno. Alla fine, una dottoressa che aveva trasformato la sua clinica di chirurgia plastica in ospedale aperto a tutti ci accettò».
Lì fu curato?
«Lì era meglio che in un'ambulanza in mezzo alla strada. Poi trovammo un'altra clinica, dove l'hanno idratato, ma serviva immunoglobina, iniziammo a cercarla telefonando a tutti: la Croce Rossa haitiana, americana, l'esercito americano, i centri anti-infettivi, l'OMS... Nessuno. Nessuno sapeva dove trovarla. Anche perché era il fine settimana. Per fortuna, uno dei nostri volontari, a cena riconobbe qualcuno del centro anti-infezione che ci indicò un ospedale a venticinque minuti da Portau-Prince che si occupava di malattie infettive. Lì avevano il vaccino. A quell'ora, il padre del ragazzo ci aveva già raggiunto ed era con noi nella clinica. Quindi, nonostante le molte esitazioni del padre, ci affrettammo a far salire il ragazzo sull'ambulanza e partimmo. Io ero dietro con loro due, padre e figlio, e dissi al padre: "Resterà vivo"».
Cosa le dava questa sicurezza?
«Il ragazzo era al limite, ma avevamo il vaccino. Arrivammo in ospedale, glielo iniettarono, festeggiammo come pazzi. Va bene, non era tornato in sé, ma si sarebbe ripreso. Tornammo al campo e stavamo bevendo punch al rum e, beh, fino alla mattina seguente non ricevemmo la notizia che il ragazzo era morto durante la notte».
A volte, nella vita c'è l'happy end.
«Sì, ma avrei dovuto aspettare prima di promettere qualcosa a qualcuno. Non vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso».