
La Russia zarista: il regno di Alessandro III (1881-1894)
Nel 1881, a seguito dell’assassinio del padre, divenne zar Alessandro III. Fin da subito egli attuò una politica repressiva nei confronti dei movimenti rivoluzionari per salvaguardare la legittimità dell’impero, inoltre rese chiaro il suo intento di mantenere l'autocrazia zarista. Per raggiungere tali obiettivi introdusse alcune modifiche al sistema di governo:- nacquero i “regolamenti temporanei”, che, conferendo ai funzionari di certe regioni ampia autorità, avevano l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico;
- inaugurò una legislazione del lavoro (limitazioni della giornata lavorativa, divieto al lavoro notturno per donne e bambini, norme per regolare il pagamento, nomina di ispettori di fabbrica che controllassero l’applicazione delle nuove norme);
- sostenne la nobiltà, ampliandone i privilegi e accentuandone la posizione di predominio;
- cercò di garantire la supremazia della Chiesa Ortodossa, alla quale affidò quanto più possibile l’istruzione primaria;
- aumentarono la repressione nei confronti delle religioni non ortodosse (cattolici, protestanti e soprattutto ebrei, vittime dei Pogrom per tutto il decennio successivo);
- abolì l’autonomia universitaria, vietando agli studenti la possibilità di fondare organizzazioni e rappresentanze collettive che potessero rappresentare un potenziale pericolo per la stabilità dello Stato;
- la lingua, la cultura e la religione russe furono imposte ai popoli di tutto l'impero ("russificazione"). Ciò fu una risposta al crescente sentimento nazionale avvertito da diverse etnie dell’impero (polacchi, armeni, ucraini, finlandesi, etc…) e all’accesso nazionalismo dei russi.
Nell'ottica di un iniziale bisogno di quiete per il suo Paese nel 1884, dopo vari indugi, Alessandro firmò l'alleanza dei tre imperatori. L'accordo difensivo fu stipulato con Francesco Giuseppe d'Austria e Guglielmo I di Germania e stabiliva che nel caso una delle potenze firmatarie si fosse trovata in stato di guerra con un'altra potenza, le altre due si sarebbero astenute dall'attaccarla, mantenendo una neutralità benevola. Sebbene nazionalista e panslavista, lo Zar decise di firmare l'alleanza mettendo da parte la sua diffidenza per la Germania.
Tuttavia tale alleanza non durò a lungo e nel 1887 la Russia si trovò in uno stato di isolamento, dovuto anche alle tensioni con la Gran Bretagna nate dall’espansione Russa verso est (Pamir, India). Alessandro III fu spinto a cercare un accordo con la Francia, siglato nel 1894: se la Francia fosse stata aggredita dalla Germania o dall’Italia, la Russia sarebbe intervenuta in sua difesa e viceversa.
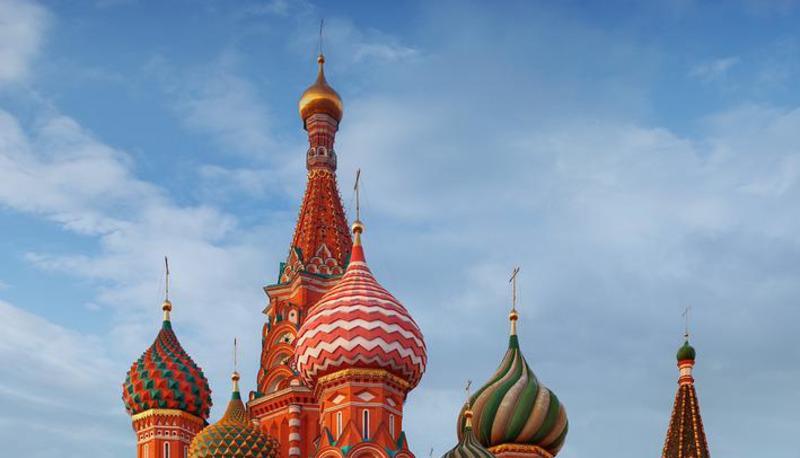
Morte di Alessandro III e i primi anni del regno di Nicola II
Alessandro III morì a soli 49 anni per una nefrite; a succedergli fu il figlio maggiore Nicola, da poco fidanzato con Alice D’Assia, nipote della regina Vittoria d’Inghilterra.Reazionario come il padre dal punto di vista della politica interna, anche sul fronte estero fu inizialmente propenso a seguire le orme di Alessandro III e appoggiare l’accordo con la Francia. Con la fine della costruzione della linea ferroviaria Transiberiana (1891-1903), gli interessi della Russia in Oriente aumentarono, soprattutto verso la Manciuria e la Corea, favorendo così una politica estera più aggressiva. La Cina cedette alla Russia la penisola di Liaotung con Porth Arthur. Questa mossa preoccupò la Gran Bretagna e il Giappone, che si allearono, dando così inizio alla guerra russo-giapponese del 1904-1905. Dopo una dura sconfitta russa ad opera della flotta navale giapponese, il conflitto si concluse con un accordo di pace che costringeva la Russia a riconoscere la supremazia giapponese sulla Corea e che riconsegnava la Manciuria alla Cina. L’insoddisfazione data dalla guerra, legata all’irrequietudine operaia per le condizioni lavorative, confluirono in una rivoluzione anti-zarista nel 1905.
Il 22 gennaio del 1905 (conosciuta poi come domenica di sangue) la polizia di Mosca spara contro una grande folla di lavoratori che stavano dimostrando per implorare l’aiuto dello zar; l’episodio rivelò l’incompetenza delle autorità e provocò indignazione, dando un nuovo slancio al movimento rivoluzionario. Di fronte alle crescenti tensioni, Nicola II dichiarò la volontà di convocare un’assemblea consultiva e proclamò la tolleranza religiosa, ma ciò non soddisfò l’opinione pubblica colta né le masse e ciò fece accrescere le manifestazioni di opposizione che culminarono in uno sciopero generale, durante il quale i lavoratori di Pietroburgo organizzarono un soviet (consiglio). Il 30 ottobre 1905 lo zar è costretto a concedere il cosiddetto Manifesto d'ottobre, un documento che garantiva libertà civili ai russi, annunciava la costituzione di una Duma (parlamento elettivo a suffragio universale) dotata di funzione legislativa e prometteva un’espansione del nuovo ordine a tutta la Russia; nel 1906 l’autarchia dei Romanov diventava una monarchia costituzionale e viene confermata la concessione della Duma eletta a suffragio universale ed è istituita formalmente la figura di Primo Ministro.
Ben presto però, essendo la Duma in completo disaccordo con lo zar, questi cambia la legge elettorale concedendo il diritto di voto alle sole classi più abbienti. La Duma viene sciolta per ben due volte poiché la maggioranza elette non è gradita allo zar. Nel 1907 Nicola II cambiò arbitrariamente la legge elettorale, invocando il suo potere storico (il diritto di abrogare ciò che aveva concesso) e la sua intenzione di rispondere dei destini del Paese solo davanti a Dio da cui gli veniva l’autorità; l’obiettivo era creare una Duma che potesse collaborale con il governo, cosa che avvenne con la terza elezione, dove la rappresentanza dei contadini e degli operai venne dimezzata, la rappresentatività della nobiltà era sproporzionata rispetto alla quantità di nobili russi, Polonia, Caucaso e regioni di frontiera persero un numero elevato di deputati e la procedura elettorale divenne indiretta. Tutti questi cambiamenti fecero sì che venne eletta una maggioranza conservatrice, in linea con le intenzioni dello zar.
Intanto il governo attuò una riforma agraria: vennero aboliti i mir, cioè le assemblee dei capifamiglia dei villaggi, che avevano il compito di amministrare le terre date ai contadini dopo che era stata abolita la servitù della gleba; viene varato anche un piano di sostegno per le famiglie contadine per favorire l’acquisto di nuove terre e per facilitare, soprattutto, la formazione di uno strato di medi proprietari. Questa riforma agraria ebbe fine nel 1911, quando il suo ideatore venne assassinato. Nicola II, incapace di seguire la strada del cambiamento, rimase fermo nella sua convinzione del proprio diritto divino al trono, trascurando la gravità della crisi che si stava aprendo dinnanzi a lui.
