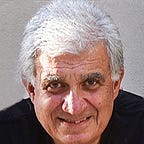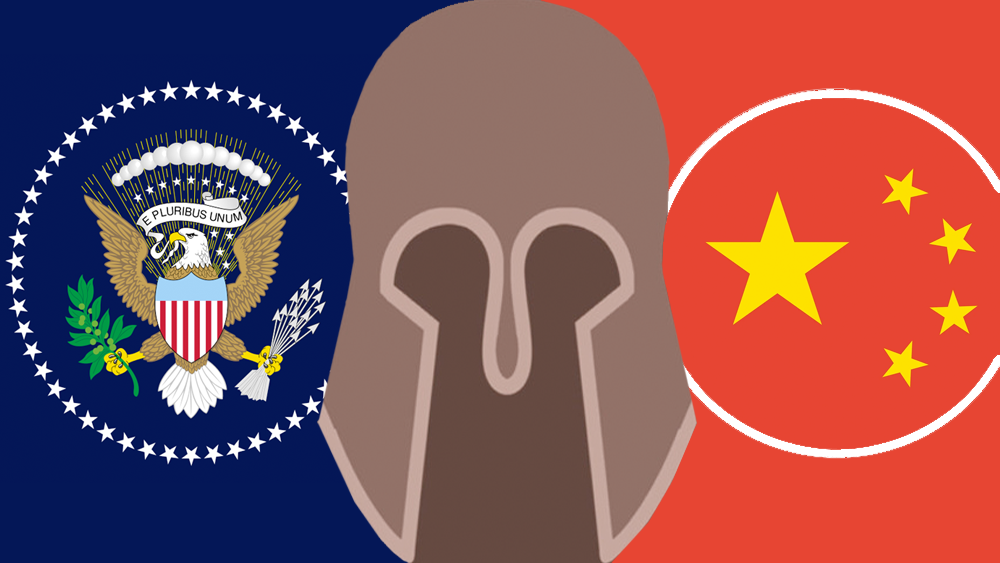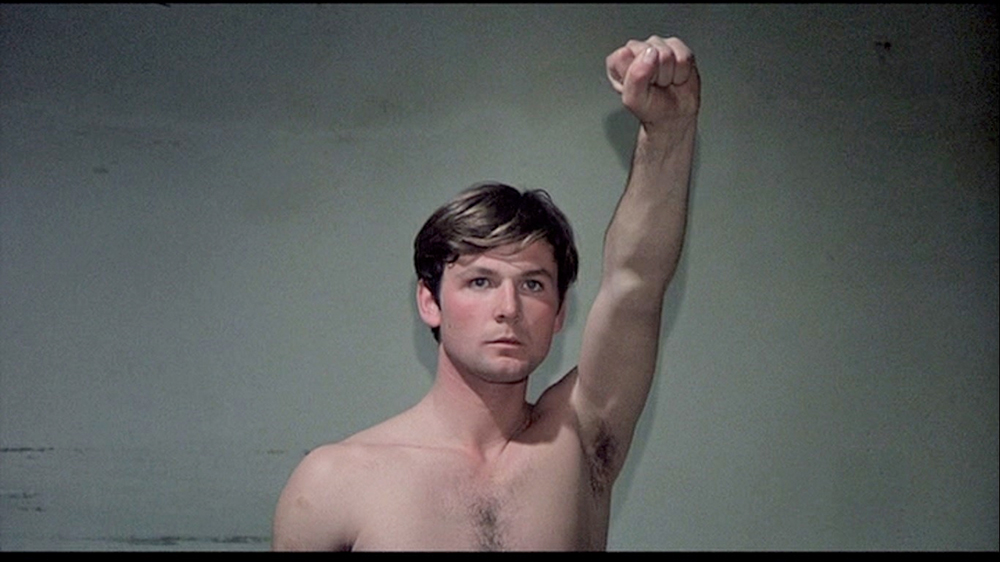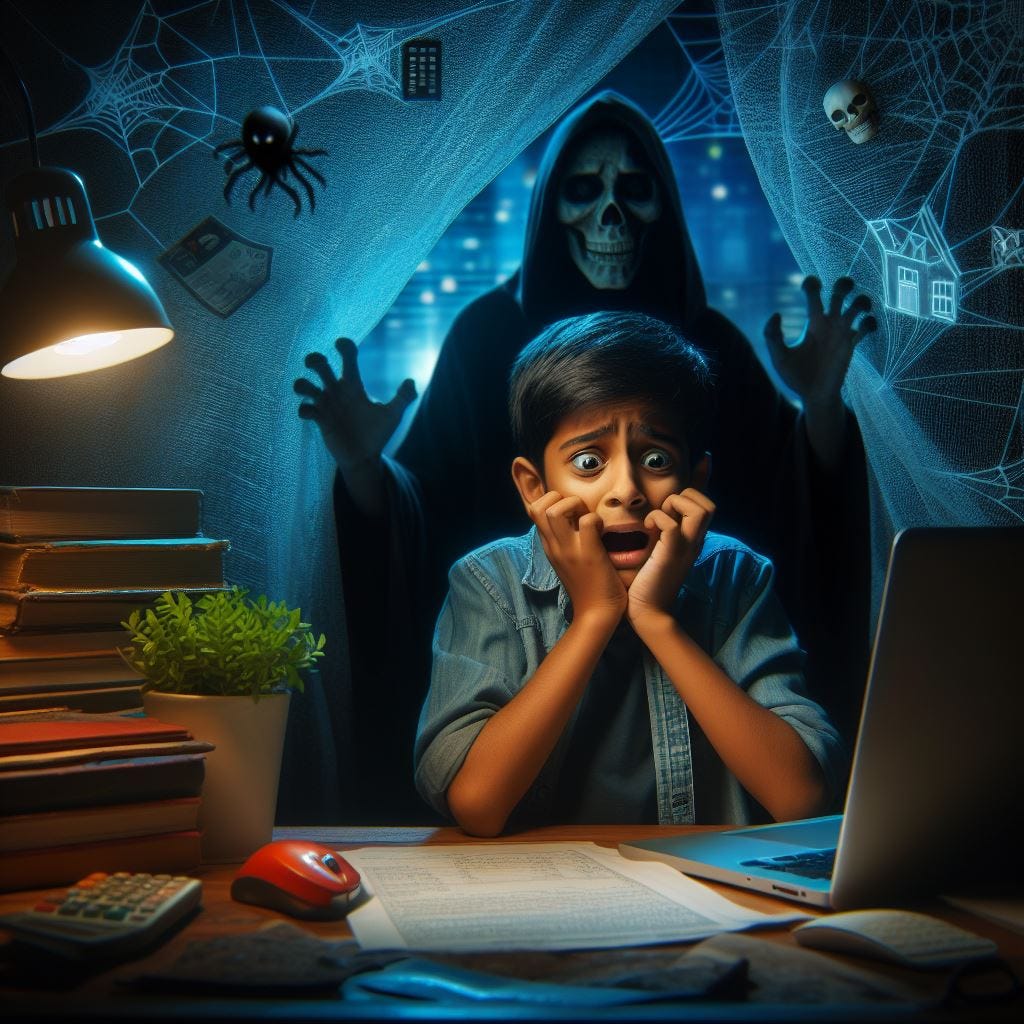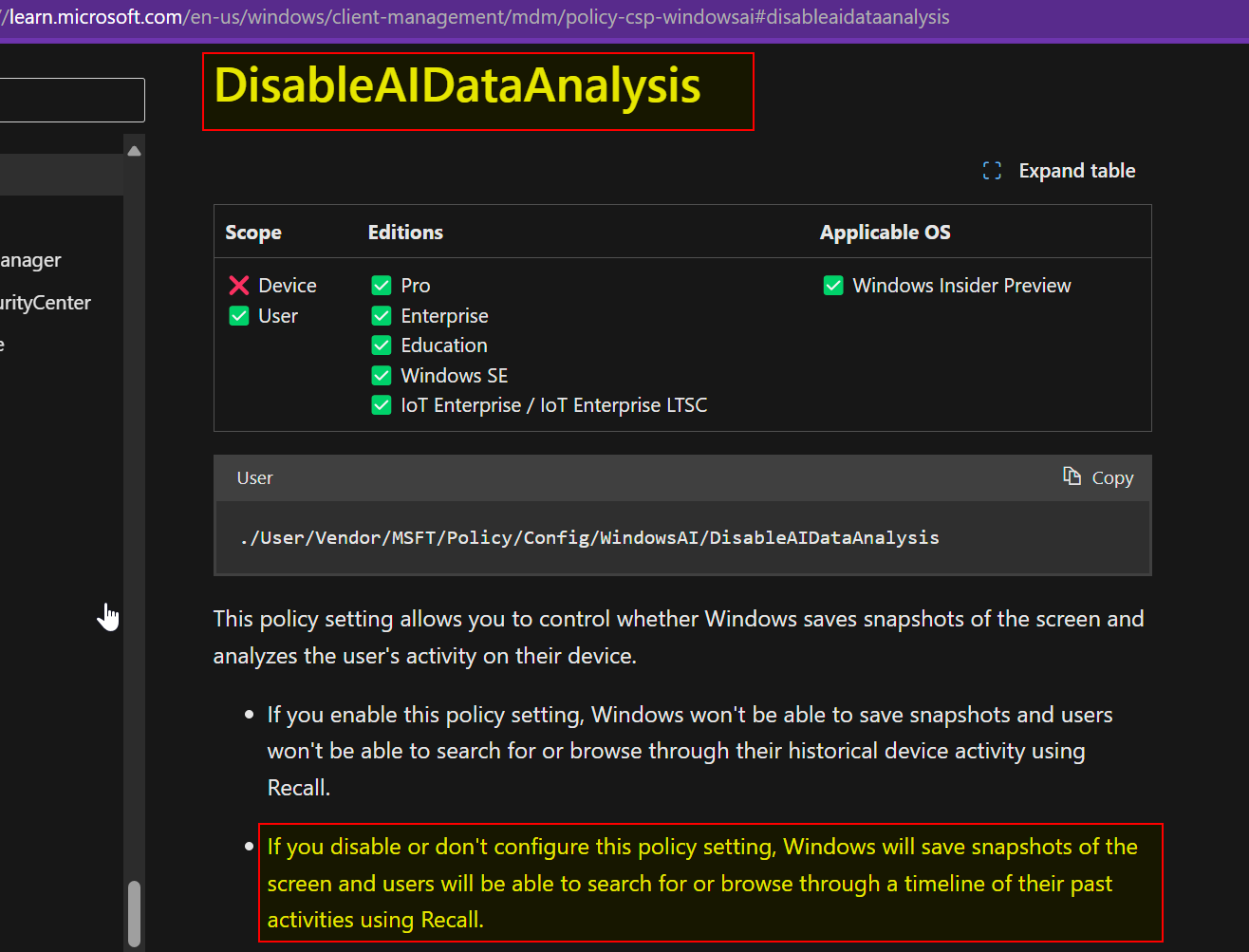Benjamin Constant: Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni
Vai agli altri articoli della serie “Grandi pensatori”
Vai agli altri articoli della serie “La società liberale e i suoi nemici”
Benjamin Constant (1767–1830), nato a Losanna, è entrato solo recentemente nella storia del pensiero politico, essendo rimasto a lungo più noto come letterato e memorialista (fu autore del romanzo Adolfo, di vari scritti autobiografici e delle Memorie sui cento giorni).
Ma in realtà il suo contributo agli studi politici è assai considerevole e appare, a distanza di oltre un secolo, uno dei più caratteristici e rappresentativi della sua epoca. Ebbe una vasta educazione letteraria e una ricca esperienza politica della vita europea: viaggiò in Inghilterra, in Svizzera, in Germania, in Belgio.
Nel 1796 pubblicò in Svizzera il suo primo scritto politico (Della forza del governo attuale della Francia e della necessità di collegarvisi) cui seguirono varie altre opere (Delle reazioni politiche, 1797; Degli effetti del Terrore, 1797; Saggio sulla controrivoluzione d’Inghilterra del 1660, 1798; Dello spirito di conquista e di usurpazione, 1814; Riflessioni sulle Costituzioni, la distribuzione dei poteri e le garanzie in una monarchia costituzionale, 1814; Principi di politica, 1815; Della religione considerata nella sua fonte, forma e sviluppo, 1824-1827).
Si tratta molto spesso di brevi scritti di occasione che offrono però, nell’insieme, un quadro compiuto e organico della visione costituzionalistica di Constant. Fu molto attivo nella vita politica divenendo membro del Tribunato sotto Napoleone, carica che gli fu poi tolta a causa delle sue critiche.
Nel 1803 lasciò, esule, la Francia con Madame de Staël, sua amica, dedicandosi alla produzione letteraria. Alla caduta di Napoleone ritornò a Parigi schierandosi contro il legittimismo della Restaurazione, difendendo la libertà di stampa e il sistema costituzionale di tipo inglese.
Durante i cento giorni di Napoleone accettò l’incarico di redigere un progetto di Costituzione, venendo meno alla sua linea antibonapartista. Dopo la definitiva sconfitta di Napoleone fu deputato e si schierò tra i liberali con Lafayette. Fu in seguito con Luigi Filippo, che lo nominò presidente del Consiglio di Stato.
Nell’epoca della Restaurazione, dunque, Constant rappresentò una posizione politica intermedia, fra la reazione legittimista e la nostalgia giacobina, e teorizzò, fra i primi, un regime costituzionale fondato sulla irresponsabilità del monarca, sulla responsabilità del governo, sulla divisione dei poteri e su un sistema di garanzie dei diritti individuali.
Un tale regime doveva, nelle sue intenzioni, costituire quel «governo regolare» che bisognava contrapporre al «governo che regolare non è», alla «usurpazione», al «dispotismo», all’«arbitrio».
L’idea centrale di questa concezione politica sta nella peculiare analisi che Constant sviluppa della libertà moderna in netto antagonismo con la libertà antica: questa, infatti, «risultava piuttosto dall’attiva compartecipazione al governo della collettività, che non dal godimento pacifico dell’indipendenza individuale».
La libertà moderna è invece essenzialmente la garanzia del perseguimento della felicità privata: «per essere felici gli uomini hanno bisogno oggi soltanto d’essere lasciati in un’assoluta indipendenza per tutto ciò che concerne le loro occupazioni, le loro intraprese, la loro sfera d’attività, le loro fantasie». Polemizzando pertanto contro “le contraffazioni moderne di repubbliche antiche”, Constant attacca “la metafisica sottile del Contratto sociale” che è “nell’età nostra atta soltanto a fornire armi e pretesti a ogni forma di tirannide, cosi a quella d’un solo come a quella di molti o di tutti”.
Fondamento della libertà politica non può essere che la sicurezza di poter svolgere la libertà civile. L’impianto tipico dello Stato moderno è pertanto costituito dal sistema rappresentativo (“una scoperta dei moderni”), entro il quale sistema va precisata e delimitata la nozione di sovranità popolare:
“L’universalità dei cittadini è sovrana nel senso che nessun individuo, nessuna frazione, nessuna associazione parziale può arrogarsi la sovranità senza averla ricevuta per delegazione. Ma da ciò non segue che l’universalità dei cittadini, o coloro che da essa sono investiti della sovranità, possano disporre sovranamente dell’esistenza degli individui.
V’è al contrario una parte dell’esistenza umana che di necessità resta individuale e indipendente, e che è di diritto al di là di ogni competenza sociale. La sovranità non esiste se non in maniera limitata e relativa.
Al punto in cui comincia l’indipendenza e l’esistenza individuale si arresta la giurisdizione di questa sovranità”.
Discende da ciò l’esigenza di un equilibrio nel sistema costituzionale attuato mediante un “potere neutro” (il monarca), la divisione dei poteri, il rispetto delle libertà individuali.
Così Constant delinea non soltanto le strutture politiche essenziali del costituzionalismo liberale, ma anche i suoi fondamenti sociali e, soprattutto, il carattere privato dei rapporti civili, il primato della proprietà privata: come la proprietà privata è il recinto entro il quale è possibile perseguire la felicità moderna, essa è anche l’altare su cui sboccia l’indipendenza individuale e con essa la razionalità stessa della vita.
Questo primato della proprietà privata comporta sia la “delegazione” al corpo rappresentativo della gestione degli affari comuni (sostanzialmente del sistema delle garanzie), sia l’esclusione dai diritti politici dei lavoratori:
“[…) per essere membro di un’associazione bisogna avere un certo grado di lumi, e un interesse comune con altri membri di questa associazione. […]
Coloro che l’indigenza mantiene in una eterna dipendenza, e che ha condannato a lavori giornalieri, non sono né più illuminati dei bambini sugli affari pubblici, né più interessati degli stranieri a una prosperità nazionale, di cui non conoscono gli elementi e di cui dividono solo indirettamente i vantaggi”.
Perciò Constant conclude che “soltanto la proprietà rende gli uomini capaci dell’esercizio dei diritti politici”. Ed è una conclusione (del resto già anticipata da Kant) che pone in luce la stretta connessione tra la struttura privatistica della società moderna e la struttura rappresentativa dello Stato.
I diritti naturali si sono ora risolti nei diritti civili, nei positivi diritti dell’Uomo, e rispetto ad essi i diritti politici assumono la portata accessoria di diritti-funzioni: il ribaltamento della libertà antica è completo.
Tramonta il fascinoso richiamo della comunità che Rousseau aveva riscoperto nella tradizione classica. Resta tuttavia il problema di come nel contesto di una stessa problematica (quella moderna, appunto) sia possibile un’analisi così divergente come quella comunitaria di Rousseau e quella individualistica di Kant-Humboldt-Constant.
A lumeggiare tale possibilità sta per venire non tanto la conferma comunitaria del socialismo utopistico, quanto piuttosto l’indagine economico scientifica di Marx sull’antagonismo delle classi. Del resto già il corso stesso dell’evoluzione storica porta i primi documenti: Constant muore nel 1830 e l’anno dopo l’agitazione dei tessili di Lione alza le prime barricate classiste dei lavoratori salariati.
Per questi non l’“indipendenza” di Constant, ma l’unione e la solidarietà sociale saranno la condizione della libertà moderna.
Riportiamo per intero il Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni nella traduzione di Pietro Fea (Biblioteca di scienze politiche diretta da Antonio Brunialti, Torino, 1890, Vol. V).
Signori
Mi propongo di sottoporvi alcune distinzioni che sono ancora abbastanza nuove fra due generi di libertà, le cui differenze sono rimaste finora inavvertite o sono state almeno troppo poco considerate. L’una è la libertà il cui esercizio era così caro ai popoli antichi; l’altra è quella il cui godimento è particolarmente prezioso per le nazioni moderne. Questa ricerca sarà interessante, se non vado errato, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la confusione tra queste due specie di libertà è stata fra noi, in epoche troppo celebri della nostra rivoluzione, la causa di molti mali. La Francia si è vista affaticare da inutili esperimenti i cui autori, irritati dal loro scarso successo, hanno cercato di costringerla a fruire del bene che essa non voleva e le hanno conteso il bene che voleva.
In secondo luogo, chiamati dalla nostra felice rivoluzione (la chiamo felice, nonostante i suoi eccessi, perché fisso lo sguardo sui suoi risultati) a fruire dei benefici di un governo rappresentativo, è curioso e utile ricercare perché questo governo, il solo al cui riparo possiamo oggi trovare qualche libertà e qualche riposo, è stato quasi interamente sconosciuto alle nazioni libere dell’antichità.
So che si è preteso di trovarne le tracce presso taluni popoli antichi, nella repubblica di Sparta e presso i Galli, nostri antenati; ma a torto.
Il governo di Sparta era un’aristocrazia monastica e non già un governo rappresentativo. Il potere dei re era limitato, ma era limitato dagli efori e non da uomini investiti di una missione simile a quella che l’elezione conferisce ai nostri giorni ai difensori delle nostre libertà. Gli efori, senza dubbio, dopo essere stati istituiti dai re furono nominati dal popolo. Ma non erano che cinque. La loro autorità era sia religiosa che politica; partecipavano anche all’amministrazione del governo, cioè al potere esecutivo e perciò la loro prerogativa, come quella di quasi tutti i magistrati popolari nelle antiche repubbliche, lungi dall’essere semplicemente una barriera contro la tirannide, diveniva talvolta essa stessa una insopportabile tirannide.
Il regime dei Galli, che somigliava notevolmente a quello che un certo partito vorrebbe renderci, era al tempo stesso teocratico e guerriero. Gli ecclesiastici godevano di un potere illimitato. La classe militare o la nobiltà possedeva privilegi assai insolenti e oppressivi. Il popolo era privo di diritti e di garanzie.
A Roma i tribuni avevano fino a un certo punto una missione rappresentativa. Erano organi di quei plebei che l’oligarchia, eguale in tutti i secoli, aveva sottomesso, rovesciando i re, a un duro servaggio. Il popolo esercitava tuttavia direttamente gran parte dei diritti politici. Esso si riuniva per votare le leggi, per giudicare i patrizi messi sotto accusa: non v’erano dunque a Roma che deboli tracce del sistema rappresentativo.
Questo sistema è una scoperta dei moderni e vedrete, Signori, che la condizione della specie umana nell’antichità non permetteva a un’istituzione di questo tipo di introdurvisi o di stabilirvisi. I popoli antichi non potevano sentirne la necessità né apprezzarne i vantaggi. La loro organizzazione sociale li conduceva a desiderare una libertà completamente diversa da quella che questo sistema ci assicura.
Il discorso di questa sera sarà appunto dedicato a dimostrarvi questa verità.
Chiedetevi innanzi tutto, Signori, che cosa intendano oggi con la parola libertà un inglese, un francese, un abitante degli Stati Uniti d’America.
Il diritto di ciascuno di non essere sottoposto che alle leggi, di non poter essere né arrestato, né detenuto, né messo a morte, né maltrattato in alcun modo a causa dell’arbitrio di uno o più individui. Il diritto di ciascuno di dire la sua opinione, di scegliere la sua industria e di esercitarla, di disporre della sua proprietà e anche di abusarne; di andare, di venire senza doverne ottenere il permesso e senza render conto delle proprie intenzioni e della propria condotta. Il diritto di ciascuno di riunirsi con altri individui sia per conferire sui propri interessi, sia per professare il culto che egli e i suoi associati preferiscono, sia semplicemente per occupare le sue giornate o le sue ore nel modo più conforme alle sue inclinazioni, alle sue fantasie. Il diritto, infine, di ciascuno di influire sulla amministrazione del governo sia nominando tutti o alcuni dei funzionari, sia mediante rimostranze, petizioni, richieste che l’autorità sia più o meno obbligata a prendere in considerazione. Paragonate ora a questa libertà quella degli antichi.
Essa consisteva nell’esercitare collettivamente ma direttamente molte funzioni dell’intera sovranità, nel deliberare sulla piazza pubblica sulla guerra e sulla pace, nel concludere con gli stranieri i trattati di alleanza, nel votare le leggi, nel pronunciare i giudizi; nell’esaminare i conti, la gestione dei magistrati, nel farli comparire dinanzi a tutto il popolo, nel metterli sotto accusa, nel condannarli o assolverli. Ma se questo era ciò che gli antichi chiamavano libertà, essi ritenevano compatibile con questa libertà collettiva l’assoggettamento completo dell’individuo all’autorità dell’insieme. Non trovate presso di loro alcuno dei godimenti che abbiamo visto far parte della libertà dei moderni. Tutte le azioni private sono sottoposte a una sorveglianza severa. Nulla è accordato all’indipendenza individuale né sotto il profilo delle opinioni, né sotto quello dell’industria, né soprattutto sotto il profilo della religione. La facoltà di scegliere il proprio culto, facoltà che noi consideriamo come uno dei nostri più preziosi diritti, sarebbe sembrata agli antichi un crimine e un sacrilegio.
Nelle cose che a noi sembrano più utili l’autorità del corpo sociale si interpone e impaccia la volontà degli individui. Terpandro non può a Sparta aggiungere una corda alla sua lira senza che gli efori si sdegnino. L’autorità si intromette anche nelle relazioni più intime. Il giovane spartano non può visitare liberamente la sua sposa. A Roma i censori penetrano con occhio scrutatore al l’interno delle famiglie. Le leggi regolano i costumi e poiché i costumi concernono tutto non v’è nulla che le leggi non regolino.
Così presso gli antichi l’individuo, sovrano quasi abitualmente negli affari pubblici, è schiavo in tutti i suoi rapporti privati. Come cittadino egli decide della pace e della guerra; come privato è limitato, osservato, represso in tutti i suoi movimenti; come parte del corpo collettivo interroga, destituisce, condanna, spoglia, esilia, manda a morte i suoi magistrati o i suoi superiori; come sottoposto al corpo collettivo può a sua volta essere privato della sua condizione, spogliato delle sue dignità, bandito, messo a morte dalla volontà discrezionale dell’insieme di cui fa parte. Presso i moderni, al contrario, l’individuo, indipendente nella sua vita privata, persino negli Stati più liberi non è sovrano che in apparenza. La sua sovranità è limitata, quasi sempre sospesa; e se, a epoche fisse ma rare nelle quali è pur sempre circondato da precauzioni e ostacoli, esercita questa sovranità, non lo fa che per abdicarvi.
Debbo qui, Signori, fermarmi un istante per prevenire una obiezione che mi si potrebbe fare. V’è nell’antichità una repubblica in cui l’asservimento dell’esistenza individuale al corpo collettivo non è così completo come ho appena descritto. Questa repubblica è la più celebre di tutte; voi indovinate che voglio parlare di Atene. Su ciò ritornerò in seguito e, concordando sulla verità del fatto, ve ne esporrò la causa. Vedremo perché fra tutti gli Stati antichi Atene è quello che più somigliò agli Stati moderni. In ogni altra parte la giurisdizione sociale era illimitata. Gli antichi, come dice Condorcet, non avevano alcuna nozione dei diritti individuali. Gli uomini non erano, per così dire, che delle macchine di cui la legge regolava le molle e dirigeva i congegni. Lo stesso asservimento caratterizzava i bei secoli della repubblica romana; l’individuo si era in qualche modo perduto nella nazione, il cittadino nella città.
Risaliamo adesso all’origine di questa differenza essenziale fra gli antichi e noi.
Tutte le repubbliche antiche erano rinchiuse entro ristretti confini. La più popolosa, la più potente, la più considerevole di esse non eguagliava in estensione il più piccolo Stato moderno. Per una inevitabile conseguenza della loro piccola estensione lo spirito di queste repubbliche era bellicoso, ogni popolo urtava continuamente i suoi vicini o da essi era urtato. Spinti così dalla necessità gli uni contro gli altri essi si combattevano o si minacciavano continuamente. Coloro che non volevano essere conquistatori non potevano deporre le armi se non a rischio di essere conquistati. Tutti comperavano la loro sicurezza e la loro indipendenza, la loro intera esistenza a prezzo della guerra. Questa costituiva l’interesse costante, l’occupazione quasi abituale degli Stati liberi dell’antichità. Infine, e per conseguenza parimenti necessaria di questo modo d’essere, tutti questi Stati avevano degli schiavi. Le professioni meccaniche e, presso talune nazioni, persino le professioni industriali erano affidate a braccia incatenate.
Il mondo moderno ci offre uno spettacolo completamente opposto. I più piccoli Stati della nostra epoca sono incomparabilmente più vasti di quel che fu Sparta o Roma durante cinque secoli. La stessa divisione dell’Europa in numerosi Stati è, grazie al progresso della civiltà, più apparente che reale. Mentre prima ogni popolo formava una famiglia isolata, nemica nata delle altre famiglie, ora una massa d’uomini vive sotto nomi differenti e in differenti modi di organizzazione sociale, che è però per sua natura omogenea. È abbastanza forte per non aver nulla da temere dalle orde barbare e abbastanza illuminata perché la guerra le sia di peso. La sua uniforme tendenza è verso la pace.
Questa differenza ne comporta un’altra. La guerra è anteriore al commercio; perché la guerra e il commercio non sono che due mezzi differenti per raggiungere lo stesso fine: quello di possedere ciò che si desidera. Il commercio non è che un omaggio reso alla forza del possessore da colui che aspira al possesso. È un tentativo per ottenere pacificamente ciò che non si spera più di conquistare con la violenza. Un uomo che fosse sempre il più forte non avrebbe mai l’idea del commercio. È l’esperienza che, provandogli che la guerra, cioè l’impiego della sua forza contro la forza altrui, lo espone a varie resistenze e a vari insuccessi, lo induce a ricorrere al commercio, cioè un mezzo più dolce e più sicuro per impegnare l’interesse di un altro ad acconsentire a ciò che conviene al suo interesse. La guerra è l’impulso, il commercio è il calcolo. Ma per ciò stesso deve venire un’epoca in cui il commercio sostituisca la guerra. Noi siamo arrivati a questa epoca.
Non voglio affatto dire che non vi siano stati presso gli antichi popoli commercianti. Ma questi popoli facevano in qualche modo eccezione alla regola generale. I limiti di un discorso non mi permettono di indicarvi tutti gli ostacoli che si opponevano allora ai progressi del commercio; d’altronde voi li conoscete bene quanto me; ne ricorderò uno solo. L’ignoranza della bussola obbligava i marinai antichi a non perder di vista le coste, per quanto era loro possibile. Attraversare le colonne d’Ercole, varcare cioè lo stretto di Gibilterra, era considerato la più audace impresa. Fenici e cartaginesi, i più abili navigatori, osarono farlo solo molto tardi e il loro esempio restò a lungo senza imitatori. Ad Atene, di cui parleremo tra poco, l’interesse marittimo era di circa il 60 per cento mentre l’interesse ordinario era del 12 per cento, tanto l’idea di una navigazione lontana implicava quella del pericolo.
Inoltre, se potessi compiere una digressione che purtroppo sarebbe troppo lunga, vi mostrerei, Signori, attraverso i dettagli dei costumi, delle abitudini, del modo di trafficare dei popoli commercianti dell’antichità con gli altri popoli, che lo stesso commercio era, per così dire, impregnato dello spirito dell’epoca, dell’atmosfera di guerra e di ostilità che li circondava. Il commercio era allora un felice accidente: oggi invece è la condizione normale, il fine unico, la tendenza universale, la vera via delle nazioni.
Queste vogliono la pace, con la pace il benessere e l’industria in quanto è fonte del benessere. La guerra è ogni giorno di più un mezzo meno efficace per soddisfare i loro desideri. Le sue occasioni non offrono più né agli individui, né alle nazioni benefici che eguaglino i risultati del lavoro pacifico e degli scambi regolari. Presso gli antichi una guerra fortunata accresceva la ricchezza pubblica e privata di schiavi, tributi e terre. Presso i moderni una guerra fortunata costa infallibilmente più di quanto non renda.
Infine, grazie al commercio, alla religione, ai progressi intellettuali e morali della specie umana non vi sono più schiavi presso le nazioni europee. Sono gli uomini liberi che debbono esercitare tutte le professioni, provvedere a tutti i bisogni della società.
E facile immaginare, Signori, quale sia il risultato necessario di queste differenze.
In primo luogo l’estensione di un paese diminuisce proporzionalmente l’importanza politica che spetta a ciascun individuo. Il più oscuro repubblicano di Roma o di Sparta era una potenza. Non è la stessa cosa per il semplice cittadino della Gran Bretagna o degli Stati Uniti. La sua personale influenza è un elemento impercettibile della volontà sociale che imprime la sua direzione al governo.
In secondo luogo l’abolizione della schiavitù ha tolto alla popolazione tutto il tempo che le derivava dal fatto che agli schiavi era affidata la maggior parte dei lavori. Senza gli schiavi di Atene, ventimila ateniesi non avrebbero potuto deliberare ogni giorno sulla piazza pubblica.
In terzo luogo, il commercio non consente, come la guerra, intervalli di attività nella vita dell’uomo. Il continuo esercizio dei diritti politici, la quotidiana discussione degli affari di Stato, le diatribe, i conciliaboli, tutto il seguito e il movimento delle fazioni, agitazioni necessarie, riempitivo obbligato, se posso impiegare questo termine, nella vita dei popoli liberi dell’antichità, che senza questa risorsa avrebbero languito sotto il peso di una dolorosa inerzia, offrirebbe soltanto disordine e fatica alle nazioni moderne, nelle quali ogni individuo, occupato nelle speculazioni, nelle imprese e nei godimenti ottenuti o sperati, non vuole essere distolto che momentaneamente e il meno possibile.
Infine, il commercio ispira agli uomini un vivo amore per la indipendenza individuale. Il commercio provvede ai loro bisogni e soddisfa i loro desideri senza intervento dell’autorità. Tale intervento è quasi sempre — e non so perché dica quasi — è sempre un disturbo e un impedimento. Tutte le volte che il potere collettivo vuole immischiarsi nelle speculazioni private esso vessa gli speculatori. Tutte le volte che i governi pretendono di fare i nostri affari li fanno peggio e con maggiore dispendio di noi.
Vi ho detto, Signori, che vi avrei riparlato di Atene, il cui esempio potrebbe essere opposto ad alcune delle mie asserzioni e che, invece, le confermerà tutte.
Atene, come ho già riconosciuto, fu di tutte le repubbliche greche, quella maggiormente dedita al commercio: perciò accordava ai suoi cittadini una libertà individuale infinitamente più grande di Roma e Sparta. Se potessi entrare nei dettagli storici vi mostrerei che il commercio aveva fatto scomparire da Atene molte delle differenze che distinguono i popoli antichi dai popoli moderni. Lo spirito dei commercianti di Atene era simile a quello dei commercianti di oggi. Senofonte ci informa che durante la guerra del Peloponneso essi trasferivano i loro capitali dal continente dell’Attica alle isole dell’Arcipelago. Il commercio aveva dato vita presso di loro alla circolazione.
Notiamo in Isocrate tracce dell’uso delle lettere di cambio. Osservate anche quanto i loro costumi somiglino ai nostri. Nei loro rapporti con le donne vedrete — cito ancora Senofonte — che gli sposi sono soddisfatti quando la pace e una decorosa amicizia regnano all’interno della casa, sono indulgenti verso la sposa troppo fragile che cede alla tirannia della natura, chiudono gli occhi sull’irresistibile potere delle passioni, perdonano la prima debolezza e dimenticano la seconda. Nei loro rapporti con gli stranieri li vedrete prodigare i diritti di cittadinanza a chiunque, trasferendosi tra loro con la famiglia, intraprenda un mestiere o impianti una fabbrica; sarete infine colpiti dal loro estremo amore per l’indipendenza indi- viduale. A Sparta, dice un filosofo, i cittadini accorrono quando il magistrato li chiama; ma un ateniese si ridurrebbe alla disperazione se credesse di dipendere da un magistrato.
Poiché tuttavia molte delle altre circostanze che decidevano del carattere delle nazioni antiche esistevano anche ad Atene e poiché vi era una popolazione di schiavi e il territorio era assai piccolo, vi troviamo vestigia delle libertà proprie degli antichi. Il popolo fa le leggi, esamina la condotta dei magistrati, chiama Pericle alla resa dei conti, condanna a morte i generali che avevano diretto la battaglia delle Arginuse. In pari tempo l’ostracismo, questo arbitrio legale vantato da tutti i legislatori dell’epoca che a noi sembra, e deve sembrare, una rivoltante iniquità, prova che l’individuo era ancora più asservito alla supremazia del corpo sociale ad Atene di quanto non lo sia oggi in qualsiasi Stato libero dell’Europa.
Da quel che ho finora esposto risulta che noi non possiamo più godere della libertà degli antichi che si fondava sulla partecipazione attiva e costante al potere collettivo. La nostra libertà deve fondarsi sul pacifico godimento dell’indipendenza privata. La parte che nell’antichità ciascuno aveva nella sovranità nazionale non era affatto, come lo è oggi, una astratta supposizione. La volontà di ciascuno aveva una influenza reale: l’esercizio di questa volontà era un piacere vivo e ripetuto. Di conseguenza, gli antichi erano disposti a fare molti sacrifici per conservare i loro diritti politici e la loro partecipazione all’amministrazione dello Stato. Ciascuno sentiva con orgoglio tutto quel che valeva il suo suffragio e trovava, in questa coscienza della sua personale importanza, un ampio compenso.
Questo compenso non esiste più oggi per noi. Perduto nella moltitudine, l’individuo non avverte quasi mai l’influenza che esercita. Mai la sua volontà si imprime sull’insieme, niente prova, ai suoi occhi, la sua cooperazione. L’esercizio dei diritti politici ci offre dunque ormai soltanto una parte dei godimenti che vi trovavano gli antichi e in pari tempo i progressi della civiltà, la tendenza commerciale dell’epoca, la comunicazione dei popoli fra loro hanno moltiplicato e variato all’infinito i mezzi della felicità privata.
Ne segue che dobbiamo essere attaccati assai più degli antichi alla nostra indipendenza individuale; perché gli antichi, quando sacrificavano questa indipendenza ai diritti politici, sacrificavano il meno per ottenere il più; mentre facendo lo stesso sacrificio noi daremmo il più per ottenere il meno.
Il fine degli antichi era la divisione del potere sociale fra tutti i cittadini di una stessa patria: era questo che essi chiamavano libertà. Il fine dei moderni è la sicurezza dei godimenti privati; ed essi chiamano libertà le garanzie accordate dalle istituzioni a questi godimenti.
Ho detto all’inizio che, non avendo colto queste differenze, uomini d’altronde bene intenzionati causarono infiniti mali durante la nostra lunga e tempestosa rivoluzione. Dio non voglia che rivolga loro rimproveri troppo severi: il loro errore era scusabile. Non si possono leggere le belle pagine dell’antichità, non si possono rievocare le azioni dei suoi grandi uomini senza provare non so quale emozione particolare che niente di ciò che è moderno fa provare. Gli antichi elementi di una natura anteriore, per così dire, alla nostra sembrano risvegliarsi in noi a questi ricordi. È difficile non rimpiangere quei tempi in cui le facoltà dell’uomo si sviluppavano in una direzione predeterminata ma con un orizzonte vastissimo, con grande sicurezza nelle proprie forze e con grande sentimento di energia e dignità; e quando ci si abbandona a questi rimpianti è impossibile non voler imitare quel che si rimpiange.
Questa impressione era profonda soprattutto quando vivevamo sotto governi usurpatori che, senza essere forti, erano vessatori, assurdi nei loro principi, miserabili nell’azione; governi che avevano per movente l’arbitrio, per fine l’abbrutimento del genere umano e che certuni osano vantare ancor oggi come se potessimo dimenticare mai di essere stati testimoni e vittime della loro ostinazione, della loro impotenza e della loro rovina. Il fine dei nostri riformatori fu nobile e generoso. Chi di noi non ha sentito il cuore battere di speranza all’imbocco della strada che sembravano aprire? E guai anche oggi a chi non prova il bisogno di dichiarare che il riconoscimento di alcuni errori commessi dai nostri primi maestri non significa disonorare la loro memoria né sconfessare opinioni che gli amici dell’umanità hanno professato in tutti i tempi.
Ma questi uomini avevano attinto molte delle loro teorie alle opere di due filosofi che non ignoravano le modificazioni apportate da duemila anni alle attitudini del genere umano. Forse un giorno esaminerò il sistema del più illustre di questi filosofi, di Jean-Jacques Rousseau, e mostrerò che trasferendo nei nostri tempi moderni un’ampiezza del potere sociale, della sovranità collettiva che apparteneva ad altri secoli, questo genio sublime animato dal più puro amore per la libertà ha tuttavia fornito pretesti funesti a più di un tipo di tirannia. Senza dubbio, mettendo in rilievo quel che considero come un equivoco che è importante chiarire, sarò cauto nella mia confutazione e rispettoso nel biasimo. Eviterò certamente di unirmi ai detrattori di un grande uomo. Quando il caso vuole che io m’incontri con loro anche su un solo punto, diffido di me stesso e per consolarmi di sembrare per un istante del loro stesso parere su una unica e parziale questione, ho bisogno di sconfessare e umiliare per quanto mi è possibile questi miei pretesi alleati.
Tuttavia, l’interesse della verità deve prevalere su considerazioni che rendono tanto potenti lo splendore di un talento prodigioso e l’autorità di una fama immensa. D’altronde non è affatto a Rousseau, come si vedrà, che si deve principalmente attribuire l’errore che combatto: esso va attribuito molto di più a uno dei suoi successori, meno eloquente ma non meno austero e mille volte esagerato. Quest’ultimo, l’abate Mably, può essere considerato come il rappresentante del sistema che, conformemente alle massime della libertà antica, vuole che i cittadini siano completamente assoggettati perché la nazione sia sovrana e che l’individuo sia schiavo perché il popolo sia libero.
L’abate Mably, come Rousseau e come molti altri, sulla scia degli antichi, aveva scambiato l’autorità del corpo sociale per la libertà e tutti i mezzi gli sembravano buoni per estendere l’azione di questa autorità su quella parte recalcitrante dell’esistenza umana di cui egli deplorava l’indipendenza. Il rimpianto che egli esprime dappertutto nelle sue opere è che la legge non possa raggiungere che le azioni. Egli avrebbe voluto che essa raggiungesse i pensieri, le impressioni più fugaci e perseguisse l’uomo senza posa e senza lasciargli asilo ove potersi sottrarre al suo potere. Appena scorgeva presso un qualsiasi popolo una misura vessatoria, credeva di aver fatto una scoperta e la proponeva per modello; egli odiava la libertà individuale come si odia un nemico personale e quando incontrava nella storia una nazione che ne era completamente priva non poteva trattenersi dall’ammirarla. Si estasiava davanti agli egiziani perché, diceva, tutto presso di loro era regolato dalla legge, perfino i piaceri e i bisogni: tutto si piegava sotto l’impero del legislatore; ogni attimo della giornata era occupato da qualche dovere; perfino l’amore era soggetto a questo intervento rispettato ed era la legge che di volta in volta apriva o chiudeva l’alcova nuziale.
Sparta, che al medesimo asservimento degli individui univa forme repubblicane, eccitava nello spirito di questo filosofo un entusiasmo ancor più vivo. Questo vasto convento gli sembrava l’ideale di una perfetta repubblica. Per Atene aveva un profondo disprezzo e avrebbe detto volentieri di questa nazione, che fu in Grecia la prima, quel che un accademico gran signore diceva della Accademia francese: «Che spaventoso dispotismo! Tutti vi fanno quel che vogliono». Debbo aggiungere che questo gran signore parlava dell’Accademia com’era trenta anni fa.
Montesquieu, dotato di uno spirito più osservatore perché aveva una testa meno focosa, non è caduto affatto negli stessi errori. Egli è stato colpito dalle differenze che ho riferito: ma non ne ha individuata la vera causa. I politici greci che vivevano sotto il governo popolare non riconoscevano — diceva — altra forza che quella della virtù. Quelli di oggi non parlano che di manifatture, di commercio, di finanze, di ricchezza e perfino di lusso. Egli attribuisce questa differenza alla repubblica e alla monarchia: bisogna attribuirla invece allo spirito opposto dei tempi antichi e dei tempi moderni. Tanto i cittadini delle repubbliche quanto i sudditi delle monarchie vogliono tutti godere e nessuno può non volerlo, allo stato attuale della società. Nella nostra epoca il popolo più attaccato alla sua libertà, prima della liberazione della Francia, era anche il popolo più attaccato a tutti i godimenti della vita e teneva alla sua libertà soprattutto perché vi vedeva la garanzia dei godimenti che amava. In passato là dove c’era libertà si potevano sopportare le privazioni; ora dovunque ci sono privazioni è necessaria la schiavitù per rassegnarvisi. Oggi sarebbe più facile fare di un popolo di schiavi un popolo di spartani che formare degli spartani per la libertà.
Gli uomini che si trovarono sospinti dall’onda degli avvenimenti alla testa della nostra rivoluzione erano, per necessaria conseguenza dell’educazione che avevano ricevuta, imbevuti di opinioni antiche e ormai false, rimesse in onore dai filosofi di cui ho parlato. La metafisica di Rousseau, nella quale lampeggiavano d’un tratto sublimi verità e passaggi di una eloquenza trascinatrice, la austerità di Mably, la sua intolleranza, il suo odio contro tutte le passioni umane, la sua brama di asservirle tutte, i suoi esagerati principi sulla competenza della legge, la differenza tra ciò che egli raccomandava e ciò che esisteva, le sue declamazioni contro le ricchezze e perfino contro la proprietà, tutto ciò doveva affascinare uomini infiammati da una vittoria recente che, conquistando un potere legale, erano ben disposti ad estenderlo su tutto. Per loro era un’autorità preziosa quella di due scrittori che, disinteressati nella questione, avevano pronunciato l’anatema contro il dispotismo degli uomini redigendo in assiomi il testo della legge. Vollero dunque esercitare la forza pubblica come avevano imparato dai loro maestri che era stata un tempo esercitata negli Stati liberi. Credettero che tutto dovesse di nuovo cedere davanti alla volontà collettiva e che tutte le restrizioni ai diritti individuali sarebbero ampiamente compensate dalla partecipazione al potere sociale.
Voi sapete, Signori, quale è stato il risultato. Istituzioni libere, fondate sulla conoscenza dello spirito del secolo, avrebbero potuto sussistere. L’edificio rinnovato degli antichi è crollato nonostante molti sforzi e molti atti eroici che hanno diritto all’ammirazione. Il fatto è che il potere sociale feriva in tutti i sensi l’indipendenza individuale senza distruggerne il bisogno. La nazione non trovava affatto che una parte ideale di una sovranità astratta valesse i sacrifici che le si ordinavano. Invano le si ripeteva con Rousseau: le leggi della libertà sono mille volte più austere di quanto non sia duro il giogo dei tiranni. Essa non voleva queste leggi austere e nella sua stanchezza credeva talvolta che il giogo dei tiranni sarebbe stato preferibile. È venuta l’esperienza e l’ha disingannata. Essa ha visto che l’arbitrio degli uomini era peggiore delle peggiori leggi. Ma anche le leggi debbono avere i loro limiti.
Se sono giunto, Signori, a farvi condividere la convinzione che secondo me questi fatti debbono produrre, riconoscerete con me la verità dei principi che seguono.
L’indipendenza individuale è il primo bisogno dei moderni: di conseguenza non se ne deve mai chieder loro il sacrificio per stabilire la libertà politica.
Ne segue che nessuna delle istituzioni numerose e troppo vantate che nelle repubbliche antiche limitavano la libertà individuale è ammissibile nei tempi moderni.
Sembra a tutta prima superfluo, Signori, stabilire questa verità. Molti governi dei nostri giorni non sembrano affatto inclini a imitare le repubbliche dell’antichità. Tuttavia, se hanno poca inclinazione per le istituzioni repubblicane, hanno non so quale attaccamento per alcune usanze repubblicane. È deplorevole che siano proprio quelle che permettono il bando, l’esilio e la confisca. Mi ricordo che nel 1802 in una legge sui tribunali speciali venne inserito un articolo che introduceva in Francia l’ostracismo greco; e Dio sa quanti oratori eloquenti ci parlarono, per far approvare questo articolo che fu tuttavia ritirato, della libertà di Atene e di tutti i sacrifici che gli individui dovevano fare per conservare la libertà! Del pari, in epoca più recente, quando autorità paurose tentarono con mano titubante di dirigere le elezioni a loro piacimento, un giornale che pure non è affatto contaminato di repubblicanismo propose di far rivivere la censura romana per allontanare i candidati pericolosi.
Credo dunque di non impegnarmi in una digressione inutile se, per sostenere la mia asserzione, dirò qualche parola su queste due tanto celebrate istituzioni.
L’ostracismo di Atene si fondava sull’ipotesi che la società ha piena autorità sui suoi membri. In questa ipotesi esso si poteva giustificare in uno Stato piccolo, ove l’influenza di un individuo forte del suo credito, della sua clientela, della sua gloria, eguagliava spesso la potenza della massa, l’ostracismo poteva avere una parvenza di utilità. Ma tra noi gli individui hanno diritti che la società deve rispettare e l’influenza individuale, come ho già osservato, è talmente perduta in una moltitudine di influenze eguali o superiori che ogni vessazione motivata con la necessità di diminuire tale influenza è inutile e quindi ingiusta. Nessuno ha il diritto di esiliare un cittadino se non è condannato legalmente da un tribunale regolare in base a una legge formale che infligge la pena dell’esilio per l’azione di cui è colpevole. Nessuno ha diritto di strappare il cittadino alla sua patria, il proprietario ai suoi beni, il negoziante al suo commercio, lo sposo alla sposa, il padre ai figli, lo scrittore alle sue meditazioni, il vecchio alle sue abitudini. Ogni esilio politico è un attentato politico. Ogni esilio pronunciato da una assemblea per pretesi motivi di salute pubblica è un crimine di tale assemblea contro la salute pubblica, la quale riposa sempre sul rispetto delle leggi, sulla osservanza delle forme e sul mantenimento delle garanzie.
La censura romana supponeva come l’ostracismo un potere discrezionale. In una repubblica in cui tutti i cittadini, allevati dalla povertà in una estrema semplicità di costumi, abitavano nella stessa città e non esercitavano altra professione che distraesse la loro attenzione dagli affari di Stato trovandosi così costantemente spettatori e giudici dell’uso del potere pubblico, la censura poteva da una parte avere maggiore influenza e, da un’altra, l’arbitrio dei censori era contenuto da una sorta di vigilanza morale esercitata su di loro. Ma quando l’estensione della repubblica, la complicazione delle relazioni sociali e l’affinamento della civiltà tolsero a questa istituzione quel che le serviva da base e da limite, la censura degenerò persino a Roma. Non era dunque la censura che aveva creato i buoni costumi; era la semplicità dei costumi che costituiva la potenza e l’efficacia della censura.
In Francia una istituzione arbitraria come la censura sarebbe al tempo stesso inefficace e intollerabile: nello stato presente della società i costumi si compongono di sfumature sottili, ondeggianti, impercettibili che si snaturerebbero in mille modi se si tentasse di dar loro maggiore precisione. Soltanto l’opinione può percepirle; essa soltanto può giudicarle, perché ha la medesima natura, mentre si solleverebbe contro ogni autorità positiva che volesse conferirle maggior precisione. Se il governo di un popolo moderno volesse, come i censori di Roma, colpire un cittadino con una decisione discrezionale, la nazione intera protesterebbe e non ratificherebbe le decisioni dell’autorità.
Quel che ho detto a proposito del trapianto della censura nei tempi moderni si applica a molti altri aspetti della organizzazione sociale, in ordine ai quali l’antichità ci viene citata ancor più frequentemente e con ancor maggiore enfasi. Così è per la educazione, ad esempio. Che cosa non ci vien detto circa la necessità di permettere che il governo si impadronisca delle nuove generazioni per modellarle a suo piacimento e con quali citazioni erudite non viene sostenuta questa teoria! I persiani, gli egiziani, e la Gallia e la Grecia e l’Italia ci vengono di volta in volta ricordate. Oh! Signori, noi non siamo né persiani sottomessi a un despota, né egiziani soggiogati dagli ecclesiastici, né galli che potevano essere sacrificati dai loro druidi, né infine greci e romani che potevano consolarsi del loro asservimento privato per la partecipazione all’autorità sociale. Siamo dei moderni che vogliamo godere ciascuno dei propri diritti, sviluppare ciascuno le proprie facoltà come meglio ci sembra senza nuocere agli altri, vegliare sullo sviluppo di queste facoltà nei fanciulli che la natura affida al nostro affetto tanto più illuminato quanto più è vivo. Non abbiamo bisogno dell’autorità se non per ottenere gli strumenti generali di istruzione che può fornire, come i viaggiatori accettano da essa le grandi strade senza farsi dirigere nel cammino da seguire. Anche la religione è esposta a questi ricordi dei secoli passati. Intrepidi difensori dell’unità di dottrina ci citano le leggi degli antichi contro gli dèi stranieri e sostengono i diritti della chiesa cattolica con l’esempio degli ateniesi che fecero perire Socrate perché aveva attaccato il politeismo e con quello di Augusto che voleva che si restasse fedeli al culto dei padri, la qual cosa fece sì che qualche tempo dopo si gettassero alle belve i primi cristiani.
Diffidiamo, dunque, Signori, di questa ammirazione per certe reminiscenze antiche. Giacché viviamo nei tempi moderni voglio la libertà che conviene ai tempi moderni; e giacché siamo retti da monarchie supplico umilmente queste monarchie di non mutuare dalle antiche repubbliche mezzi di oppressione.
La libertà individuale, lo ripeto, ecco la vera libertà moderna. La libertà politica ne è la garanzia; la libertà politica è quindi indispensabile. Ma chiedere ai popoli dei nostri giorni di sacrificare come quelli di altre epoche la totalità della loro libertà individuale alla libertà politica è il mezzo più sicuro per distaccarli dall’una e quando vi si sarà riusciti non si tarderà a strappar loro l’altra.
Vedete, Signori, che le mie osservazioni non tendono affatto a sminuire il valore della libertà politica. Dai fatti che vi ho sottoposti non traggo affatto le conseguenze che ne traggono certuni. Dal fatto che gli antichi sono stati liberati e che noi non possiamo più essere liberi come gli antichi essi concludono che siamo destinati a essere schiavi. Essi vorrebbero costituire il nuovo stato sociale con un piccolo numero di elementi che ritengono i soli appropriati alla situazione del mondo attuale. Tali elementi sono i pregiudizi per spaventare gli uomini, l’egoismo per corromperli, la frivolezza per stordirli, i piaceri grossolani per degradarli, il dispotismo per guidarli; e, ce n’è pur bisogno, conoscenze positive e scienze esatte per servire meglio il dispotismo. Sarebbe strano che questo fosse il risultato di quaranta secoli durante i quali il genere umano ha conquistato tanti mezzi morali e fisici: non posso pensarlo. Dalle differenze che ci distinguono dagli antichi io traggo conseguenze del tutto opposte. Non è affatto la garanzia che bisogna indebolire, è il godimento che bisogna estendere. Non voglio affatto rinunciare alla libertà politica, ma reclamo la libertà civile con altre forme di libertà politica. I governi non hanno più di ieri il diritto di arrogarsi un potere illegittimo. Ma i governi che derivano da una fonte legittima hanno meno di ieri il diritto di esercitare sugli individui una supremazia arbitraria. Possediamo ancor oggi i diritti che sempre avemmo, gli eterni diritti di approvare le leggi, di deliberare sui nostri interessi, di essere parte integrante del corpo sociale di cui siamo membri. Ma i governi hanno nuovi doveri; i progressi della civiltà, i mutamenti operati dai secoli comandano all’autorità maggior rispetto per le abitudini, per gli affetti, per l’indipendenza degli individui. Essa deve portare su tutte queste cose una mano più prudente e leggera.
Questo riserbo dell’autorità è nei suoi stretti doveri ed è parimenti, beninteso, nei suoi interessi; giacché se la libertà che conviene ai moderni è differente da quella che conveniva agli antichi il dispotismo che era possibile presso gli antichi non è più possibile presso i moderni. Dal fatto che siamo spesso distratti dalla libertà politica più di quanto potevano esserlo loro e che nella nostra condizione ordinaria possiamo essere meno appassionati per essa può derivare che talvolta trascuriamo troppo, e sempre a torto, le garanzie che essa ci assicura; ma al tempo stesso, poiché teniamo assai più degli antichi alla libertà individuale, noi la difenderemo, se è attaccata, con maggior abilità e tenacia; e per difenderla abbiamo mezzi che gli antichi non avevano.
Il commercio rende l’azione dell’arbitrio sulla nostra esistenza più vessatoria che in altri tempi perché le nostre speculazioni sono più svariate sicché l’arbitrio deve moltiplicarsi per colpirle; ma il commercio rende altresì l’azione dell’arbitrio più facile a eludersi perché muta la natura della proprietà rendendola quasi inafferrabile.
Il commercio conferisce alla proprietà una qualità nuova, la circolazione: senza circolazione la proprietà non è che un usufrutto; l’autorità può sempre influire sull’usufrutto perché può togliere il godimento; ma la circolazione pone un ostacolo invisibile e invincibile a questa azione del potere sociale.
Gli effetti del commercio si estendono ancor più lontano: non soltanto esso affranca gli individui, ma, creando il credito, rende l’autorità dipendente.
Il denaro, dice uno scrittore francese, è l’arma più pericolosa del dispotismo, ma è al tempo stesso il suo più potente freno; il credito è sottoposto all’opinione; la forza è inutile; il denaro si nasconde o fugge; tutte le operazioni dello Stato sono sospese. Il credito non aveva la stessa influenza presso gli antichi; i loro governi erano più forti dei privati; i privati sono più forti dei poteri politici della nostra epoca; la ricchezza è una potenza più disponibile a ogni istante, più applicabile a ogni interesse e quindi assai più reale e meglio obbedita: si sfugge al potere ingannandolo; per ottenere i favori della ricchezza bisogna servirla: questa deve vincere.
Come conseguenza delle medesime cause l’esistenza individuale è meno inglobata nell’esistenza politica. Gli individui trasferiscono lontano i loro tesori; portano seco tutti i godimenti della vita privata; il commercio ha ravvicinato le nazioni e ha dato loro costumi e abitudini presso che eguali: i capi possono essere nemici, i popoli sono compatrioti.
Il potere, dunque, si rassegni; ci occorre la libertà e l’avremo. Ma poiché la libertà che ci occorre è diversa da quella degli antichi occorre ad essa un’organizzazione diversa da quella degli antichi, occorre ad essa un’organizzazione diversa da quella conveniente alla libertà antica. In questa, quanto più uno dedicava tempo e forza all’esercizio dei suoi diritti politici, tanto più si credeva libero; nel tipo di libertà che si addice a noi, quanto più l’esercizio dei nostri diritti politici ci lascerà tempo per i nostri interessi privati, tanto più la libertà ci sarà preziosa.
Di qui, Signori, scaturisce la necessità del sistema rappresentativo. Il sistema rappresentativo non è altro che una organizzazione mediante la quale una nazione scarica su alcuni individui ciò che non può o non vuol fare da sé. I poveri fanno da sé i loro affari: i ricchi assumono degli intendenti. È la storia delle nazioni antiche e delle nazioni moderne. Il sistema rappresentativo è una procura data a un certo numero di uomini dalla massa del popolo che vuole che i suoi interessi siano difesi e che però non ha il tempo di difenderli sempre da sé. Ma, a meno di essere insensati, i ricchi che hanno degli intendenti esaminano con attenzione e severità se gli intendenti fanno il loro dovere, se sono negligenti o corruttibili o incapaci; e per giudicare della gestione di questi mandatari i mandanti che sono prudenti si tengono al corrente degli affari di cui affidano loro l’amministrazione. Parimenti i popoli che, al fine di godere della libertà che si addice loro, ricorrono al sistema rappresentativo debbono esercitare una sorveglianza attiva e costante sui loro rappresentanti e debbono riservarsi, in epoche che non siano separate da intervalli troppo lunghi, il diritto di allontanarli se hanno deluso i loro desideri e di revocare i poteri di cui avessero abusato.
Dal fatto che la libertà moderna differisce dalla libertà antica deriva infatti che essa è altresì minacciata da un pericolo di natura differente.
Il pericolo della libertà antica era che gli uomini, attenti soltanto ad assicurarsi la partecipazione al potere sociale, non rinunciassero troppo a buon mercato ai diritti e ai godimenti individuali.
Il pericolo della libertà moderna è che, assorbiti nel godimento della nostra indipendenza privata e nel perseguimento dei nostri interessi particolari, noi possiamo rinunciare troppo facilmente al nostro diritto a partecipare al potere politico.
I depositari dell’autorità non mancano di esortarci a ciò. Sono tanto disposti a risparmiarci ogni sorta di pena, eccettuata quella di obbedire e di pagare! Essi ci diranno: quale è in fondo lo scopo dei vostri sforzi, il motivo dei vostri lavori, l’oggetto di tutte le vostre speranze? Non è la felicità? Ebbene lasciateci fare e ve la daremo. No, Signori, non lasciamo fare; per quanto commovente sia un così tenero interessamento, preghiamo l’autorità di restare nei suoi confini: si limiti a essere giusta, noi ci incaricheremo di essere felici.
Potremmo essere felici se i nostri godimenti fossero separati dalle garanzie? E dove troveremmo queste garanzie se rinunciassimo alla libertà politica? Rinunciarvi, Signori, sarebbe follia simile a quella di chi, col pretesto che abita appena al primo piano, pretendesse costruire sulla sabbia un edificio senza fondamenta.
D’altronde, Signori, è dunque vero che la felicità, quale che possa essere, sia il fine unico del genere umano? In questo caso la nostra carriera sarebbe assai ristretta e il nostro destino ben poco elevato. Non c’è nessuno di noi che, se volesse discendere e restringere le sua facoltà morali, abbassare i suoi desideri, abdicare all’attività, alla gloria, alle emozioni generose e profonde, potrebbe abbrutirsi ed essere felice. No, Signori, chiamo a testimone la parte migliore della nostra natura, questa nobile inquietudine che ci perseguita e ci tormenta, questa brama di estendere le nostre conoscenze e di sviluppare le nostre facoltà; non alla sola felicità, ma al perfezionamento ci chiama il nostro destino; e la libertà politica è il mezzo più energico e possente di perfezionamento che il cielo ci abbia dato.
La libertà politica, sottoponendo a tutti i cittadini senza eccezione l’esame e lo studio dei loro interessi più sacri, allarga il loro spirito, nobilita i loro pensieri, stabilisce tra loro una sorta di eguaglianza intellettuale che fa la gloria e la potenza di un popolo.
Così, vedete come una nazione ingrandisce alla prima istituzione che le renda l’esercizio regolare della libertà politica. I nostri concittadini di tutte le classi, di tutte le professioni, uscendo dalla sfera dei loro lavori abituali e della loro industria privata si trovano subito al livello delle importanti funzioni che la Costituzione affida loro e scelgono con discernimento, resistono con energia, sconcertano l’astuzia, sfidano la minaccia, resistono nobilmente alla seduzione. Il patriottismo più puro, profondo e sincero trionfa nelle nostre città e vivifica perfino i nostri casali, attraversa i nostri opifici, rianima le nostre campagne, persuade del sentimento dei nostri diritti e della necessità delle garanzie lo spirito giusto e retto del coltivatore utile e del negoziante industrioso che, conoscendo dalla storia i mali che hanno subiti nonché i rimedi che questi mali esigono, abbracciano con un solo sguardo la Francia intera e, dispensatori della riconoscenza nazionale, ricompensano con i loro suffragi, dopo trenta anni, la fedeltà ai principi nella persona del più illustre difensore della libertà.
Lungi dunque, Signori, dal rinunciare ad alcuna delle due specie di libertà delle quali vi ho parlato, bisogna, come ho dimostrato, imparare a combinarle l’una con l’altra. Le istituzioni, come dice il celebre autore della Histoire des républiques du moyen àge, debbono compiere i destini del genere umano; tanto meglio raggiungono il loro scopo se innalzano il maggior numero possibile di cittadini alla più alta dignità morale.
L’opera del legislatore non è affatto completa quando ha soltanto reso tranquillo il popolo. Anche quando il popolo è contento, resta ancora molto da fare. Occorre che le istituzioni completino l’educazione morale dei cittadini. Mentre rispettano i loro diritti individuali e tutelano la loro indipendenza esse debbono tuttavia consacrare la loro influenza sulla cosa pubblica, chiamarli a concorrere con le loro deliberazioni e con i loro suffragi all’esercizio del potere, debbono garantir loro un diritto di controllo e di sorveglianza tramite la manifestazione delle loro opinioni e, formandoli in tal modo mediante la pratica a queste elevate funzioni, debbono dar loro al tempo stesso il desiderio e la facoltà di adempierle.
Tratto da: Il pensiero politico, a cura di Umberto Cerroni, Roma, Editori Riuniti, 1966, pp. 704.724