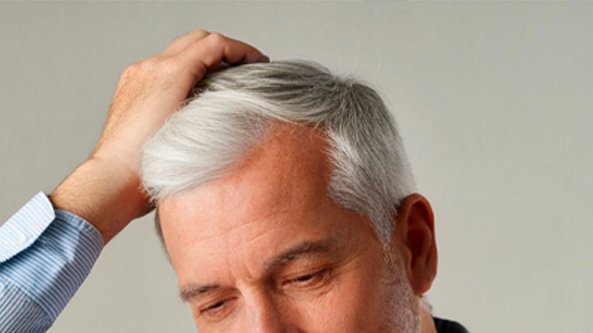In realtà non è neppure certo che si tratti di Eleonora come la tradizione vorrebbe, la principessa nipote di Federico d'Aragona scomparsa nel 1405, e sarebbe quindi un idealizzato ritratto postumo. Gli storici dell'arte, spesso molto litigiosi quando si tratta di attribuzioni e datazioni, in merito alla identità della figura effigiata da Francesco Laurana dibattono da decenni, ipotizzando possa trattarsi di un'altra principessa aragonese, Isabella, figlia di Alfonso II, o una delle sorelle del sovrano, Beatrice o un'altra Eleonora vissuta quindi almeno un paio di generazioni dopo l'antenato di cui porta il nome e che si vorrebbe riconoscere nell'opera oggi a Palazzo Abatellis. In ogni caso, il busto giustamente celebrato, insieme al Trionfo della Morte e alla Annunziata di Antonello quale momento irrinunciabile di qualsiasi visita alla Galleria regionale della Sicilia, è divenuto col tempo una icona, grazie anche alla soluzione geniale con cui Carlo Scarpa ne dispose la visione al momento dell'allestimento del museo: di profilo, provenendo dalla grande Sala del Trionfo, sul fondo di un pannello colorato in verde.
Talmente famoso, questo profilo, che alcuni anni fa Italo Rota ideò per i dissuasori del prato al Foro italico dei birilli multicolori con il profilo continuo di Eleonora che in verità era sovrapponibile al profilo continuo di Mussolini realizzato da designer Renato Giuseppe Bertelli negli anni Trenta. Vabbè, incidenti di percorso.
Ma una icona è comunque una icona, riconoscibile, emblematica, per definizione aperta e rivisitabile. È quello che ha fatto Igor Scalisi Palminteri, in un murale che sarà inaugurato oggi (una iniziativa de Le Vie dei tesori all'interno del progetto " Rinascono i luoghi di Eleonora d'Aragona") alle 11.30 a Contessa Entellina, il borgo vicino a quel bosco di Calatamauro dove sorgeva (imperfetto d'obbligo: recuperata da uno stato di precarietà, oggi è un relais) l'abbazia benedettina di Santa Maria del Bosco, di cui Eleonora era stata fondatrice e patrona e da cui proviene il busto che un tempo ne sormontava il monumento funebre. Una scelta non casuale quella di affidare il murale, alto otto metri, al pittore palermitano, classe 1972, che ormai da anni ha individuato in questa forma di arte pubblica una sua specifica e personale sigla espressiva, dedicando i suoi interventi spesso a figure della devozione tradizionale, da Santa Rosalia a Sant'Erasmo a San Benedetto il Moro, con un approccio figurativo che ne enfatizza la solennità iconica - rappresentate come sono in posizione frontale - in un incrocio riuscito e originale tra figurazione pop e immaginazione popolare. Pop, del resto vuol dire esattamente questo, e non per caso le sue opere si ritrovano a Palermo e non solo in zone problematiche della città come figure di riscatto e di aggregazione. " A Contessa Entellina il murale sorge all'inizio del paese, come a dare il benvenuto ai visitatori. - racconta il pittore - Per me è stata l'occasione di confrontarmi con la scultura, cercando di coglierne la componente spirituale recuperando il verde che Scarpa ha usato per il pannello di fondo e restituendo, del capolavoro di Laurana, una presenza ieratica sin quasi alla stilizzazione. L'intervento di Contessa Entellina sarà seguito da altri due murales nei luoghi dove Eleonora ha vissuto, tra cui Giuliana, moltiplicandone quindi le tracce".

Eleonora una, bina e trina, come d'altronde è nella storia dell'arte: al busto di Palazzo Abatellis si affiancano infatti altre due versioni, entrambe a Parigi, una al Louvre e l'altra al museo Jaquemart - André; ma il gioco delle identità multiple non finisce qui, perché un ritratto identificato come Beatrice d'Aragona si trova a New York, alla Frick Collection, un altro, Isabella d'Aragona o secondo altri la Laura di Petrarca - al Kunsthistorisches Museum di Vienna, e sfoggia ancora parte della smagliante policromia originale. Ultima, tra le sorelle, Battista Sforza, in un ritratto ora al Museo del Bargello a Firenze dalle medesime impostazioni ma più mosso e nervoso, con la bocca leggermente schiusa e il capo che che ha un leggero movimento verso l'alto. Dettaglio non da poco: si tratta della medesima nobildonna raffigurata nel celebre dittico degli Uffizi insieme al marito Federico da Montefeltro da Piero della Francesca, il che apre a quello che, per gli storici dell'arte, è relativamente alla ricostruzione della biografia e del catalogo dello scultore, il problema dei problemi: Laurana e Piero si sono conosciuti, e dove, e quando?
Si era detto prima: il busto di Eleonora d'Aragona è al centro di un groviglio di questioni interpretative, a partire da quella più semplice dopo l'identificazione della ritratta, e cioè dove e quando Francesco Laurana lo avrebbe scolpito, se in Sicilia, all'epoca del suo primo soggiorno, documentato tra il 1468 e il 1471, ovvero più tardi, al momento di un secondo soggiorno, controverso e soltanto ipotizzato, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta. O invece fuori dall'Isola, quando Laurana ripercorre a ritroso i passi che lo avevano condotto in Sicilia e torna, quindi, prima a Napoli e poi in Francia, in un peregrinare dove avrebbe in effetti potuto incontrare Piero, allacciando una stretta relazione con la pittura italiana del primo Rinascimento forse alimentata da un altro incontro, quello con Antonello da Messina, magari nei centri orientali, Noto o Palazzolo Acreide, per i quali entrambi si erano trovati a lavorare.
Fatto è che il ritratto di Eleonora, o chiunque sia la gentildonna che increspa appena il volto con un accenno subito smorzato di sorriso enigmatico e sfuggente, ha la chiusa perfezione sospesa che ricordiamo in alcune Madonne di Piero della Francesca, quella della Pala del Duca Federico per esempio o della Madonna di Senigallia: una fissità da idolo antico e remoto immerso nel silenzio, carezzata dalla luce che nella veste e nella cuffia intacca in brevi solchi la superficie del marmo come in una scultura dell'arcaismo ionico greco e dilaga invece quieta nel modellato del volto che si flette, quel poco che basta a farci intuire in quella perfezione una vita, una attesa, un commiato. Un vertice assoluto, allora, dell'arte europea del Quattrocento: e sarebbe bello pensare che prima o poi, in Sicilia, ci si decidesse a organizzare una mostra del grande scultore dalmata, riunendo insieme per la prima volta tutte le diverse versioni e varianti di questo ritratto femminile, Eleonora e le sorelle.