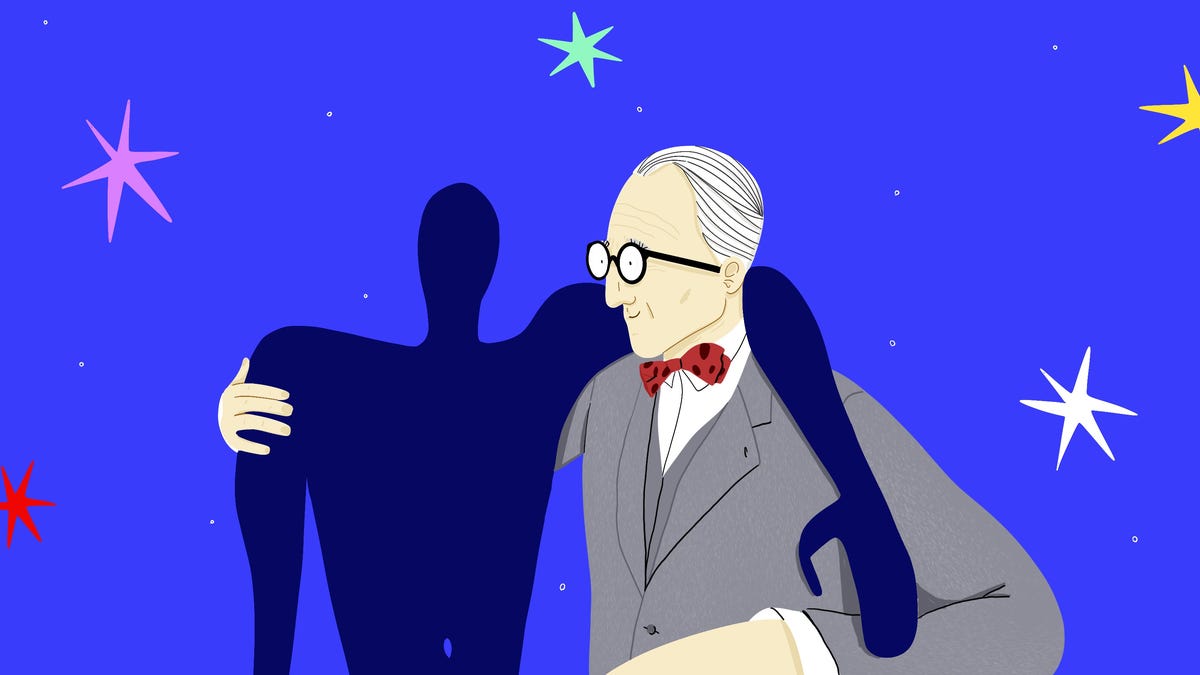A 83 anni, 50 dei quali passati a disegnare e plasmare il mondo a modo suo, Renzo Piano è un architetto noto a tutti, ben oltre il ristretto club degli addetti ai lavori.
Tra gli ultimi progetti di Renzo Piano che hanno fatto il giro del mondo c'è sicuramente il nuovo ponte di Genova, l’opera che il celebre architetto ha regalato alla sua città, e che se tutto andrà come previsto vedrà la luce nel 2019. “Bello, di una bellezza genovese: restìa, parsimoniosa, taciturna”, così Renzo Piano ha descritto quello che per lui non è semplicemente un ponte, ma un segno di pace, la ricomposizione di una frattura, un monumento alla memoria e all'unità, non solo di una città, ma di un paese intero.
Renzo Piano, biografia
Tutto ha inizio da Genova, città difficile e fiera, stretta tra il mare e le montagne, dove l’architetto nasce nel 1937. E il cantiere da subito diventa la sua casa. Grazie al padre, costruttore edile, Renzo Piano impara ad amare la polvere e la fatica, la magia misteriosa delle forme che si compongono, mattone dopo mattone. E per comprendere quella magia, va a studiare architettura, prima a Firenze, e poi al Politecnico di Milano. Qui trova la sua dimensione, meno “perfetta”, più permeabile, e soprattutto trova un maestro, Franco Albini, padre del Razionalismo italiano, che nutre la sua passione per i dettagli, contribuendo a segnarne la visione architettonica. Una visione in cui ciascun progetto è come un prototipo, che si assembla pezzo per pezzo, con una spiccata vocazione tecnologica e artigianale, deliberatamente anti-accademica: ogni singola componente conta e va concepita in armonia con la propria funzione e con ciò che le sta intorno. Per questo nessuna opera è uguale a un’altra. Non ci sono motivi ricorrenti e riconoscibili nel lavoro di Renzo Piano, non c’è uno stile unico, perché come lui stesso spiega “lo stile è una trappola. Quello che mi piace è l’intelligenza e la coerenza. La coerenza non c’entra con la forma, è qualcosa di più forte, più umanistico, più poetico”.
Renzo Piano, opere prime
Le prime tracce di questo approccio appaiono evidenti già negli anni 60. Lasciata Milano, Renzo Piano si sposta negli Stati Uniti, a Philadelphia, dove collabora con Louis Kahn. Qui sperimenta soluzioni innovative, leggere, “a guscio”, con sistemi costruttivi all’avanguardia, che risentono anche dell'influsso delle space structures di Zygmunt Stanislaw Makowski, ingegnere polacco ma di stanza a Londra, con cui Renzo Piano stringe un profondo legame.
Tra le opere più significative di questa stagione giovanile ci sono la fabbrica mobile per l’estrazione di zolfo a Pomezia (1966), il padiglione per la Triennale di Milano (1967), e la sede della B&B Italia a Novedrate di Como (1971-1973), tutti progetti che prendono vita dall'integrazione di singole parti, ad alto tasso di tecnologia e design.
Il Renzo Piano architetto comincia a farsi un nome, ma il vero salto di qualità avviene negli anni 70, quando approda a Londra e sigla un sodalizio decisivo col grande architetto britannico Richard Rogers. Nel 1971, sbaragliando la concorrenza di 641 architetti provenienti da ben 49 paesi, lo studio “Piano&Rogers” porta a casa una commessa destinata a lasciare il segno nella storia dell’architettura del XX secolo: parliamo del Centre Georges Pompidou di Parigi, un museo come non se n’erano mai visti. Emblema del costruttivismo e del movimento high-tech, che dava grande risalto alle innovazioni tecnologiche, l’edificio piombava sullo storico quartiere del Marais come “un’enorme navicella spaziale fatta di vetro, acciaio e tubature colorate”. Era un corpo estraneo, sfacciato e irriverente, ma che avrebbe ben presto messo radici profonde, nel cuore della città e dell’immaginario collettivo. A cinquant’anni di distanza, la sua facciata percorsa da scale mobili, dove ad ogni elemento strutturale è associato un colore diverso in base alla funzione, lascia ancora a bocca aperta.
È questo l’inizio di una lunga storia d’amore, quella tra Renzo Piano e l’architettura museale, che fa il giro del mondo, celebrando il rapporto simbiotico tra ingegneria, design e umanesimo che sta alla base dell'approccio di Piano: si va dalla Menil Collection a Houston (1982-1986), alla Fondazione Beyeler a Basilea (1991-1997), per poi approdare nel nuovo millennio con altri capolavori indiscussi, come l’High Museum di Atlanta (1999-2003), il Paul Klee Zentrum di Berna (1999-2005), il MUSE di Trento (2013), o il recente Centro Butin di Santander, inaugurato nel 2017.
Renzo Piano, le strutture degli anni '80
Ma torniamo al Centro Pompidou, una delle opere più famose di Renzo Piano e punto di svolta di una carriera che da lì in avanti non si sarebbe più fermata. Su quel cantiere Renzo Piano conosce Peter Rice, ingegnere capo del progetto, che diviene suo partner, soppiantando Richard Rogers. La collaborazione dura quattro anni e si conclude nel 1981, quando l’architetto italiano decide di mettersi in proprio: nasce così il Renzo Piano Building Workshop, che non a caso elegge Genova a sua sede principale (ma si aggiungeranno poi gli uffici di Parigi, Osaka e New York).
Dagli anni 80 in avanti, fioccano le commissioni, e Renzo Piano con il suo Rpbw diviene a tutti gli effetti un’archistar, capace di spaziare in tutti i campi, dal sacro al profano, dal piccolo al gigantesco. Tra i suoi progetti più importanti ricordiamo l’Aeroporto internazionale del Kansai a Osaka, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la Chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, lo stadio San Nicola di Bari, fino ad arrivare ai grattacieli: The Shard, a Londra, inaugurato nel 2012, e il Nuovo palazzo di Giustizia di Parigi, in costruzione, che diventerà il più alto edificio della città dopo la Torre Eiffel.
Renzo Piano tra architettura e impegno civico
È dall’impegno civico che Renzo Piano trae le più grandi soddisfazioni. Oltre a firmare musei e centri culturali disseminati a tutte le latitudini, l’architetto genovese si cimenta infatti in numerosi interventi di riqualificazione urbana, concependo opere che incidono profondamente nel tessuto socio-culturale dei luoghi in cui si insediano. Pensiamo ad esempio al progetto di ristrutturazione Schlumberger di Montrouge (1981-1984) e soprattutto al recupero del Porto Antico di Genova (1985-2001), che esattamente come il futuro ponte di cui tutti parlano in questi giorni, riflette un moto di rinascita e orgoglio cittadino. La stessa filosofia si ritrova nella riconversione del Lingotto di Torino da fabbrica dismessa a polo culturale, o ancora nel restyling di Potsdamer Platz a Berlino, dopo la caduta del muro: Renzo Piano riesce nell'intento di innovare restando fedele all’identità e alla storia di ciascun luogo, con una sensibilità artistica, e ancor prima umana, che innerva le forme architettoniche, e le rende vive, uniche, capaci di suscitare in chi vi passa attraverso un senso immediato di appartenenza e meraviglia.
Questo talento è valso all’architetto genovese una sfilza lunghissima di premi e riconoscimenti, primo fra tutti il Pritzker Prize, ricevuto dalle mani di Bill Clinton nel 1998, ma anche la medaglia d'oro del RIBA - Royal Institute of British Architects (1989), la légion d'honneur (2000), il Wexner Prize (2001), la medaglia d'oro dell'AIA - American institute of architects (2008), solo per citarne alcuni. Anche l’Italia negli anni ha tributato i giusti onori a un uomo capace di rappresentarne l’eccellenza in giro per il mondo: dopo il Compasso d’oro, conquistato nel lontano 1981, si sono succeduti innumerevoli riconoscimenti, fino al titolo di Senatore a vita, conferitogli nel 2013 dal presidente Giorgio Napolitano.
Un po’ della sua fortuna e del suo successo, Renzo Piano ha deciso di condividerli, dando vita nel 2006 a una Fondazione che porta il suo nome, un ente no-profit con sede a Genova, che si occupa dell'archivio dello Studio Renzo Piano, ma che soprattutto mira a supportare e formare i giovani architetti, attraverso borse di studio, pubblicazione di libri e promozione di mostre.
Oggi, a 83 anni, senza più nulla da dimostrare, Renzo Piano è un uomo che può concedersi il lusso di lavorare gratis per qualcosa che gli sta a cuore, come il ponte della sua città, ferita e ansiosa di rinascere. È, ancora, un eterno ragazzo che guarda ostinatamente al futuro, capace di stupirsi e stupire, come quando da esordiente sperimentava materiali e tecniche innovative, rifuggendo ogni schema. È, in una parola, un artista, che da mezzo secolo immagina e modella la realtà, con l’ambizione di renderla migliore, e molte volte ci riesce, se è vero, come scrisse di lui il New York Times, che “la serenità dei suoi migliori edifici può farti quasi credere che viviamo in un mondo civilizzato”.

Elisa Zagaria è un’autrice che ha trasformato in un lavoro la sua più grande passione: cercare e inventare storie. Quelle che racconta per Elle Decor, in qualità di collaboratrice freelance, hanno per protagonisti case da sogno, personalità, eventi e luoghi simbolo del nostro tempo. E poi ci sono altre storie, in forma di romanzi e soprattutto sceneggiature, che scrive per la televisione, in attesa di diventare sufficientemente ricca da potersi comprare una di quelle case da sogno.