Lui la chiama ditta. «Perché si stupisce tanto?». Nel Canavese, in quella parte d’Italia che sta tra Ivrea e Torino, la ditta è sempre stata tutto. Era ditta il piccolo capannone industriale nato negli anni Sessanta di fianco all’autostrada per Aosta ma anche il grande gruppo. Ancora negli anni Ottanta, quando l’allora vescovo di Ivrea, Luigi Bettazzi, si rivolgeva ai vertici della Olivetti, si raccomandava che organizzassero «il lavoro nella ditta secondo giustizia e con l’adeguata remunerazione». Allora la Olivetti era un multinazionale di livello mondiale. La Spea lo è diventata anche se non gode di tanta fama in patria (per quanto il logo disegnato con i fiori campeggi sull’aiuola d’ingresso del paese). Ma, a dispetto delle apparenze, Luciano Bonaria, il fondatore e profeta, è un signore che spiega alla Apple quali sono i chip difettosi e riceve premi in tutto il mondo. Mille dipendenti in Italia e una missione che il signor Luciano riassume con poche, lapidarie parole: «Siamo indispensabili per la vita sul pianeta. Siamo solo tre ditte, a livello mondiale, a testare tre trilioni di microchip ogni anno. Se uno si rompe, rischia di cadere un aereo, si blocca un porto, va in tilt una sala operatoria. Mica scherzi».
Può dare una certa soddisfazione insegnare ai signori di Cupertino come deve essere un microchip, segnarli con la matita rossa e blu. Bisogna avere neuroni eccezionali: «Sa qual è il segreto? Essere scelti dalle persone giuste. Ci vuole capacità ma anche un po’ di fortuna». Il primo ad accorgersi di Luciano era stato «un amico che avevo incontrato durante una vacanza con gli scout in Valle d’Aosta. Mi aveva insegnato a costruire le radio, quelle che usavano i radioamatori e le centrali dei taxi». Conserva ancora una fotografia in bianco e nero, lui e i suoi amici in posa sul tetto di una baita, orgogliosamente aggrappati a una lunga antenna: «Mi ero appassionato. Nei giorni di bel tempo andavamo a Montoso, sulle Alpi della valle Po, e trasmettevamo fino alla Sicilia. Parlavamo con Catania e ci pareva un miracolo». Perché in fondo questa è sempre stata la vocazione di Luciano: inventare macchine per fare cose ritenute impossibili. Ancora oggi è così: come si fa a dire quando si romperà un microchip? Chi è in grado di prevedere il futuro? «Abbiamo inventato strumenti in grado di farlo. Ma dobbiamo andare con ordine». Perché alla fine, ma solo alla fine, si scoprirà che la soluzione è una questione di logica.
L’ufficio di comando della Spea, a Volpiano, 15 chilometri da Torino, non ha nulla di avveniristico. Niente arredamenti da Guerre Stellari, Star Trek e mondi futuribili. Piuttosto, mobili in legno lucido, poltrone trapuntate, e sui tavoli di noce una serie di copripiano in pelle pregiata. Perché questo tuffo nell’Ottocento proprio qui, nel regno dei microchip? «Perché la mia famiglia viene dall’800. Mio padre ha cominciato all’età di 11 anni cucendo le scarpe di pelle ai lavoranti di casa Savoia in piazza Castello. Ecco perché la pelle è rimasta nella mia vita». Anche quella di suo padre era una ditta? «No, quella era una bottega. Il frutto dei sacrifici di una vita. Purtroppo andò male. Aveva investito i risparmi in buoni del tesoro e con la fine della guerra tutto il suo patrimonio andò in fumo. Pochi anni dopo nacqui io». Lei non seguì le orme di suo padre. Perché? «Mi consigliarono di studiare da perito elettronico». E lei si diplomò a pieni voti: «Niente affatto. Uscii con un voto basso perché più dello studio mi interessava il basket». Lì il profitto era migliore? «Assolutamente sì. Segnavo 12-14 punti a partita. Ho giocato fino a 50 anni. Mi allenavo due volte alla settimana». E oggi qual è il suo sport preferito? «Le faccio vedere le fotografie. Guardi qui: arrampico in montagna con la moto». Con tutto il rispetto, con il basket e il trial non si fa fortuna nel mondo dei microchip: «Vero. Per quello bisogna incontrare le persone giuste. La seconda persona che mi ha scelto nella vita è stato Carlo Avenati Bassi, direttore della divisione elettronica della Olivetti». Qui la storia di Luciano si intreccia con quella, affascinante, degli uomini che fecero il computer. Un gruppo di ingegneri, tecnici, designer, che avrebbe creato a Ivrea il polo mondiale dell’elettronica. «Olivetti indisse un concorso nelle scuole: partecipammo in 2.000. Dovevano scegliere 100 candidati. Arrivai quarantatreesimo. Mi presero. Avenati Bassi mi chiamò per un colloquio a tu per tu». Un bel successo vero? «Mi stupii molto. Gli dissi: “Perché tra tanti ha scelto me che sono solo un perito e non un ingegnere?”. Mi chiese: “Lei che cosa sa fare?”. Allora gli dissi che mi piaceva inventare. Che a 4 anni facevo le trottole con la terra, che a 10 costruivo lampadine e le vendevo al mercato di Porta Palazzo. Il primo giorno di lavoro arrivò con una scheda magnetica e mi disse: “Tra tre giorni torni qui e mi dica come dobbiamo fare a creare una macchina per capire se questa scheda funziona. In sette mesi alla Olivetti ho inventato quattro macchine per collaudare le schede dei computer». Perché era tanto importante il collaudo? “Perché all’inizio i computer avevano funzioni diverse sulle due sponde dell’Atlantico. Semplificando un po’ i computer dell’Ibm in America servivano sostanzialmente a contare i soldi. Quelli della Olivetti da noi servivano a far funzionare le fabbriche e i sistemi complessi in modo più veloce. Se sbagli a contare i soldi sopravvivi, se sbagli a collaudare il computer di un aereo, è una strage”.
A Caluso, venti chilometri da Ivrea, la Olivetti e la General Electric producevano l’anima dei computer. “Ci chiedevano di collaudare apparecchi pieni di fili con una memoria da 8 k. Venivano realizzati da centinaia di donne, alcune avevano lavorato nell’industria tessile ed erano brave a infilare i fili di rame collegando i nuclei. Poi arrivò Intel e cambiò tutto, anche per noi”. E’ successo che un altro “ex” della Olivetti, Federico Faggin, emigrato negli Usa, ha inventato, insieme a due colleghi americani, il microprocessore: «Fu una rivoluzione perché sulla punta di un dito stava la capacità di memoria che prima si trovava su un piatto». Nuovi processori, nuove macchine per collaudarli. «Abbiamo imparato e siamo diventati bravi. Una delle soddisfazioni più grandi? Nel 2007 arrivarono microchip nuovi più potenti. Le statistiche dicevano che erano sicuri al 99 per cento, che solo una minima parte si rompeva. Ci fu un bando in America. Noi abbiamo partecipato e abbiamo vinto, battendo la concorrenza delle aziende californiane. Abbiamo garantito: con noi non se ne romperà nessuno». Affermazione impegnativa. Come si fa a garantire l’imprevedibile?
Eccoci arrivati al cuore della filosofia di Luciano Bonaria: «Il segreto sta nella capacità di prevedere le irregolarità. Le persone come me, che sono creative e irregolari dalla nascita, praticano le irregolarità e dunque le conoscono. In fondo il difetto è una irregolarità. Se un microprocessore è difettoso, invece di durare trenta, quarant’anni, si blocca dopo quattro. E non può succedere. La verità è che per riuscire a dare la caccia alle diversità, devi essere diverso tu. Così le riconoscerai meglio. E le sconfiggerai». Funziona? «Ha sempre funzionato. Per questo ci chiamano in tutto il mondo. E io, a 76 anni, continuo a girare il globo per lavoro. Questo mese sono stato in Tailandia a inaugurare il nuovo stabilimento. A giugno andrò nelle Filippine. Una caccia senza fine ai difetti dei microchip. Questa, in fondo, è la missione della mia vita».


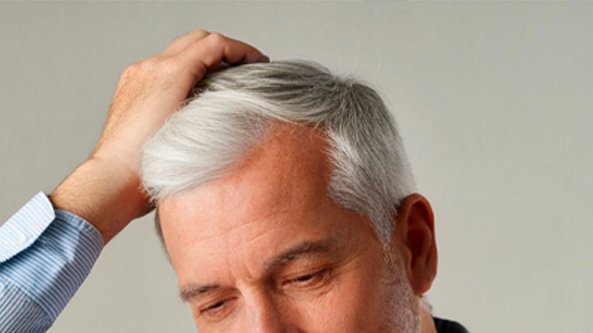

I commenti dei lettori