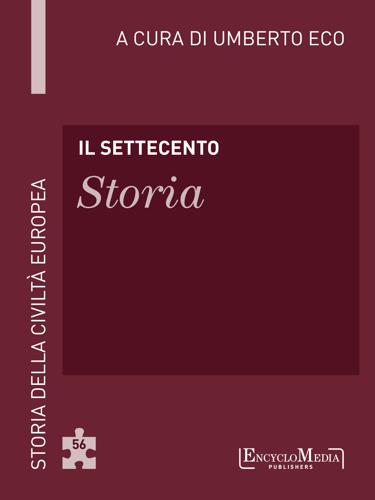La Prussia (il Settecento)
Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco (2014)
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Nel corso del Settecento la Prussia si afferma come una delle grandi potenze del sistema europeo, malgrado la frammentazione del suo territorio, il limitato potenziale demografico e la sua arretratezza economica e sociale. Il consolidamento e l’espansione dello Stato prussiano sono soprattutto il risultato della tenace opera di riforma – politica, economica e militare – di Federico Guglielmo I e di suo figlio Federico II.
Dal Brandeburgo al Regno di Prussia
Nel 1701 l’imperatore Leopoldo I d’Austria, per assicurarsi l’alleanza dell’elettore del Brandeburgo nella guerra di successione spagnola, concede il titolo regio a Federico III di Hohenzollern, che diviene così Federico I di Prussia. Questo avvenimento sancisce, non solo formalmente, l’ascesa della potenza brandeburghese iniziata nel corso del Seicento durante il lungo regno di Federico Guglielmo I.
Il consolidamento del principato brandeburghese è essenzialmente una conseguenza della dura competizione politica e militare nell’area baltica, e soprattutto della pressione della potenza svedese: proprio il nuovo Regno di Prussia sarà, assieme allaRussia di Pietro il Grande, il principale beneficiario del crollo dell’egemonia svedese nell’Europa settentrionale dopo la sconfitta di Carlo XII di Svezia nella battaglia di Poltava (1709).
All’inizio del secolo, il Regno di Prussia si presenta come un aggregato di territori disomogenei e inframmezzati da altre entità statali. Il nucleo centrale è costituito dal ducato di Brandeburgo, dalla Pomerania orientale e dal Magdeburgo; territorialmente separata è invece la Prussia orientale, e ancora più remoti il ducato di Kleve e la Contea Mark nella Renania, il Principato di Mindene la contea di Ravensberg in Westfalia.
Nel 1713, con il trattato di Utrecht, la Prussia ottiene anche il Principato di Neuchâtel in Svizzera e la Gheldria nei Paesi Bassi. Nel 1721 con la pace di Nystad, che pone termine alla seconda guerra del Nord, la Prussia guadagna laPomerania occidentale, con la città di Stettino.
Federico Guglielmo I e le riforme politiche e militari
Nel 1713 sale al trono Federico Guglielmo I, che si dedica a una intensa opera di rafforzamento e di riorganizzazione dello Stato, soprattutto al fine di migliorarne le capacità militari. La struttura istituzionale e sociale dello Stato prussiano è il risultato di un compromesso fra la monarchia e la nobiltà terriera, raggiunto a spese dei contadini e delle città. In cambio di una sostanziale riduzione della propria autonomia politica, la nobiltà prussiana si vede riconfermata l’autorità giuridica, oltre che economica, sui contadini e trova nell’apparato statale, e soprattutto in quello militare, una fonte di entrate, di prestigio sociale e di legittimazione.
Il culmine dell’opera di riorganizzazione dello Stato operata da Federico Guglielmo I si ha nel 1733 con l’istituzione del General-Ober-Finanz-Kriegs und Domänen-Direktorium, organismo che accentra praticamente tutte le funzioni di governo. Una caratteristica peculiare dello Stato prussiano – e un indice della sua arretratezza – è la grande importanza del demanio regio, che comprende in totale un quinto delle terre e delle foreste.
La riforma dell’esercito riceve particolari attenzioni. Negli anni 1732-1733 tutto il regno viene suddiviso in cantoni, per ognuno dei quali è stabilito annualmente il numero di reclute da arruolare. In sostanza viene creato un sistema di coscrizione obbligatoria di tutta la popolazione rurale, che sostituisce il reclutamento attraverso imprenditori militari privati.
Il secondo cardine della riforma militare è la creazione di un corpo ufficiali efficiente, composto esclusivamente di nobili, nel quale vengono assorbiti soprattutto i cadetti e la nobiltà minore.
Il dispotismo illuminato di Federico II
Federico II sale al trono nel 1740 e prosegue l’opera riformatrice di Federico Guglielmo I, influenzata ora dal pensiero illuminista. Amico personale di alcuni dei principali esponenti dell’Illuminismo, Federico II è forse il più rappresentativo esempio di dispotismo che unisce un’intensa attività di riforma all’intransigente difesa dell’assolutismo monarchico.
La tensione fra riformismo illuministico e assolutismo paternalistico emerge con evidenza nella vicenda della riforma giudiziaria elaborata da Samuel von Cocceji, il quale mira a una evoluzione verso uno Stato di diritto che vede il sovrano subordinato alla legge. Cocceji riesce a portare a compimento le riforme dell’amministrazione della giustizia, ma il suo codice ispirato al diritto romano rimane a lungo lettera morta. L’Allgemeines Landesrecht promulgato nel 1794 costituisce invece un compromesso, in quanto ha un carattere solo sussidiario rispetto alle tradizioni giuridiche delle diverse province.
Federico II si impegna anche in una vasta opera di bonifica dei terreni paludosi e di ripopolamento con la fondazione di nuovi villaggi. La volontà di mantenere un apparato militare in grado di fronteggiare quelli di altri Stati europei sottopone però l’arretrata economia prussiana a una tensione notevole, poiché il potenziale demografico ed economico dello Stato non è paragonabile a quello delle potenze rivali.
La Prussia conta infatti circa due milioni di abitanti: a questa debolezza si cerca di porre rimedio con una politica di sostegno all’incremento della popolazione e di incentivazione all’immigrazione da altri Paesi. Particolarmente importante è l’immigrazione di ugonotti francesi a partire dalla revoca (1685) dell’editto di Nantes.
L’inevitabile compromesso con l’aristocrazia e il conseguente privilegio accordato agli interessi agrari della nobiltà costituiscono un grave intralcio allo sviluppo economico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti manifatturieri e commerciali. Alla fragilità dell’apparato produttivo la monarchia prussiana cerca di sopperire con una politica protezionistica e di sostegno alle attività industriali.
I sussidi statali o l’intervento diretto si concentrano soprattutto sulle produzioni di lusso – porcellane, arazzi – o su quelle connesse alle esigenze militari. I risultati sono comunque modesti anche per la limitatezza del mercato interno, ulteriormente gravato dall’elevata pressione fiscale che colpisce in particolar modo i consumi dei ceti meno abbienti. L’agricoltura rimane dunque il perno economico dello Stato prussiano e in questo campo si registrano effettivamente alcuni progressi, stimolati anche dall’aumento dei prezzi del grano che costituisce il principale prodotto dell’agricoltura.
La Prussia grande potenza
Parallelamente all’opera riformatrice, Federico II dà il via a una politica vivacemente espansionistica grazie al potente apparato militare forgiato da suo padre e da lui a tal punto perfezionato da divenire un modello per tutti gli eserciti europei.
La morte di Carlo VI d’Asburgo, nel dicembre del 1740, e il rifiuto da parte di Federico II di riconoscere la Prammatica sanzione che garantisce la successione al trono della figlia dell’imperatore Maria Teresa, costituiscono il pretesto per l’invasione della Slesia. La Prussia, alleatasi con Francia, Baviera e Spagna, ottiene importanti vittorie a Mollwitz e a Chotusitz. Nel 1742 Austria e Prussia giungono alla pace di Breslavia: Maria Teresa cede la Slesia e ottiene in cambio l’uscita della Prussia dalla coalizione.
Nel 1744 però la Prussia muove nuovamente guerra all’Austria e, con la pace di Dresda del 1745, ottiene definitivamente la Slesia.
Il conflitto austro-prussiano si riaccende nel 1756 nel quadro della guerra dei Sette anni. La posizione della Prussia è estremamente difficile, poiché Federico II si trova a dover fronteggiare gli eserciti di Austria, Francia e Russia.
Grazie alla sua abilità, all’impiego di tattiche innovative e all’addestramento del suo esercito, il sovrano ottiene successi clamorosi contro i Francesi (battaglia di Rossbach, 1757), contro gli Austriaci (battaglia di Leuthen, 1757) e contro i Russi (battaglia di Zorndorf, 1758), ma l’esercito prussiano viene in seguito sconfitto dagli austro-russi a Kunersdorf e la stessa capitale Berlino è occupata dal nemico. La morte di Elisabetta di Russia e l’ascesa al trono prima di Pietro III e poi di Caterina II salvano Federico II da una situazione ormai disperata.
La pace di Hubertusburg del 1763 non comporta modifiche territoriali, ma sancisce, oltre al nuovo ruolo della Russia nell’equilibrio europeo, anche l’ingresso a pieno titolo della Prussia nel novero delle grandi potenze.
Nell’ultimo quarto del secolo la Prussia ottiene nuovi significativi incrementi territoriali. Nel 1772, in occasione della prima spartizione della Polonia a seguito deltrattato di San Pietroburgo, viene annessa la Prussia occidentale che permette il collegamento territoriale fra la Prussia orientale e il Brandeburgo e la Pomerania.
Nel 1786 a Federico II succede il nipote Federico Guglielmo II. Durante il suo regno la Prussia amplia ulteriormente il suo territorio. Nel 1793 (con la seconda spartizione della Polonia) la Prussia si annette parte della Slesia e nel 1795 (con la terza spartizione che decreta la fine dell’indipendenza polacca) la Mazovia con Varsavia.
Nel 1792 la Prussia partecipa alle guerre di coalizione contro la Francia rivoluzionaria e le truppe prussiane sono sconfitte nella battaglia di Valmy. La pace di Basilea tra Francia e Prussia del 1795 prevede l’uscita della Prussia dalla prima coalizione e una serie di aggiustamenti territoriali sul Reno. La Prussia resterà neutrale nelle successive guerre rivoluzionarie e napoleoniche fino al 1806.
© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Riproduzione riservata