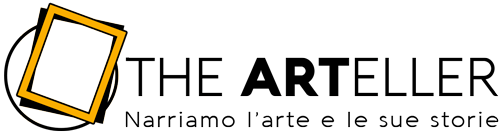E allora, già che ci siamo, buttiamo giù anche il Duomo
Il Castello Sforzesco, ad un certo punto della sua gloriosa vita, rischiò di essere demolito.
Durante un infuocato consiglio comunale di fine ‘800, Luca Beltrami – uno dei protagonisti della nostra nuova storia – lanciò l’idea di abbattere anche il Duomo, naturalmente con spirito del tutto provocatorio.
Già, perché a Milano in quegli anni si sta pensando seriamente alla possibilità di smantellare (almeno in parte) il celeberrimo:
- Castello Sforzesco
quello che oggi è considerato uno dei simboli della città, insieme al Duomo e a Sant’Ambrogio.
Come mai si è potuto arrivare a tanto? Per quale ragione il monumento era così inviso ai milanesi che quando si decise di abbatterlo non mossero neppure un dito?
Nel corso dell’articolo daremo una risposta a queste domande.
Ma prima di narrare le lotte di Beltrami e il suo portentoso progetto di ricostruzione, è doveroso fare un passo indietro. Dobbiamo tornare al tempo in cui nella Rocca di Porta Giovia – questo l’altro nome del maniero – vivevano, governavano e tramavano i Signori di Milano.
Il Castello Sforzesco: scene da un dramma familiare
26 dicembre 1476.
Tra le mura del Castello Sforzesco, una donna si aggira guardinga.
Con lei il figlioletto di appena sette anni.
Cerca di proteggerlo, di metterlo al riparo nel luogo più sicuro del maniero: la Rocchetta, una sorta di fortezza nella fortezza.
Ma cosa è successo? E chi è la donna che tenta di salvare il piccolo, legittimo erede del Ducato di Milano?
Il duca Galeazzo Maria Sforza è stato appena assassinato da tre congiurati durante la Messa nella chiesa di S. Stefano.
L’ormai vedova Bona di Savoia e il piccolo Gian Galeazzo si trincerano all’interno della Rocchetta.
Bona di Savoia piange il marito appena trucidato, teme i congiurati appartenenti alla nobiltà milanese e sa che con buona probabilità tra i mandanti morali dell’assassinio c’è anche il potentissimo re di Francia.
Ma ancor di più teme i cognati. I fratelli di Galeazzo sono assetati di potere.
C’è Ascanio che più tardi scalerà le gerarchie ecclesiastiche fino a diventare cardinale. C’è l’agguerrito Sforza Maria già duca di Bari e pronto a tutto per la conquista del Ducato.
E soprattutto c’è lui: Ludovico il Moro, il quarto figlio maschio di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Ludovico è giovanissimo, in quel momento fatidico ha appena 24 anni.
Ma è scaltro e calcolatore, sa intessere trame ed intrighi. Più tardi sarà uno dei maggiori mecenati dell’arte rinascimentale ma nel frattempo – che sia in maniera lecita o illecita – ha un solo obiettivo in mente: diventare duca di Milano.
Di fronte alla duchessa-vedova e all’erede-bambino, il Moro e la sua terribile ambizione sembrano avere la strada spianata e il Castello Sforzesco è il luogo ideale dove ambientare questa scalata al potere di altri tempi.
Cicco Simonetta: in difesa dello “Stato”
Ma tutto ciò non sarà una passeggiata per Ludovico.
Dalla parte dello “Stato” si schiera il potentissimo segretario generale del Ducato di Milano: Cicco Simonetta.
Facciamo un passo indietro. Quando nel 1450 Francesco Sforza conquista Milano dopo le sollevazioni della Repubblica Ambrosiana, Cicco è già al fianco del condottiero e da quel momento in poi entrerà stabilmente nella stanza dei bottoni con ruoli sempre maggiori.
Quando nel 1466 Francesco muore e gli succede il primo figlio maschio, Galeazzo Maria, Cicco è sempre lì come deus ex machina del potere ducale, e addirittura tutore dei figli del nuovo Signore.
E Cicco sarà lì a difendere il Ducato quando, qualche mese dopo l’assassinio del duca Galeazzo Maria Sforza, i fratelli Ascanio, Sforza Maria, Ottaviano e Ludovico insieme al cugino Roberto Sanseverino tentano una prima congiura nel maggio del 1477.
Cicco con le truppe lealiste resiste all’onda d’urto dei fratelli Sforza e riesce a mandarli in esilio.
Bona di Savoia, dal canto suo, si affretta a rafforzare la Rocchetta all’interno del Castello Sforzesco, fortificandola con una torre poderosa che passerà alla storia come la Torre di Bona.
Ottaviano muore giovanissimo subito dopo questo maldestro tentativo di assalto al potere. Ascanio si ritira dalla lotta politica, interessato più alla carriera nel clero che al titolo di duca, mentre Sforza Maria muore a sua volta nel 1479.
Il Moro è rimasto solo nel tentativo di espugnare il Castello Sforzesco e nella lotta per la conquista del Ducato.
Le sue speranze si vanno affievolendo di giorno in giorno. Cicco sembra ormai avere il pieno controllo della situazione.
Ma le carte in tavola cambiano repentinamente. E questa volta nel modo più inaspettato.
Colpo di scena: il Moro al potere
Nel settembre del 1479 con un improvviso colpo di mano Bona di Savoia fa arrestare Cicco Simonetta, chiama a sé Ludovico e lo nomina co-reggente del piccolo Gian Galeazzo.
Cosa è successo?
Le gradi capacità diplomatiche e dialettiche del Moro hanno finalmente sortito i loro effetti? Oppure è stato l’amante di Bona ad avere un ruolo fondamentale nel voltafaccia della duchessa?
Sono interrogativi forse ancora aperti. Certo è che Ludovico entra a Milano con il minimo sforzo, si insedia nel Castello Sforzesco e nel giro di pochissimi mesi diventa di fatto il signore assoluto della città.
Nei giorni drammatici del suo arresto, Cicco si rivolge a Bona con parole sibilline: “Duchessa Illustrissima, à me sarà tagliato il capo, e voi in processo di tempo perderete lo stato”.
Cicco è profetico ma oggettivo al tempo stesso. Conosce il Moro e sa che la sua ambizione non si fermerà alla mera reggenza del piccolo Gian Galeazzo.
Il Moro vuole il potere, vuole il titolo di Duca, vuole Milano.
Stranamente però Ludovico temporeggia nel far eseguire l’esecuzione capitale di Cicco. Il primo segretario rimarrà più di un anno in carcere e verrà giustiziato solo nell’ottobre del 1480 tra le mura del castello di Pavia.
Negli stessi mesi il Moro allontana da Milano anche Bona di Savoia: la profezia di Cicco è compiuta, Ludovico diventa di fatto il duca di Milano, piazza il suo quartier generale nel Castello Sforzesco e corona il suo capolavoro politico con la conquista assoluta del potere.
Breve storia del Castello Sforzesco
Il Castello Sforzesco non nasce con gli Sforza ma con… i Visconti.
Tra il 1360 ed il 1370 si mette mano alla costruzione della Rocca di Porta Giovia che da quel momento accompagnerà fedelmente la storia di Milano, in un continuo rapporto di amore e odio tra i milanesi e le pietre del Castello Sforzesco.
Gian Galeazzo Visconti – primo duca di Milano dal 1395 – risiede stabilmente lì e si adopera per fare eseguire i primi lavori di ampliamento.
La dinastia dei Visconti dura poco più di 50 anni dalla nomina del primo duca. Nell’anno 1447, tra le mura della Rocca di Porta Giovia, muore senza eredi maschi il terzo e ultimo duca del casato: Filippo Maria Visconti.
La Repubblica Ambrosiana, che tenta di inserirsi nel vuoto di potere, sferra il primo attacco al maniero considerato emblema del potere assoluto dei Visconti.
Ma il tentativo repubblicano durerà pochissimo perché nel 1450 Francesco Sforza entra a Milano e si impossessa del titolo di duca.
Un titolo strappato con i denti, perché Francesco aveva sposato qualche anno prima la figlia di Filippo Maria: Bianca Maria Visconti. Eppure, ciò non bastò per non considerare lo Sforza un mero usurpatore.
Entrando a Milano, lo Sforza aveva giurato che non avrebbe mai ricostruito la Rocca di Porta Giovia. Invece, fin da subito, Francesco mise mano al Castello Sforzesco facendo passare la ricostruzione come mera questione di sicurezza cittadina.
Per dissimulare la ricostruzione ed eliminare il volto severo della Rocca di Porta Giovia, Francesco Sforza chiamò a Milano uno dei grandi architetti del primo Rinascimento fiorentino: Antonio Averlino detto il Filarete. Questi progettò il fronte verso la città, con la celeberrima torre che ancora oggi porta il suo nome: la Torre del Filarete.
Tra poco scopriremo la sua singolare storia.
La dinastia degli Sforza e la Rocca di Porta Giovia
Francesco Sforza e la consorte non abitarono nel Castello Sforzesco che invece divenne residenza stabile del loro primo figlio: Galeazzo Maria Sforza.
Il nuovo duca mise mano alla Rocchetta e alla Corte Ducale, trasformando definitivamente la Rocca di Porta Giovia in maniero signorile.
Con la conquista del potere da parte di Ludovico il Moro, il Castello Sforzesco diventa la quinta scenica della fastosa corte di uno dei massimi signori del Rinascimento italiano.
Ludovico è un grande mecenate.
Durante il suo ducato a Milano operano artisti del calibro di Leonardo da Vinci, che più tardi dipingerà il magnifico Cenacolo, e l’architetto Donato Bramante che – prima di trasferirsi a Roma e mettere mano alla basilica di S. Pietro – lascerà a Milano il coro di Santa Maria delle Grazie, uno dei massimi capolavori dell’architettura rinascimentale.
All’interno del Castello Sforzesco, Leonardo decorerà la Sala delle Asse, mentre Ludovico si farà costruire per sé la cosiddetta Ponticella. Rispetto agli immensi ambienti del castello, si tratta di un piccolo ma elegante edificio posto al di sopra di uno dei ponti che scavalcano il fossato in direzione della Ghirlanda, le mura esterne oggi distrutte.
Nelle stanze della Ponticella – quelle che lui stesso definì stanzette negre – Ludovico il Moro si ritirò per piangere la morte della consorte: la Duchessa Beatrice d’Este.
Dal Moro allo straniero
Ma il tempo di Ludovico non è destinato a durare a lungo.
I continui cambi di alleanze e i relativi tradimenti avranno un impatto micidiale su di lui e sul Ducato di Milano.
Nel 1499, il Re di Francia Luigi XII invade il Ducato.
Mentre Ludovico cerca di radunare truppe all’estero per tentare di arginare i francesi, a Milano il castellano Bernardino della Corte spalanca le porte del Castello Sforzesco agli invasori.
Termina così l’epopea degli Sforza e il ducato di Ludovico: è la fine di un’epoca!
Leonardo esprime con parole chiare ed esemplari la fine del Moro: “Il duca perso lo stato e la roba e la libertà e nessuna sua opera si finì per lui”.
I primi due decenni del ‘500 sono convulsi.
Anche il Castello Sforzesco subisce un danno irreparabile: nel 1521 la Torre del Filarete salta letteralmente in aria.
Si tratta di un fulmine? O forse la disattenzione di un soldato? La seconda ipotesi sembra essere quella più attendibile.
Luca Beltrami – tra poco scopriremo il suo ruolo fondamentale – nel suo libro “Guida storica del Castello di Milano (1368-1894)” afferma che:
“Circa la causa della catastrofe, anziché la versione di un fulmine a ciel sereno, si presenta più attendibile la ipotesi che alcuni barili di polvere che si stavano trasportando fuori del Castello in quel momento, per essere spediti ad altre fortezze, abbiano preso fuoco, per incuria di coloro che ne effettuavano il trasporto”.
I dominatori – francesi prima, spagnoli poi e austriaci in ultimo – trasformarono il Castello Sforzesco nella cabina di regia dell’odiata oppressione straniera.
Dopo la parentesi napoleonica, l’apice dell’odio verso i dominatori, e verso il Castello Sforzesco, si ebbe nel 1848: gli austriaci durante le Cinque Giornate sparano con i cannoni sulla folla mentre nelle segrete del maniero vengono reclusi un gran numero di milanesi.
Luca Beltrami: colui che salvò il Castello Sforzesco da morte certa
Quando – dopo secoli di dominazione straniera – l’Italia diventa indipendente, a Milano il Castello Sforzesco non è per nulla amato. E qui ritorniamo all’inizio della nostra storia.
Siamo negli anni ottanta del 1800.
Milano è una delle città di punta del nuovo stato unitario, è il centro finanziario ed economico. È una città in forte espansione e ha bisogno di nuove case per esprimere al meglio il ruolo che le spetta.
Viene avanzato il progetto di un’immensa lottizzazione che avrebbe unito corso Sempione con piazza Cordusio. Peccato che nel bel mezzo di questo tracciato si trova proprio il Castello Sforzesco.
E a quel punto si avanza la scioccante proposta: demolire parte delle mura della Rocca di Porta Giovia.
Il nuovo tracciato stradale avrebbe tagliato in due il Castello Sforzesco, incuneandosi tra la Rocchetta e la Corte Ducale.
Nessuno dei milanesi batte ciglio. Nessuno si oppone a questa idea balzana e spregiudicata.
La Rocca di Porta Giovia non gode di ottima salute, è deturpata e semidistrutta da secoli di utilizzo improprio. Ma soprattutto è ancora identificata come il centro del potere dell’oppressione straniera.
Non sono passati nemmeno 40 anni dai tragici eventi delle Cinque Giornate, eventi che sono ancora freschi nella memoria dei nonni milanesi, che raccontano ai nipoti i tragici fatti di quei giorni terribili.
Il Castello Sforzesco non è amato dai milanesi. Nel disinteresse generale si leva la voce solitaria ma potente di Luca Beltrami: architetto, storico, politico, figura poliedrica a tutto tondo – più tardi sarà anche direttore del Corriere della Sera e senatore del Regno.
Con un’azione testarda e perentoria riesce a far apporre il vincolo culturale sul Castello Sforzesco, scongiurando l’abbattimento parziale della Rocca.
Dalla salvezza alla ricostruzione
Ma l’attività di Beltrami non si ferma alla salvaguardia delle pietre esistenti.
Beltrami sogna il Castello Sforzesco come era ai tempi del Moro.
Il restauro viene avviato tra il 1893 e 1894.
Tutti i luoghi simbolo vengono ripristinati nel loro antico splendore: si mette mano alla Rocchetta, viene ricostruita in parte la Torre di Bona. Poi tocca alla Corte Ducale e alla Ponticella del Moro.
Manca solo l’elemento principale.
Pensandoci bene, la Torre del Filarete non è rimasta in piedi nemmeno un secolo. Eppure sembra essere essa stessa il Castello Sforzesco: c’è una forte sovrapposizione nella memoria tra la Torre e la Rocca di Porta Giovia.
Beltrami non indugia nemmeno un momento: la Torre del Filarete deve essere ricostruita.
Ma come farlo? La ricerca storica dà pochi frutti. Ad aiutare Beltrami ci sono solo due documenti: un quadro eseguito da un allievo di Leonardo ed un dipinto sul muro di una cascina. In entrambi la Torre appare com’era.
I lavori iniziano nel 1900.
Procedendo a ritmo serrato, nel 1905 la Torre viene terminata.
Dedicata al Re Umberto I, con i suoi 70 metri di altezza la struttura è ancora oggi per tutti i milanesi e per il mondo intero la Torre del Filarete.
Il lavoro visionario di Beltrami non solo ha riconsegnato a tutti noi un monumento quasi distrutto, ma ha permesso di stipulare una tregua di lunga durata tra la Rocca di Porta Giovia e i cittadini.
Oggi il Castello Sforzesco è la sede di fantastici musei, prestigiose collezioni e somme istituzioni come la Biblioteca Trivulziana.
Il Castello Sforzesco è uno dei massimi simboli della città di Milano e la Torre del Filarete si staglia bonaria a sancire la riappacificazione tra le sue mura e i milanesi.