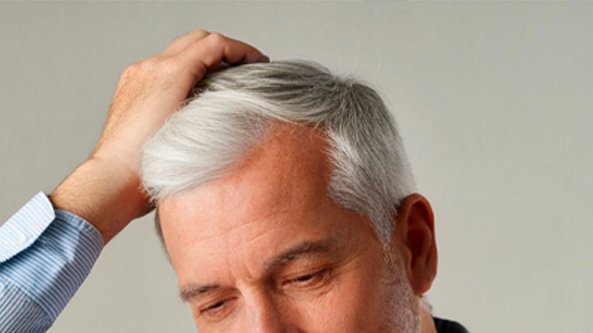Per l’immaginario collettivo, la dinastia inizia a Villar Perosa con Giovanni Agnelli, il «fondatore», nato in Val Chisone il 13 agosto 1866, in un’elegante tenuta di campagna acquistata qualche anno prima: sono ancora di là da venire la Fiat e le vetture a motore, il mondo si sposta con i barrocci e i treni che bruciano carbone, le proprietà agrarie sono l’investimento predominante e l’imprenditoria industriale rappresenta più la prospettiva futura che il presente.
Ma nella storia (e a maggior ragione nella storia di una famiglia) ogni inizio è, contemporaneamente, l’approdo di un percorso precedente. Chi e che cosa c’è dietro il «fondatore»? Alcuni spunti sono stati proposti dagli studiosi nel corso degli anni, con ricerche che giungono sino al XVII secolo. Sappiamo così che gli «Agnelli» erano verosimilmente originari di Priero, vicino a Ceva, dove erano chiamati «Nielli»; che all’inizio del Settecento si erano trasferiti a Racconigi, acquisendo la denominazione di «Agnelli»; che all’attività agricola associavano quella commerciale. A trasformare gli spunti in una ricostruzione organica provvede ora un testo di Giulia Ajmone Marsan, Aniceta&Edoardo, appena edito dal Centro Studi Piemontesi. Fondato su una solida documentazione d’archivio, ben impostato e di facile lettura perché scritto in forma fruibile (qualità rara nella saggistica storica), il volume si sofferma sui genitori del «fondatore», Edoardo (1831-1871) e Aniceta Frisetti (1845-1920) e sul nonno paterno, Giuseppe Francesco (1789-1866). Ne risulta il ritratto dell’imprenditoria torinese nei decenni dei suoi esordi, in un intreccio di intuizioni, contatti, prudenze, sperimentazioni, alleanze, con alcune «fortune» che si affermano in fretta ed altre che altrettanto in fretta sfumano.
Il nonno Giuseppe Francesco, nativo di Racconigi, si forma nel Piemonte napoleonico, inizia l’attività nella stagione tormentata della Restaurazione, si afferma in quella propulsiva del Risorgimento: decenni di fermento politico, ma anche di trasformazioni socio-economiche, che offrono opportunità a chi ha intraprendenza e capacità innovativa. Giuseppe Francesco è prima «fondachiere» (venditore all’ingrosso di materie prime per medicinali e spezie), poi raffinatore di zucchero (attività che negli anni Trenta del XIX secolo conosce un particolare sviluppo nel Regno di Sardegna), quindi commerciante di seta e «banchiere» (perché le «negoziazioni di sete gregge e lavorate fuori di Paese sempre hanno da intingere nelle operazioni di banco», come si legge in una Descritione di Torino del 1840). In accordo con altri imprenditori con i quali costituisce una delle prime società per azioni piemontesi, in strette relazioni con investitori esteri come i ginevrini De Fernex, attento alle novità tecnologiche, Giuseppe Francesco combina gli azzardi delle attività industriali con le sicurezze degli investimenti agrari: il 17 febbraio 1853 egli acquista così la casa («il Castello») e la tenuta di Villar Perosa, 115 ettari con quattro cascine, mulino e filatura. A vendere sono i marchesi Turinetti di Priero e la transazione assume carattere emblematico: l’indebolimento finanziario dell’aristocrazia piemontese (quella che, a differenza dei Benso o dei D’Azeglio, non ha saputo attrezzarsi per le nuove sfide) apre la strada all’affermazione delle classi sociali legate alle professioni e ai commerci.
Un gruppo emergente significa un sistema nuovo di relazioni che si consolida e lo si vede bene nel matrimonio tra Edoardo (l’ultimogenito di Giuseppe Francesco) e Aniceta Frisetti. Il matrimonio è celebrato nel Duomo di Torino il 23 aprile 1863, lui trentaduenne e lei diciottenne: testimoni sono i rispettivi padri, a dimostrazione che si tratta di un’alleanza matrimoniale (anche se i due sposi si sono scelti liberamente). I Frisetti sono una famiglia originaria di Orbassano, radicata nel mondo commerciale, in particolare nel settore del cotone, e prima ancora sono stati produttori di colla forte (utilizzata per rendere i fogli impermeabili all’inchiostro) e fornitori della Stamperia Reale. Da due generazioni si sono trasferiti a Torino e vivono in via San Maurizio 3 (all’epoca, il tratto di via XX Settembre tra via Santa Teresa e via Monte di Pietà); Giuseppe Francesco Agnelli gestisce invece i suoi affari da uno stabile di piazza San Carlo, qualche isolato più in là. Famiglie «rampanti», frequentazioni e affari comuni, benestanti che non vogliono adagiarsi sul successo ottenuto ma proiettarsi nel futuro. Alla morte del padre, Edoardo eredita un patrimonio che lo pone tra i cinque borghesi più ricchi di Torino e vive con Aniceta in un prestigioso appartamento di via Cernaia; egli gestisce le attività con oculatezza, si affaccia nell’amministrazione pubblica (consigliere comunale in Val Chisone), gli viene riconosciuta competenza nelle questioni finanziarie, ma muore appena quarantenne nel 1871. A mantenere intatto il patrimonio è la vedova, Aniceta, in quanto «legal amministratrice» dell’unico figlio vivente, Giovanni il fondatore, che raggiunta la maggiore età assume il controllo delle attività. «Tutto ciò che accade dopo – come scrive l’autrice concludendo il volume - non è più storia di famiglia ma storia d’Italia».