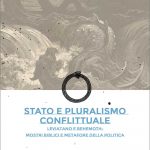Leviatano
Leviatanodi Thomas Hobbes
«La tesi di fondo del Leviatano è che l’intera struttura di una ordinata vita associata è resa possibile solo dalla politica, e non dalla morale tradizionale, né dalle teologie, e neppure dalla nascente economia. Da una politica assoluta e autonoma, scientificamente atteggiata, che ha in sé la forza di lasciarsi investire dalle questioni e dalle ragioni della morale e della teologia, e di reinterpretarle, che le assume in sé, che non se ne lascia fondare. Certo, Hobbes è l’eponimo di una politica categorialmente diversa e opposta rispetto a quella di Machiavelli, di una politica che segna di sé, istituzionalmente, la fase centrale e matura della modernità, l’età dello Stato – mentre quella dell’italiano è una politica laterale, centrata sul dinamismo delle contese più che sulla loro neutralizzazione, e più sul potere che sulla ragione, e come tale, pur di enorme importanza nella storia del pensiero politico moderno, non è del tutto a suo agio nella dimensione della statualità e della cittadinanza, che ha la propria matrice nel razionalismo politico hobbesiano e nel suo disegno di neutralizzare giuridicamente il conflitto. Il Centauro differisce dal Leviatano perché li separa l’Idra furiosa delle guerre civili di religione, che hanno divampato in Europa per quasi un secolo e mezzo, la malinconia della crisi dell’Umanesimo, la scoperta del Nuovo Mondo in America, e la nuova energia ribelle del soggetto protestante. Eppure, come Machiavelli aveva fatto della politica il primum, portandola a coincidere con la sorgiva energia dell’azione alla ricerca della gloria e del potere, così Hobbes fa della politica, come scientifica soddisfazione della richiesta di ordine che nasce dalle stesse vite umane, sempre bisognose di tutela, una dimensione originaria, non preceduta da istinti comunitari, da metafisiche, da teleologie, da tradizioni giuridiche, dalla sia pur spregiudicata interpretazione della «lezione delle cose antique». Due diversi primati della politica, due diverse rotture con il passato, due diverse architetture intellettuali.
Soprattutto, a differenza da Machiavelli, Hobbes associa la filosofia alla politica in modo nuovo ma del tutto cogente. Eppure la sua non è una deduzione della politica dalla filosofia; è piuttosto l’intrinseca e originaria politicità della filosofia moderna: le idee di Hobbes sul mondo (il suo materialismo atomistico, la sua epistemologia nominalistica) e sull’uomo (l’antropologia, le passioni) sono strutturate intorno a un’unica questione che le fonda: la questione dell’ordine; una questione alla quale viene ridotta tutta la politica, una questione che occupa tutto lo spazio politico, ridisegnandolo e semplificandolo more geometrico. Hobbes, insomma, fa della politica l’altro volto della filosofia, e di entrambe fa la risposta a un problema concreto: una risposta non spiritualistica come quella di Cartesio, né trascendentale come quella di Kant, ma nata dalla domanda stessa; se il problema, il punto di partenza, è il disordine (la materia in movimento senza un fine, la non umanità dell’esperienza del mondo, la sua intrinseca instabilità), allora la risposta di Hobbes (la sua filosofia politica) consiste nell’individuare, nella nuova desolata immagine del mondo e cioè nella natura stessa – nella natura umana, che della natura fisica fa parte (l’assunto politico che sta alle spalle dell’isomorfismo tra fisica e politica è la non eccezionalità qualitativa dell’uomo) –, i movimenti che vanno verso una possibile, benché transitoria, soluzione stabilizzante, verso un’utile pausa del movimento eterno della materia. Quel movimento è lo stato di natura; quella pausa è lo Stato. Lo scetticismo, qui, è vinto con il costruttivismo. […]
Nel Leviatano tutto ciò è più chiaro che in ogni altra opera di Hobbes – ed è per questo che è il suo capolavoro. Qui la semplificazione a cui Hobbes aspira – il gesto di tagliar via le costruzioni intellettuali e politiche del passato – ha vita propria; il movimento di distruzione e di ricostruzione si sostiene da sé. Se la politica di Machiavelli è immediatezza, quella di Hobbes è una mediazione immediata, una macchina che è politica già nel suo progetto, e che nello svolgersi si arricchisce di materie e di ragioni, così da dare un’immagine di concretezza superiore a quella che danno altre opere hobbesiane. […]
Fra le grandi immagini e i grandi scenari in cui si articola la nuova narrazione scientifico-politica spicca fin dall’inizio l’emblema del Leviatano, mito biblico (che ha grande spazio nel Libro di Giobbe) riferito a un terrificante mostro marino – invincibile e minaccioso –, di per sé una balena o un coccodrillo, ma simbolo dell’onnipotenza creatrice di Dio (e poi traslato, nel cristianesimo, a indicare il diavolo o l’anticristo), che nel frontespizio, suggerito dallo stesso Hobbes, si presenta però in modalità tutt’altro che mostruose, come un grande uomo incoronato che regge nelle mani spada e pastorale a proteggere un pacifico paesaggio; un uomo che non è un uomo, ma una silhouette, un perimetro, un confine chiuso in forma di figura, la cui superficie interna è composta di tanti uomini che lo fissano in volto; uomini – anzi, cittadini – che solo il contorno del grande uomo riesce a fare stare uniti. Il sovrano non è un’entità in sé consistente (benché, certo, sia efficace nel far coesistere gli uomini); ovvero, del Leviatano biblico e cristiano non resta, nell’intento di Hobbes, nulla di sostanziale – non certo la mostruosità tremenda né la diabolicità –; resta un nome, che nella cultura del tempo non significava più nulla di inquietante se non (anche ironicamente) un’iperbolica grandezza; un nome che in seguito sarebbe divenuto infamante ma che certo non lo voleva essere per Hobbes. Soprattutto, restano – ed è questa la spiegazione del titolo celeberrimo –, le funzioni e le caratteristiche del mostro biblico, attribuite ora al grande uomo (allo Stato che fa esistere in pace e uniti i cittadini): esplicitamente citata nel frontespizio è la suprema potenza (non est potestas super terram quae comparetur ei); nel corso dell’opera si trovano altre stringenti e puntuali analogie fra il Leviatano biblico e il nuovo Stato razionale, che cioè questo, come quello, non soffre la paura, che domina i superbi, e che con esso non si possono stringere patti. Dalla mostruosità alla civiltà perfezionata, dalla bestia al grande uomo e ai cittadini: questa reinterpretazione del materiale intellettuale e immaginario della tradizione, questa nuova narrazione e questo nuovo orizzonte sono, per la loro forza di sintesi, per la loro chiarezza che si accompagna all’allusività – seria e ironica al contempo –, la più straordinaria invenzione del libro. Il gusto barocco dell’emblema manda qui il proprio messaggio più radicale: siamo in un mondo nuovo, duro ma razionale, che si fa beffe del vecchio, asservendolo a nuove logiche e a nuovi fini. […]
Lo stato di natura è l’altra immagine, l’altra scena, in cui i concetti della scienza politica sono organizzati, anzi la scena primaria su cui si snoda e si struttura l’intera costruzione politica hobbesiana. È, questo, l’insieme delle relazioni che intercorrono fra gli uomini così descritti, mossi solo dalla disperata volontà di vita, di potere e di piacere individuale, poiché nulla di collettivo o di comune esiste in natura: questa volontà è lo ius naturale, il diritto di tutti su tutte le cose, la libertà naturale, la volontà di vita di ciascuno; in uno scenario di uguaglianza radicale anche fra i sessi (cioè un’uguaglianza quantitativa, di forze e d’intelletto; le qualità morali, le virtù, le eccellenze non fanno parte del quadro), di scarsità dei beni (una scarsità reale, ma soprattutto derivante dalla convergenza competitiva di tutti su tutti i beni), di mancanza di comunicazione razionale fra gli uomini (la diffidenza, la mancanza di ragioni perché ci si possa fidare gli uni degli altri), di conflitto (la guerra – almeno come possibilità costante – di tutti contro tutti) causato sia da questi fattori (riconducibili all’utilità) sia da quello, ancora più indeterminante e destabilizzante, che è la «vanagloria» (la considerazione di sé superiore a quella che gli altri sono disposti a concedere, da cui nasce la pretesa che gli altri mutino il loro giudizio; è anche per domare questa superbia che nasce il Leviatano); una impotente volontà di potenza, un conflitto improduttivo, dunque, che va neutralizzato, non avendo in sé alcun possibile sviluppo nella direzione dell’energia politica.»