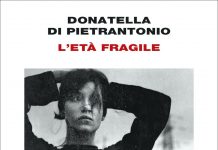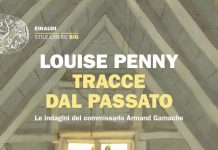Scritto nel 1892, Il costruttore Solness ha per protagonista un costruttore che si trova a combattere coi fantasmi del suo passato nel momento in cui l’arrivo di una giovane donna, Hilde, gli ricorda un episodio di dieci anni prima (quando lei, poco più che bambina, venne da lui baciata con trasporto). L’episodio era stato da Solness dimenticato (ma si tratta di una fantasia della ragazza o di un ricordo rimosso dall’uomo?). Nel dialogo con Hilde, Solness si trova così a ripercorrere alcune tappe della sua vita, tra cui l’incendio che, distruggendo la casa della moglie, diede origine alla sua fortuna economica e, contemporaneamente, distrusse le possibilità di felicità sue e della moglie. Il costruttore Solness è dunque un lavoro che si pone al crocevia tra la possibilità di letture dell’opera di Ibsen in chiave psicoanalitica e le letture che pongono l’attenzione sull’analisi di rappresentanti esemplari del capitalismo dell’epoca (Solness si trova impegnato anche nel rapporto conflittuale con un suo giovane dipendente che vorrebbe emanciparsi e rendersi autonomo).
I lavori dell’ultimo Ibsen (Il costruttore Solness, Il piccolo Eyolf, John Gabriel Borkman, Quando noi morti ci destiamo), hanno spesso suscitato “perplessità e riserve sia sotto l’aspetto formale che sotto quello dei significati, che appaiono sfuggenti e contradditori a molti” (G. Antonucci, Introduzione, in I capolavori, Newton Compton, p. XVI) e per questo sono oggi molto meno rappresentati di quelli della fase precedente del drammaturgo norvegese.
Trifirò ambienta l’azione in una scenografia ridotta ai minimi termini: una poltrona e un cubo su cui sedersi, una scala che compare nel terzo atto a rappresentare le impalcature su cui Solness sale e da cui cade. I costumi sono contemporanei e privi di particolari connotazioni. Sul piano visivo lo spettacolo è caratterizzato in particolare dai fondali trasparenti che rendono talvolta visibili personaggi che non partecipano all’azione principale, e dai marcati cambi di luce (che, per esempio, disegnano pesanti ombre quando Solness rievoca l’incendio). Riguardo alle trasparenze – espediente che consente di rappresentare i condizionamenti degli altri, in qualche modo sempre presenti anche quando non ci sono fisicamente, e la frequente presenza nei testi di questo autore dell’azione dell’origliare (cfr. R. Alonge, Istruzioni per l’uso, in Drammi moderni, Rizzoli, p. 11) –
le avevamo trovate già in altre messinscene ibseniane. È il caso, ad esempio, di Spettri diretto da Cristina Pezzoli, che ne otteneva quadri visivamente suggestivi. Qui, invece, realizzate con pesanti teloni in plastica, risultano visivamente piuttosto grossolane.
Sul testo, la drammaturgia di Trifirò interviene in modo deciso (non esitando, ad esempio, ad eliminare due personaggi come il dottor Herdal e, soprattutto, la moglie Aline, la cui presenza è solo evocata – per esempio, al termine della scena tra Solness e Kaja, in cui la didascalia “crolla davanti a lui” è letta dal regista in modo da lasciar intendere una fellatio, analogamente a quanto avveniva nella messa in scena di Beppe Navello del 1999). In tal modo, lo spettacolo procede speditamente e con ritmo scorrevole, ma finisce anche per ridurre l’originale complessità dell’opera.
Il costruttore Solness di Henrik Ibsen
Drammaturgia e regia: Roberto Trifirò
Con Roberto Trifirò, Sonia Burgarello, Luigi Rausa, Elisabetta Scarano
Scene e costumi: Alessandro Rosso
Progetto in collaborazione con Teatro MA
Produzione Teatro Filodrammatici
Al Teatro Filodrammatici di Milano dal 2 al 14 aprile 2013