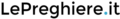I Dieci Comandamenti rappresentano il fondamento della morale nella Bibbia che regola il rapporto di Alleanza tra Dio e l’uomo nel Vecchio Testamento.
Gli studiosi biblici affermano che la coscienza religiosa del popolo d’Israele concepisce Dio non solo come il Creatore, ma anzi tutto il Dio della Parola. Colui che si rivela all’uomo attraverso un’interpellanza morale. I comandamenti per ciò diventano per gli Ebrei non solo delle norme materiali di azione, ma intendono identificare una disposizione di fondo che si traduce in un atteggiamento di fiducia ed obbedienza verso Dio. Da applicare in tutti campi dell’agire.
Il Decalogo non rappresenta quindi un mero elenco di obblighi da osservare, ma vuole, nella libertà personale, orientare il percorso di vita verso un’espressione di fede in un solo Dio.
Cenni Storici
Secondo la tradizione cristiana, i Comandamenti – chiamati anche Legge Mosaica o sinaitica – sono le Dieci Parole scritte da Dio sul Monte Sinai, portate da Mosè in tavole di pietra a tutto il popolo ebraico che si trovava nel deserto.
Siamo intorno al XII sec. a.C.
Queste tavole furono poi conservate gelosamente nell’Arca dell’Alleanza, luogo della presenza di Dio in mezzo al popolo, ma successivamente andate perdute nella distruzione del Tempio di Gerusalemme. Le Dieci Parole furono quindi tramandate oralmente di padre in figlio e poi nel VIII sec. a. C., e scritte in due libri dell’Antico Testamento:
- Esodo
- Deuteronomio
La tradizione ecclesiale ha riconosciuto al Decalogo un’importanza e un significato fondamentale. Infatti appare in epoca patristica con un valore di formula di fede da S. Ireneo che li cita nella sua opera Adversus Haereses, e Sant’Agostino che impartisce lezioni di catechesi ai battezzandi e ai fedeli, inerenti lo studio dei comandamenti e la rilevanza che hanno su tutto il dato di fede.
Nel XV sec. si prese l’abitudine di insegnare i precetti in formule e in rima per facilitarne la memorizzazione, ancora in uso oggi. La Chiesa, attraverso i concili della sua storia, soprattutto quello di Trento (1545-63) e il Vaticano II (1962-65), hanno recepito questo aspetto proclamando l’obbligatorietà del Decalogo per i cristiani, nell’osservanza dei precetti necessari alla salvezza, in quanto portatore privilegiato della legge naturale (Lumen Gentium n.24 C.Vat.II).
Le Versioni
Esistono varie versioni dei Dieci Comandamenti, in quanto ognuna delle tre religioni monoteiste li ha diversamente interpretati e redatti, sebbene l’originale ebraico ne sia alla base .
Nel secondo millennio cristiano, si è provveduto però ad una nuova formulazione per facilitare l’individuazione delle fondamentali citazioni bibliche allo scopo di favorire sia l’aspetto mnemonico sia quello catechetico ed è la formula più conosciuta.
Il testo del Decalogo si trova all’interno della Bibbia dell’A.T. nel Libro dell’Esodo (20,2-17) e nel Deuteronomio (5,6-21). Si distinguono per sottigliezze esteriori ma la sostanza risulta la stessa:
I Dieci Comandamenti nell’Esodo
Nel libro dell’Esodo, il Decalogo fa parte del grande complesso storico e letterario dell’Alleanza del Sinai, nel quale occupa un posto centrale.
Dalla posizione dei versetti, gli esegeti hanno stabilito che venne introdotto in epoca posteriore rispetto alla narrazione già formata e collocata. Questa circostanza sottolinea inoltre l’intenzione dell’autore sacro di porre il Decalogo in stretta relazione con gli avvenimenti storici del Sinai e dimostrare che è veramente il documento dell’Alleanza.
Nel complesso il Decalogo appare qui chiaramente come il documento ufficiale dell’Alleanza. L’espressione fondamentale dell’elezione d’Israele, dove al cui interno il Decalogo è disegnato frequentemente come Parole dell’Alleanza, Clausole dell’Alleanza, Dieci Parole (Es 34,27-28) e, più ancora, Libro dell’Alleanza (Es 24,7).
I Dieci Comandamenti nel Deuteronomio
Il Deuteronomio raccoglie gli elementi già formulati anteriormente e li presenta sottoforma di catechesi sulla Legge al popolo, nel corso di cerimonie e liturgie allo scopo di esortarlo verso i precetti dell’Alleanza.
Gli avvenimenti passati vengono rivisti, in questo contesto, per scoprirne la volontà attuale di Dio su come Israele deve vivere il patto di elezione e promessa.
Il documento in esame è inserito al capitolo V e occupa una posizione all’inizio del secondo discorso di Mosè, nel momento storico del rinnovo dell’Alleanza, in cui il condottiero di Dio spiega la Legge divina; insistendo sul senso del primo comandamento: Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me. Inoltre nel libro viene descritto quando Mosè riferisce agli Ebrei sia il modo in cui Dio gli si è rivelato sia il modo in cui materialmente Dio stesso ha scritto sulle due tavole di pietra la Legge che regolava da quel momento in poi la sua storia con la storia dell’uomo (Dt 5,2).
Quali sono i Dieci Comandamenti
Il Decalogo come viene presentato in ambito cattolico in forma ridotta e nella sua struttura più nota, redatta dal Catechismo della Chiesa secondo le disposizione di papa S. Pio X, è il seguente:
(Ascolta Israele!) Io sono il Signore Dio tuo:
- Non avrai altro Dio all’infuori di me.
- Non nominare il nome di Dio invano.
- Ricordati di santificare le feste.
- Onore il padre e la madre.
- Non uccidere.
- Non commettere adulterio (o atti impuri).
- Non rubare.
- Non dire falsa testimonianza.
- Non desiderare la donna d’altri.
- Non desiderare la roba d’altri.
Periodo
Sull’età riferibile al documento gli esegeti mostrano alcune discordanze.
La maggioranza propende verso l’origine mosaica del Decalogo. L’essenziale è comunque tener conto che i comandamenti rappresentano un testo relativo alla più antica tradizione di Alleanza, risalente già al sec. XII a.C., cioè al tempo dell’Esodo (1270- 1240 a.C.).
Le tavole costituiscono un’unità organica della Legge Divina, per cui ogni “parola” rimanda a tutto l’insieme. Questo sta a significare che trasgredire ad un comandamento porta ad una trasgressione di tutta la legge naturale.
L’autore del Decalogo è Dio come ci viene riferito da Mosè nel Deuteronomio (5,22) che ha inciso le Tavole con la luminescenza della Parola divina da una parte all’altra così da poter essere lette davanti e sul retro e allo stesso modo su entrambi i lati.
Stai cercando una lettura sui Dieci Comandamenti adatta ai bambini?
10 Comandamenti: spiegazione
I dieci comandamenti sono suddivisi in due gruppi: i primi tre secondo le esigenze dell’amore a Dio e gli altri sette relativi all’amore verso il prossimo.
Primo Comandamento
“Io sono il Signore tuo Dio: Non avrai altri dei di fronte a te”
Questo comandamento occupa un posto privilegiato nel Decalogo, in quanto Jahvè vuol essere il Dio unico d’Israele, rivendicando per sé il rispetto, la fedeltà, l’amore senza consentire di condividerlo con gli idoli in cui spesso il popolo ha creduto.
Secondo Comandamento
“Non nominare il nome di Dio invano”
Dio ha rivelato il suo nome a Mosè (Es 13,3) e per mezzo di lui a tutto Israele consegnando così sé stesso. Per questo chiunque invochi il Suo nome, sa che può contare sul suo soccorso, ma l’impiego abusivo, non cultuale o profano di Jahvè è dunque formalmente proibito, come proibito il giuramento falso dato nel nome divino.
Terzo Comandamento
“Ricordati di santificare le feste”
Il comandamento insiste nel carattere religioso e sacro del sabato, come giorno da dedicare al Signore, cioè sottrarlo agli usi profani e collocarlo in relazione esclusiva con Dio con la conseguenza di distinguerlo dagli altri giorni. Questa esigenza è in riferimento agli eventi legati ai giorni della creazione, alla schiavitù in Egitto e al tempo dell’ esilio babilonese dove Israele ricorda le grandi opere salvifiche compiute di Jahvè.
Quarto Comandamento
“Onora tuo padre e tua madre”
Qui si attribuisce ai genitori un valore speciale, trasferendoli al dominio del sacro, dato che il comandamento li pone in relazione diretta con Jahvè, in quanto strumenti di Dio creatore e fonte di vita e come garanzia di edificazione e di sopravvivenza della comunità.
Quinto Comandamento
“Non uccidere”
La vita umana è sacra perché viene da Dio e appartiene a Lui, ed è il più grande dono che Dio ha fatto nel momento della creazione. Viene condannato dunque tutto ciò che chiamiamo omicidio o assassinio, cioè la morte di un membro della famiglia umana. Anzi qui si afferma la necessità di contribuire al sostentamento della vita del prossimo.
Sesto Comandamento
“Non commettere adulterio o atti impuri”
Nella legge di Mosè non c’era niente che proibisse formalmente all’uomo relazioni con donne sposate o non; le relazioni extraconiugali non costituivano adulterio, come invece accadeva per la donna. Il Decalogo pone fine a questo aspetto considerando l’adulterio come attentato verso la Legge di Jahvè equiparandolo ad una impurità legale. Il comandamento sta anche a significare il simbolismo di fedeltà tra Dio e Israele che deve essere legato indissolubilmente all’Alleanza.
Settimo Comandamento
“Non rubare”
Il settimo comandamento non solo proibisce il furto dei beni materiali, ma di fatto protegge e garantisce la libertà dell’uomo e ne vieta la riduzione della sua dignità preservando i diritti fondamentali della persona umana.
Ottavo Comandamento
“Non dire falsa testimonianza”
Non è la menzogna come tale che cade sotto la proibizione del comandamento, ma solo la falsa testimonianza utilizzata per danneggiare la reputazione di un’altra persona. Sotto l’aspetto positivo, il comandamento obbliga ognuno ad essere un testimone di verità al servizio della giustizia e del rispetto dei diritti del prossimo.
Nono Comandamento e Decimo Comandamento
Non desiderare la roba d’altri” e “Non desiderare la donna d’altri”
Questi due comandamenti, che sono strettamente legati in quanto proibiscono nella loro origine la realizzazione esteriore di un desiderio, deplora le manovre affettive finalizzate al possesso dei beni del prossimo. Anche qui si viene a proteggere i diritti fondamentali della persona umana perché il peccato non ha solo inizio nell’istante in cui si commette adulterio o si sottrae ingiustamente la proprietà altrui, ma scaturisce già dagli stati d’animo interiori.