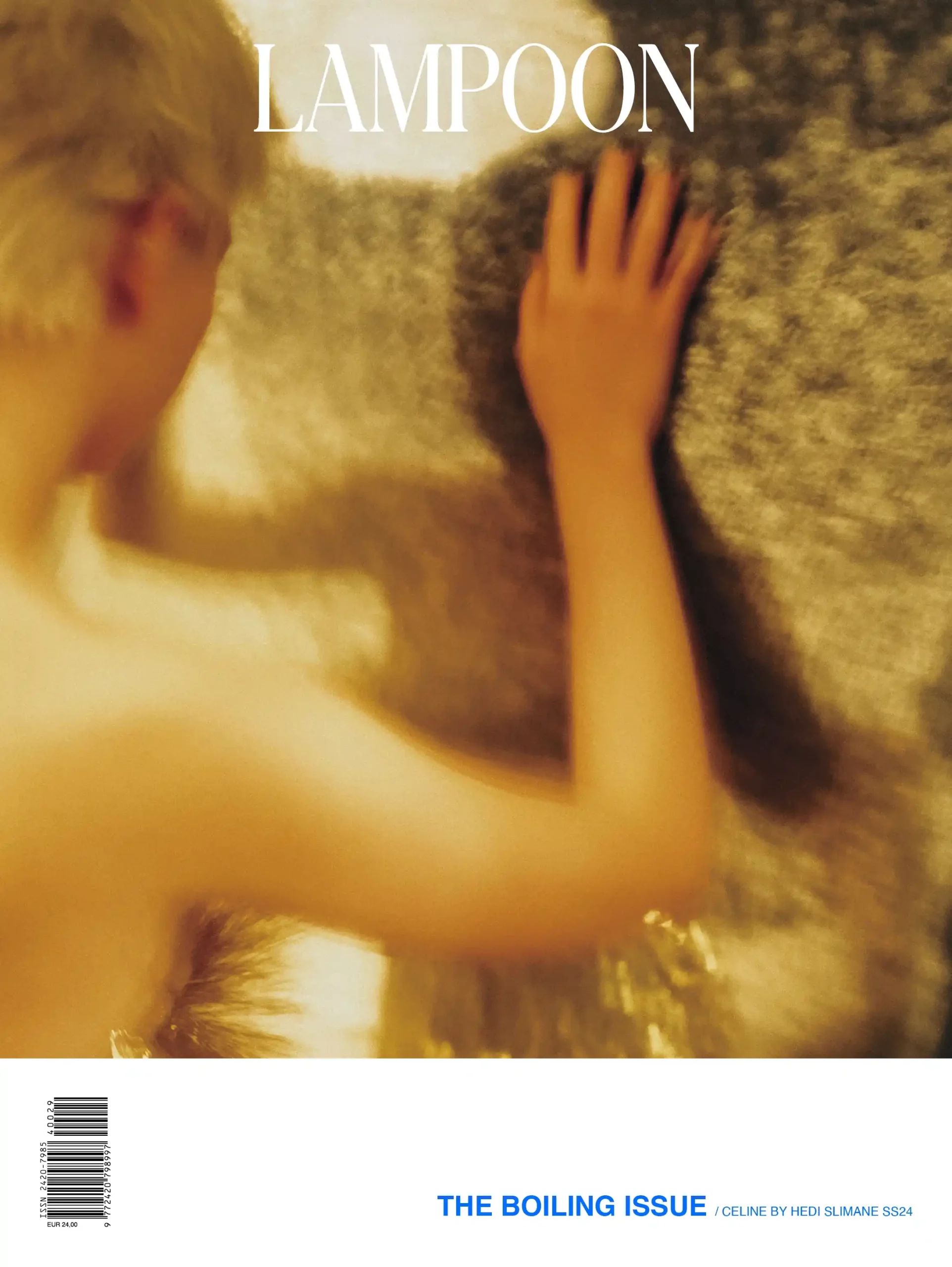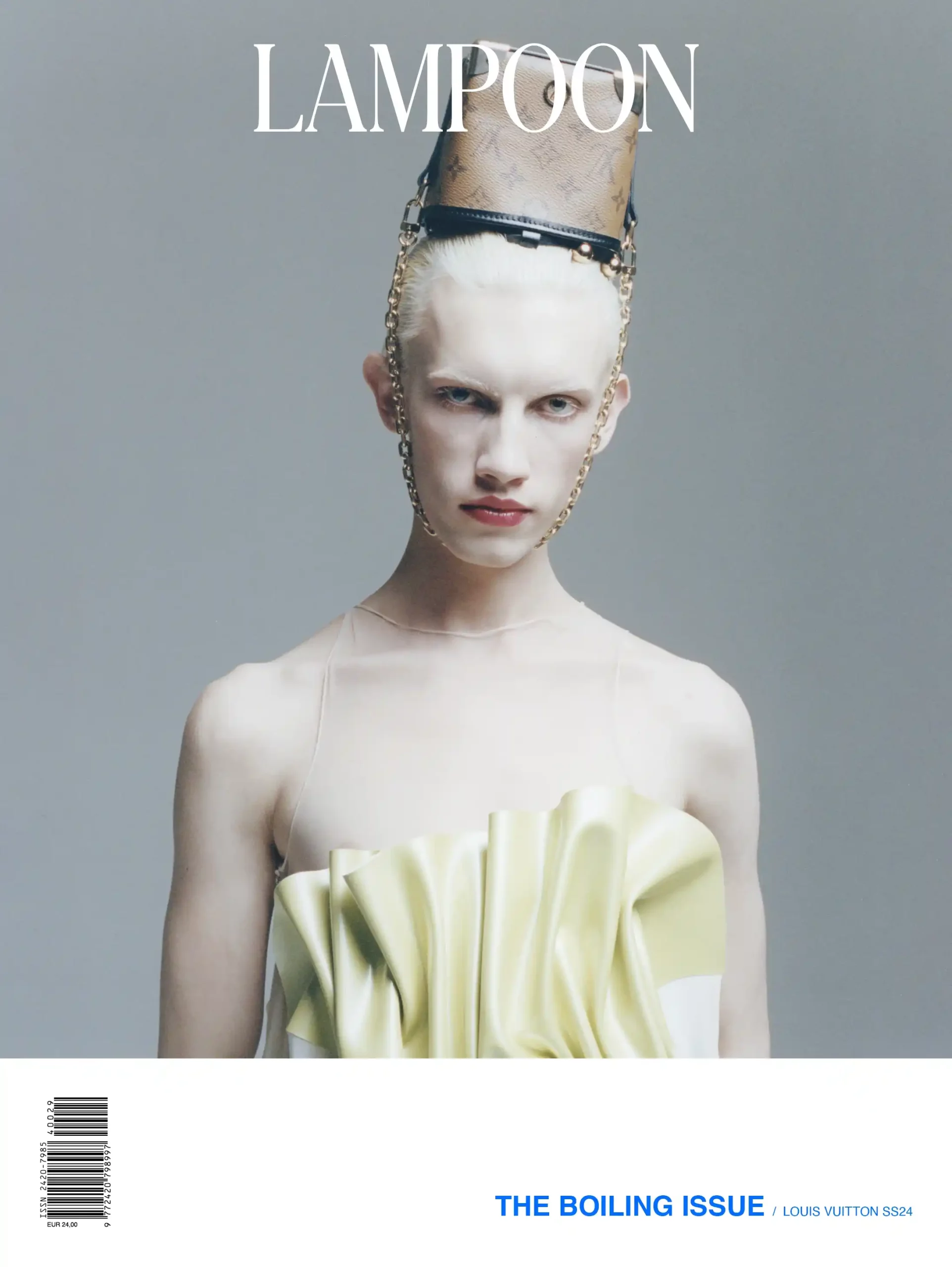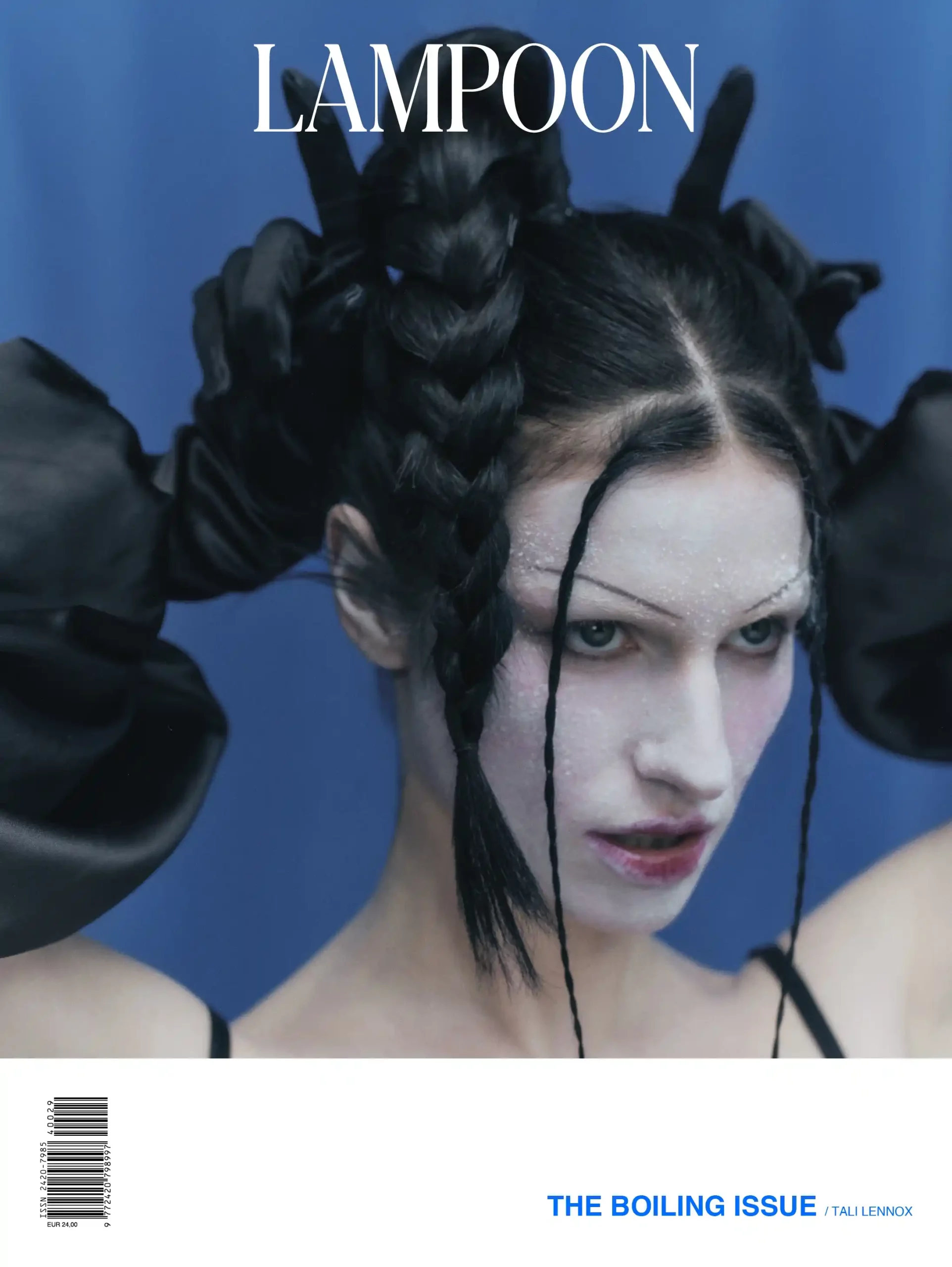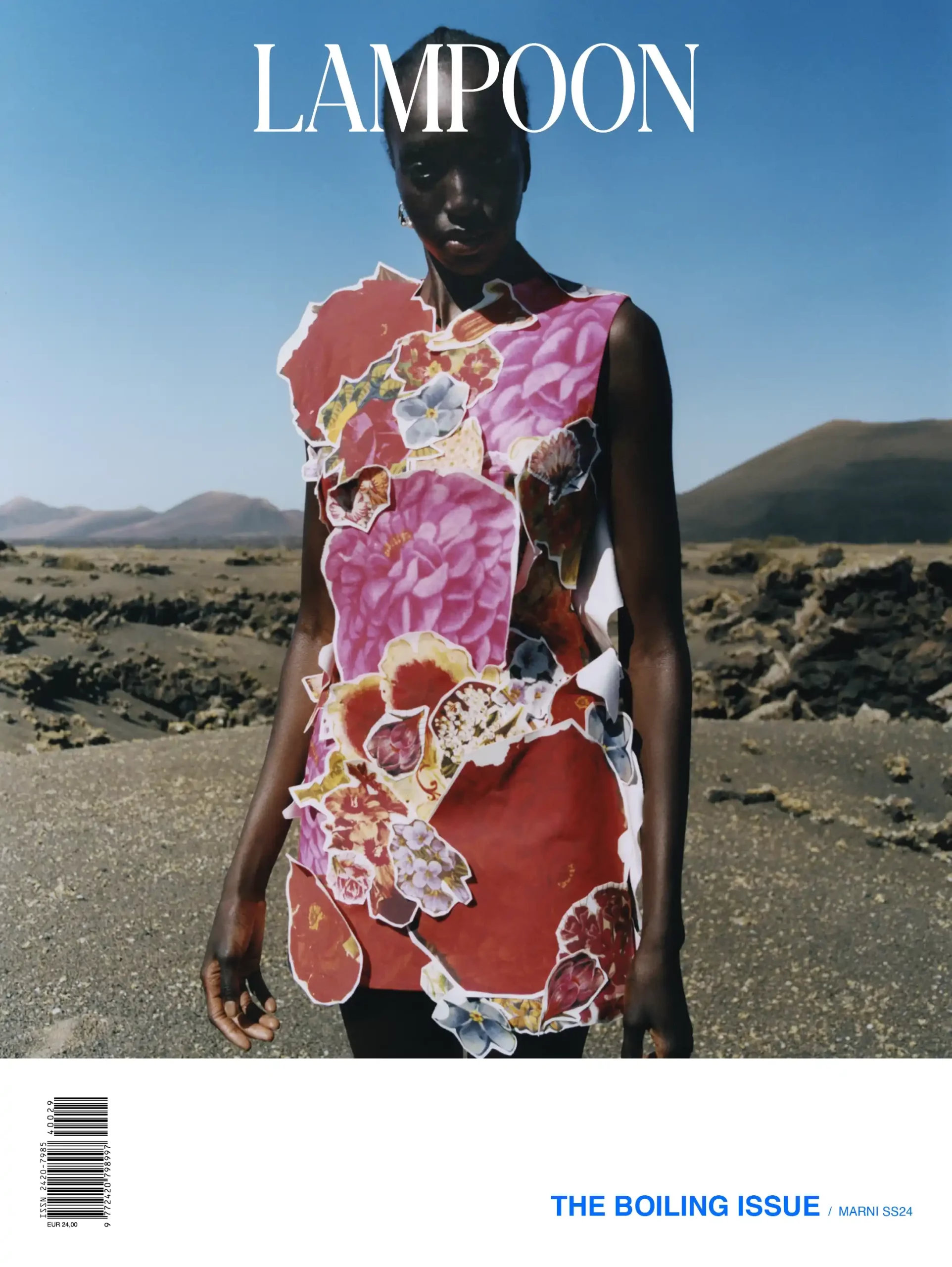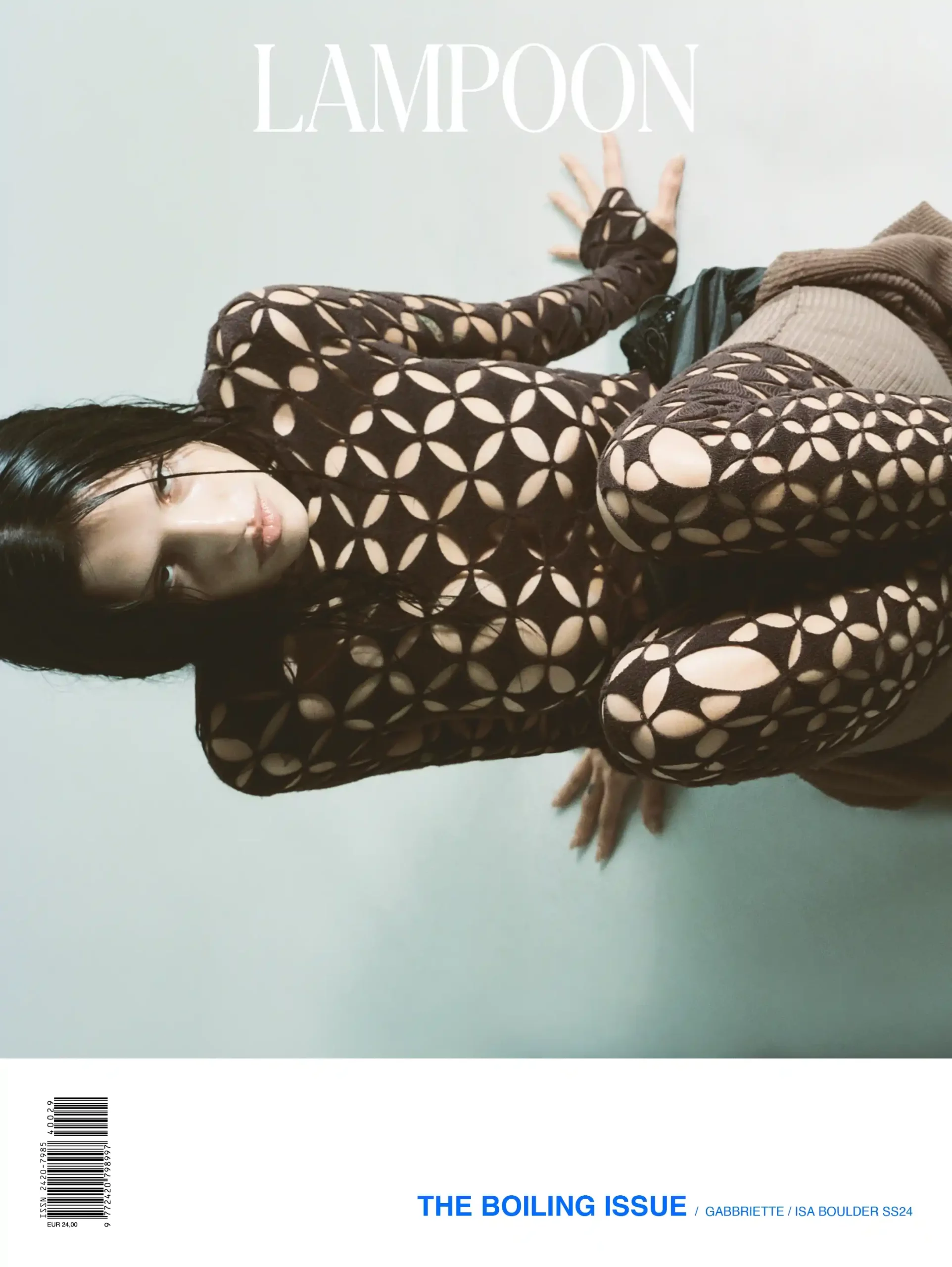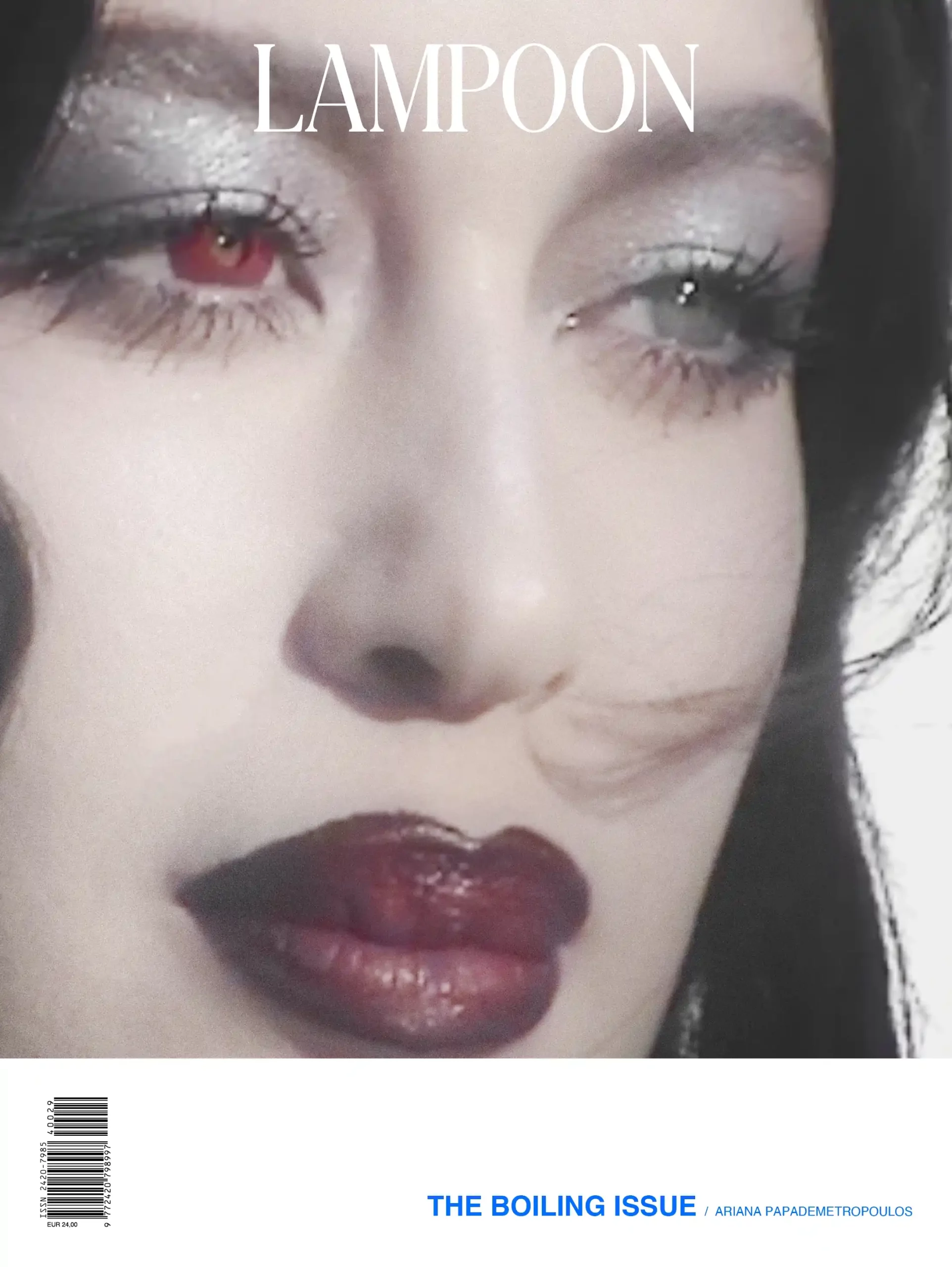Dall’Alto Adige, i principi dell’architettura vernacolare, che integra edificio e ambiente naturale; dall’Austria, l’architettura radicale – Alles ist Architektur. Oggi Milano, intervista a Peter Pichler
Architetture in armonia con il contesto: intervista all’architetto altoatesino Peter Pichler
L’Alto Adige si distingue per l’armonia con cui l’architettura si integra con la natura. Negli ultimi anni la sperimentazione e l’innovazione sono diventati tratti distintivi dell’area. Su questa scia, Peter Pichler, architetto altoatesino che ha studiato a Vienna e a Los Angeles e che nel 2015 ha avviato il suo studio in Porta Romana, a Milano, disegna e progetta architetture in armonia con il contesto, impiegando tecniche e materiali locali, seguendo i principi di funzionalità e praticità – si parla di architettura vernacolare.
Architettura Vernacolare: cosa significa
L’architettura vernacolare si riferisce a quelle soluzioni costruttive che si sviluppano in modo spontaneo e organico in determinate aree geografiche, sulla base di cultura, di materiali e di tecniche di costruzione locali. L’esito di questo tipo di architettura si distingue per l’adattabilità al clima, al territorio e a esigenze pratiche: si tratta di costruzioni in pietra a secco, terra cruda o fango, costruite con antiche tecniche tramandate ed evolute di generazione in generazione.
Come ha scritto Norman Foster, l’architettura vernacolare è l’insieme di quegli edifici e strutture che non rientrano nel campo dell’architettura convenzionale, e che non sarebbero state considerate architettura dai miei docenti. Mi riferisco ai granai monumentali e alle strutture altamente tecnologiche (per l’epoca) dei mulini a vento medievali in Gran Bretagna.
Architetto tra Zeitgeist e Genius loci: i progetti di Peter Pichler dall’Austria a Milano
Applicare gli insegnamenti dell’architettura vernacolare, anteriori all’epoca delle tecnologie prettamente industriali, consente di progettare rispondendo a principi di sostenibilità, spiega Peter Pichler: «Non avrebbe senso realizzare un edificio in legno ad Abu Dhabi, dove non esistono competenze su come si lavora con legno, non vi è disponibilità del materiale e sarebbe necessario trasportarlo dall’estero. Quando lavoriamo sui dettagli o su una scala di progettazione più specifica, troviamo essenziale collaborare con le persone coinvolte nella realizzazione. Ascoltare le loro competenze, ci consente di imparare tanto. I nostri migliori progetti sono quelli dove c’è un legame con la storia locale, un aspetto che non può essere negato, e da cui è possibile sviluppare le radici di un progetto. È più difficile lavorare su un contesto in cui manca: più il contesto è privo di storia, più le possibilità diventano infinite, come un prato verde».
Si tratta di un approccio che coglie le caratteristiche del tempo e dell’identità locale, nel rispetto dello Zeitgeist e del Genius loci: «Se consideriamo i nostri progetti in Austria, Alto Adige o Germania, il paesaggio è fonte di ispirazione – racconta Peter Pichler. In altri casi, come il progetto per la sede di Bonfiglioli in Emilia Romagna, o una villa privata in cantiere a cui stiamo lavorando ad Abu Dhabi, ciò non accade. Il contesto è diverso e magari per ragioni di privacy l’architettura si chiude e la sfida diventa creare spazi di massima qualità per le persone che vivono o lavorano al loro interno. A Bologna siamo partiti dall’esposizione e dalla luce per disegnare la geometria dell’edificio e aprire con vetrate la parte dell’edificio esposta a nord con spazi aperti, mentre la parte esposta a sud è caratterizzata dall’inclinazione del tetto. Il trattamento della facciata è con una seconda pelle che crea un filtro per la luce, e le condizioni di lavoro ottimale per chi lavora all’interno. Il contesto industriale ha influenzato la scelta dei materiali, il contesto geografico e la geometria dell’edificio».
Peter Pichler: l’infanzia nelle montagne e il presente a Milano
«Sono nato a Bolzano, fra le montagne, in un posto che garantisce un’alta qualità di vita: quando ero bambino, in inverno andavo a sciare ogni weekend con i miei genitori il sabato, o magari la domenica dopo essere stati in chiesa. Avevamo le montagne e i comprensori sciistici a 20 minuti da casa. Oggi vivo a Milano con mia moglie e i bambini, e ogni tanto mi manca la montagna: credo che essere cresciuto in quei luoghi ha influenzato l’approccio che proponiamo nei nostri progetti, con i quali cerchiamo di costruire con una relazione fra uomo e natura».

L’influenza di Walter Pichler e dell’Austria radicale
La tradizione artigianale del Sud Tirolo si è sviluppata nel corso dei secoli e si è affermata come una delle eccellenze della regione grazie alla combinazione di maestria tecnica e impiego di materiali di alta qualità. La vicinanza con l’Austria ha poi reso possibile scambi, influenze ed effervescenze creative: «Walter Pichler, il cugino di mio padre, durante la guerra si trasferì in Austria e perdemmo i contatti con lui. Verso la fine degli anni Novanta, tornò a Bolzano per una mostra. In quel periodo frequentavo la scuola geometra ma non sapevo ancora cosa avrei voluto fare dopo. Sentivo che mi sarebbe piaciuto fare l’architetto, ma non ne ero del tutto convinto. Durante il nostro incontro, Walter mi parlò di Vienna negli anni Sessanta: mi raccontava di Hans Hollein, che ancora insegnava alla Angewandte, l’università delle arti applicate. Mi consigliò di andare a studiare a Vienna, una città che era stata la patria di artisti e di architetti radicali. Nel frattempo, si presentò l’opportunità di lavorare a un progetto vicino alla fucina di mio nonno, che era un fabbro, e Walter mi invitò ad unirmi a lui per realizzare alcuni disegni tecnici».
Austria radicale
Walter Pichler aveva contribuito negli anni Sessanta e Settanta al movimento dell’architettura radicale austriaca, diventando famoso per aver progettato la serie “Case portatili”, una serie di soluzioni abitative facilmente trasportabili e assemblabili, critica al boom di consumi che in quegli anni avevano alimentato il miracolo economico. I principi dell’architettura radicale austriaca erano sintetizzati nella formula di Hans Hollein: Alles ist Architektur, Tutto è architettura. Il principio estendeva principi e pratiche della progettazione oltre ai confini canonici, dando forme e visioni a film, performance, installazioni.
Il movimento faceva parte della tendenza dell’architettura radicale emersa in Europa in quegli periodo, e cercava di sfidare le norme architettoniche consolidate e di esplorare nuovi modi di pensare all’ambiente costruito. La sperimentazione di nuovi materiali, forme e tecnologie, e il desiderio di impegnarsi con questioni sociali e politiche erano i tratti distintivi del movimento.
Architecture Without Architects – I Maestri dell’architettura
Convinto dal cugino del padre, Peter Pichler comincia gli studi presso l’Università di Arti Applicate di Vienna e dopo averli perfezionati negli Stati Uniti alla University of California, torna in Austria e si laurea con Zaha Hadid e Patrik Schumacher. Non è solo dall’esperienza diretta che apprende il metodo alla progettazione, ma anche dallo studio di un altro architetto austro-americano:
«Un Maestro dell’architettura che non ho conosciuto, ma che ha avuto un grande impatto su di me è Bernard Rudofsky, l’architetto che negli anni Sessanta ha presentato al MoMA di New York la mostra Architecture without Architects. La mostra, da cui nasce anche un volume, esplorava l’architettura vernacolare e le soluzioni adottate quando la professione dell’architetto ancora non esisteva, e le soluzioni tecnologiche rispondevano a esigenze specifiche, come quelle climatiche. Credo che il suo approccio abbia influenzato i nostri progetti, in cui spesso studiamo il contesto locale e utilizziamo metodi e tecniche che erano efficienti già in passato. Mi piace chiamare questo approccio “low tech” rispetto a quello “high tech” attuale. Nel corso del tempo abbiamo dimenticato molte conoscenze».
Dall’Alto Adige a Milano, passando per Londra e Rotterdam
Peter Pichler lavora a Londra, nello studio di Zaha Hadid, e a Rotterdam, con Rem Koolhaas, quindi torna a Vienna e si unisce allo studio Delugan Meissl. Nel 2015, però, sceglie di tornare in Italia: «Già da un po’ di tempo avevo l’idea di avviare uno studio, e nel frattempo avevo conosciuto Silvana, mia moglie, originaria di Maiorca. Inziavo a sentire Bolzano un po’ stretta e desideravo entrare in contatto con più persone e vivere un contesto più urbano. Anche se ancora trascorrevamo quattro mesi a Bolzano, era l’anno dell’Expo a Milano, e abbiamo ritenuto che la città fosse il contesto giusto per noi. Milano offre la possibilità di lavorare bene durante la settimana, e nel weekend di raggiungere in poche ore Bolzano o Maiorca, o la costa ligure. Il suo carattere è stimolante, in costante evoluzione, anche se è vero che a volte forse le persone sono troppo concentrate sul raggiungimento di obiettivi. Tutto sembra debba essere fatto subito e qui. Nel campo creativo occorre avere delle pause. Le idee e l’ispirazione prendono forma in me quando sono a Maiorca o in montagna. Credo sia necessaria una certa tranquillità per stimolare la creatività».
Peter Pichler
Peter Pichler è nato a Bolzano nel 1982. Ha studiato Architettura all’Università di Arti Applicate di Vienna, dove si è laureato con lode nella masterclass di Zaha Hadid, e negli Stati Uniti, presso l’Università della California. Nel 2015 fonda a Milano, insieme alla moglie Silvana Ordinas, lo studio Peter Pichler Architecture. È stato nominato giovane talento italiano dalla Camera Nazionale degli Architetti in Italia, finalista al Premio Medaglia d’Oro dell’Architettura della Triennale di Milano e ai Dezeen Awards come Architetto Emergente dell’Anno. È vincitore del premio “40 under 40” tra i migliori giovani architetti e designer emergenti in Europa, selezionato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture e dal Centro Europeo per l’Architettura, l’Arte, il Design e gli Studi Urbani.
Elisa Russo