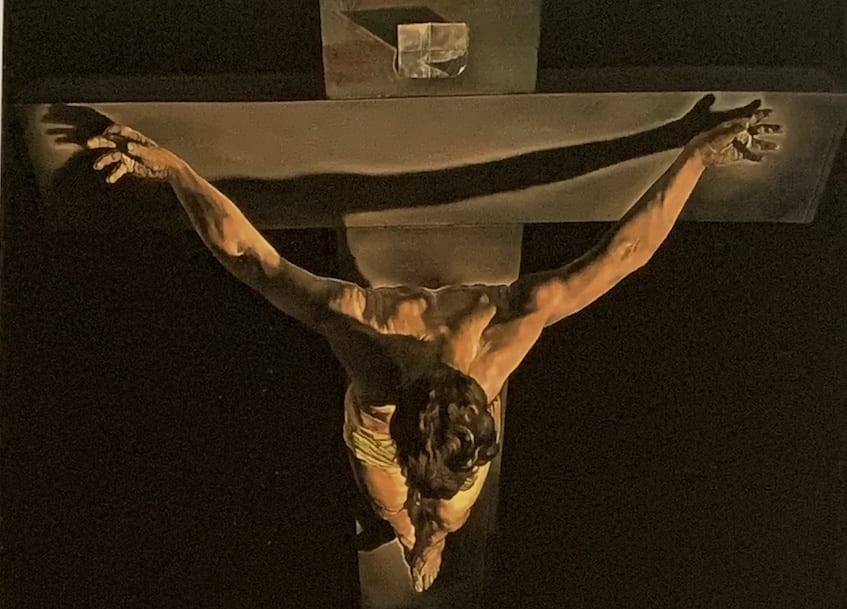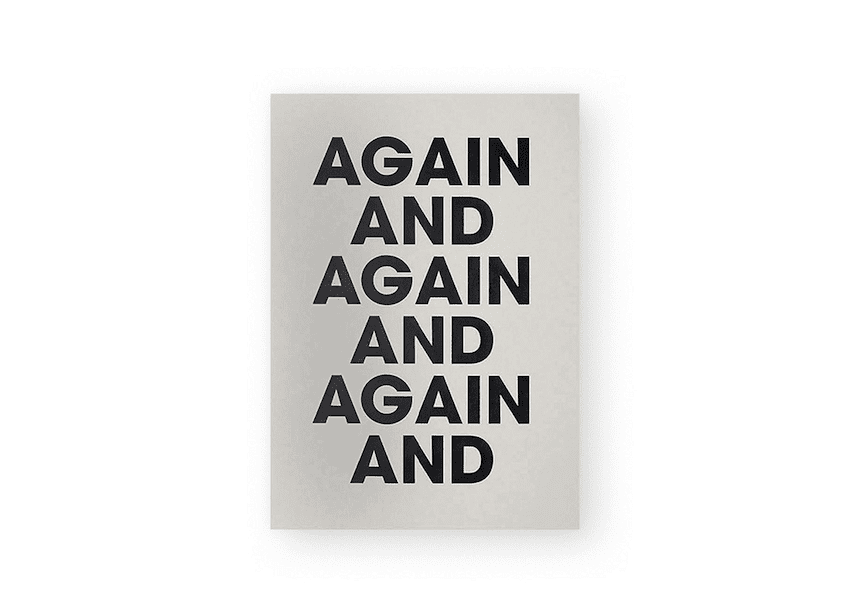Tonno rosso, architettura ligure e il mare. Una città, unico comune sull’isola di San Pietro, che della contaminazione e dello scambio culturale ha fatto la propria forza identitaria
di Antonella Montesi
C’era una volta…
La storia di Carloforte, unico comune sull’isola di San Pietro, situata a sud-ovest della Sardegna e che, con la vicina isola di Sant’Antioco fa parte dell’arcipelago del Sulcis, potrebbe iniziare come una fiaba.
Il racconto parte da lontano, dalla cittadina di Pegli (Genova), quando la ricca famiglia Lomellini, nel XVI secolo, inviò un gruppo di concittadini a Tabarka, un’isola tunisina, per pescare il corallo. Nel 1738, esauritasi questa attività, a questa piccola comunità venne concessa da re Carlo Emanuele di Savoia la possibilità di trasferirsi sull’isola di San Pietro e di fondarvi l’unico centro abitato, Carloforte, così chiamato in onore del re che aveva fornito loro una nuova patria. Sul resto dell’isola furono costruite case sparse nella macchia mediterranea, in quello che oggi è il cosiddetto stile calofortino.
E c’è un ulteriore aspetto fiabesco in questa storia: un piccolo gruppo di tabarchini venne trattenuto in schiavitù in Tunisia. Tra questi, una ragazza di particolare bellezza, la dodicenne Francesca Rosso, che divenne la preferita del Bey. Divenne poi regina di Tunisi e mise al mondo un figlio, divenuto a sua volta re di Tunisi e che, nel 1840, forse anche memore della storia materna, abolì per primo la schiavitù.
Un accenno storico così importante è d’obbligo per capire gli sviluppi che seguirono all’insediamento del 1738 – una vera e propria data di nascita, che Carloforte festeggia ancora come compleanno – e soprattutto per capire la realtà odierna di questa comunità e di questo territorio.
Carloforte esula dalle generalizzazioni, per non dire banalizzazioni, sulla Sardegna tutta yacht e notti annaffiate da Dom Perignon; ma esula anche da quell’immagine più antropologica di una Sardegna rurale ed arcaica, fatta di pastori, di cantu a cuncordu – il canto polifonico – e purceddu arrosto. Questa cittadina ha un’identità ben precisa, una sovranità quasi, nata proprio dalla simbiosi di apporti culturali diversi: i liguri diventati nordafricani, tabarchini per la precisione, e poi diventati calofortini, portando con sé quanto appreso in secoli di viaggi e attività commerciali.

L’isola vanta una comunità operosa e intraprendente. C’è l’Istituto nautico, dal quale, da decenni, escono i capitani e i commodori che comandano le navi più importanti al mondo. Ma il vero punto d’orgoglio dell’isola è la pesca del tonno rosso, il più prezioso, il thunnus thynnus, catturato nella tonnara fissa di Caloforte nel momento del suo passaggio dall’Atlantico verso il Mediterraneo, dove arriva per riprodursi. È detto “tonno di corsa”, perché pescato durante la sua migrazione di andata che avviene tra aprile e giugno, il momento migliore per le sue carni. La tonnara di Carloforte è in mano ai tre fratelli Greco, la cui famiglia vanta il possesso dell’azienda dal 1654. I Greco sono cosmopoliti, ma sono soprattutto carlofortini e genovesi, hanno un forte spirito imprenditoriale, da decenni vendono i tonni ai giapponesi, i più esigenti tra i consumatori di questo prodotto. Uno di loro, Giuliano, quando ci spiega le fasi della pesca, usa termini giapponesi. Il tonno è naturalmente il re della cucina calofortina: nei ristoranti da Nicolo (senza accento, ci tiene), La Cantina, Primo Maggio da Paola, l’Oasi, si ha la possibilità di apprezzarlo nelle varie preparazioni: dalla ventresca alla bottarga, al prosciutto di tonno, un’eccellenza locale che, accompagnata dai vini prodotti dalle due cantine isolane, Vigna du Bertin e U Tabarka, con il Vermentino ed il Carignano in primis, dà il meglio di sé.

Difficile spiegare che in quest’isola sarda, culturalmente non siamo in Sardegna; che non si parla il sardo, ma un dialetto genovese del 1700; che la cucina ha forti coloriture liguri ed arabe; che al posto della fregola, si mangia lo scucuzù, vale a dire il cous cous; che, come saluto, non si dice ajò, ma zü o anémmu.
E arriviamo al paesaggio. L’origine vulcanica dell’isola ha creato alte scogliere e falesie di grande bellezza, il paesaggio lunare di Nasca, dove Stefano Peddis, guida ambientale escursionistica, sa spiegare l’uso storico di ogni pianta, dal rosmarino selvatico al lentisco, passando per il mirto e il ginepro.
E poi c’è il mare, solcato da secoli dalle bilancelle, le imbarcazioni storiche usate per commerciare in tutto il Mediterraneo. Ed è su una bilancella del 1893 che lo skipper Antonello Rosso – forse discendente di quella Francesca Rosso diventata regina di Tunisi? – ci porta a scoprire l’isola dal mare: la mezzaluna, le spiagge di Girin, di Cala Fico. A bordo, ci prepara un piatto di spaghetti con pomodori di un orto calofortino, acciughe, basilico, bottarga e zesta grattugiata fresca, ci offre un caffè ed un mirto e ci dà appuntamento alla prossima gita: non mancheremo.
Per informazioni: www.carloforteturismo.it
Per le gite in barca: www.marinadicaloforte.com
Per il trekking e le escursioni:@carloforteoutdoor