Dal mese di gennaio del 2023, il Rione Terra si è sollevato di venticinque centimetri. Di questi, 7,5 sono stati registrati solo nel 2024. In poche parole, la velocità di sollevamento del quartiere del centro storico di Pozzuoli, già evacuato negli ‘80 durante una precedente crisi bradisismica, è cresciuta, passando dai 10mm ai 20mm mensili, circa il doppio. Ed è proprio dal mese di aprile che la tendenza è cambiata, con due eventi significativi: dal 9 al 10 aprile, il Rione Terra si è sollevato di un centimetro mentre tra il 15 e il 16 di un altro mezzo centimetro.

Le variazioni in quota della stazione GNSS di Rione Terra da primo gennaio 2024. È possibile notare come sia aumentata la velocità di sollevamento dal mese di aprile (Dati ingv)
A registrare questi dati è la Rete GNSS permanente dei Campi Flegrei, costituita da 35 stazioni terrestri e marine che registrano le deformazioni del suolo. Il Rione Terra corrisponde alla stazione GNSS di RITE, un punto fondamentale nell’analisi, visto che questa zona rappresenta un vero e proprio termometro del bradisismo. Qui, tra il 1982 e il 1984 si era registrata una fase crescente molto rapida, che aveva generato un picco di 180 cm, con diversi sciami sismici che portarono alla decisione di sgomberare definitivamente la popolazione residente.

L'area dei Campi Flegrei monitorata dall Rete GNSS permanente
È possibile prevedere il terremoto?
Come tutti i terremoti, anche quelli che si verificano nei Campi Flegrei sono imprevedibili. Esiste solo una certezza: finché il suolo si solleverà si registreranno eventi sismici. L’area è infatti soggetta al fenomeno del bradisismo, letteralmente terremoto lento, che causa il sollevamento e l’abbassamento del suolo. Il responsabile è una grande caldera vulcanica con un diametro di quasi 18 km che va dalla collina di Posillipo fino al comune di Bacoli, passando anche per le isole di Ischia e Procida. L’aumento della pressione in profondità causa l’innalzamento del suolo. A causarlo può essere sia il magma che sale dalla camera magmatica sottostante, ma anche i gas caldi che esalano dalla stessa camera e riscaldano le acque del sistema termale, creando una sorta di pentola a pressione. Tra sollevamento e terremoto c’è una relazione diretta: l’innalzamento del suolo stressa i volumi rocciosi che tendono a liberarsi di questo stress quando si supera il punto di rottura, generando così il terremoto.
Campi Flegrei, convivere col terremoto: seduti ai piedi del vulcano e senza via di fuga

Quando ha iniziato a sollevarsi la terra?
Sono quasi 19 anni che il suolo è tornato a sollevarsi nei Campi Flegrei. Dal 2005 sono state registrate velocità diverse, ma quasi mai lunghi periodi di stasi. Da allora, il sollevamento totale è stato di circa 125 cm, di cui 92 cm dal mese di gennaio 2016. «Negli ultimi 40 giorni - ha osservato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la deformazione del suolo è stata tale da fare immaginare che la sismicità sarebbe continuata con eventi di magnitudo simili, ma anche superiori». Non ci sono infatti segnali che permettano di capire se e per quanto tempo lo sciame proseguirà né se a questo sciame sismico potranno seguirne altri, ma «data la deformazione del suolo che sta interessando l'area, è evidente che ci aspettiamo anche altri eventi». Il terremoto del 20 maggio, di magnitudo 4.4, è stato il più forte degli ultimi 54 anni: una magnitudo che non si era registrata nemmeno negli anni ’80, quando il suolo si era sollevato di 180 cm.
È impossibile stabilire fino a quanto la terra potrà sollevarsi. I 177 ettari del parco archeologico sommerso di Baia rivelano un passato in cui quel pezzo della costa flegrea era sopra il livello del mare, poi la terra ha iniziato a scendere ed è finita tra i tre e i quattro metri sott’acqua. Del resto, già gli antichi greci conoscevano la particolarità di quest’area il cui nome deriva proprio dal greco antico, dove flegrei significa “ardente”.
A Napoli apre al pubblico la Baia Sommersa: 2500 metri quadrati da scoprire

Il porto e la darsena di Pozzuoli
Per capire al meglio gli effetti del bradisismo, bisogna volgere lo sguardo alla darsena di Pozzuoli. Nei periodi di sollevamento, l’area supera il livello del mare seccandosi e per il pescatori diventa molto difficile (se non impossibile) muoversi con le proprie barche. Non solo, anche il porto, che si trova a pochi metri dal Rione Terra, è a rischio. L’innalzamento della banchina ha complicato le operazioni di imbarco e sbarco con bus e camion che non sono riusciti a partire per le isole. Dal porto di Pozzuoli ogni anno transitano oltre un milione di passeggeri e più di 300mila veicoli.
Quante volte hanno eruttato i Campi Flegrei?
L’ultima eruzione conosciuta dei Campi Flegrei è datata 1538, ed è conosciuta come quella del Monte Nuovo, formatosi tra il 29 settembre e il 6 ottobre di quell’anno. Questa, come le precedenti, può essere studiata solamente attraverso l’analisi delle rocce e dei documenti storici. L’attuale conformazione del vulcano è il risultato di almeno una settantina di eruzioni a carattere esplosivo. Le due più grandi sono avvenute decine di migliaia di anni fa, in particolare la più antica 40.000 anni fa, che si chiama Ignimbrite Campana, è considerata l'eruzione esplosiva conosciuta più violenta avvenuta nel Mediterraneo. L’evento causò sensibili perturbazioni climatiche in tutto il pianeta e le ceneri raggiunsero persino la Russia.
Pozzuoli, il Lago d'Averno sembra ribollire dopo le scosse

15.000 anni fa, invece, si registrò l’eruzione del Tufo Giallo Napoletano. Tutte queste eruzioni hanno costruito l’attuale caldera: il rapido svuotamento della camera magmatica provoca il cedimento delle rocce sovrastanti che cominciano a fratturarsi e a collassare. Oggi si possono studiare i bordi della caldera per scoprire le sequenze più antiche, mentre all'interno ci sono quelle più giovani. Attraverso questo studio è possibile ricostruire la dinamica dell'eruzione, ma anche l'impatto.
Recentemente l’Ingv ha spiegato che «la probabilità che la prossima eruzione sia del tipo Ignimbrite Campana o Tufo Giallo Napoletano è bassissima. Secondo gli studi lo scenario con la più alta probabilità di accadimento è quello di una eruzione di piccole dimensioni, come avvenute per l’eruzione di Monte Nuovo del 1538».
È possibile prevedere un’eruzione?
«Al momento non è possibile fare previsioni deterministiche su un evento eruttivo naturale, dove per deterministiche si intende il giorno, l'ora, il minuto e la localizzazione esatta della bocca che si attiverà –spiega Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani Ingv – Il monitoraggio multi parametrico è costante e i dati vanno interpretati». In sostanza, più ci si avvicina a una possibile eruzione, maggiori saranno i segnali da interpretare con una serie di tecniche probabilistiche. Di Vito spiega che tutti i fenomeni legati alla condizione del magma sono controllati: «Le analisi dei gas stanno evidenziando un aumento delle temperature e della pressurizzazione del sistema idrotermale superiore, con valori del gas emesso, pari a 4.500 tonnellate di CO2 al giorno nel sistema delle solfatare in località Pisciarelli (le cosiddette fumarole)». Misure analoghe sono in corso in mare, nel golfo.
Crisi sismica ai Campi Flegrei: il drone in volo sulla solfatara

Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha spiegato durante una recente audizione informale della commissione Ambiente della Camera, che «non abbiamo nessuna evidenza di magma in risalita ai Campi Flegrei. Quello che sappiamo è che c'è una camera magmatica come in tutti i vulcani, in profondità a 7-8 chilometri. Ipotizziamo che ci siano anche dei livelli più superficiali, ma la loro quantità e dimensioni sono abbastanza ignote». Il tema, però, è frutto di dibattito nella comunità scientifica.


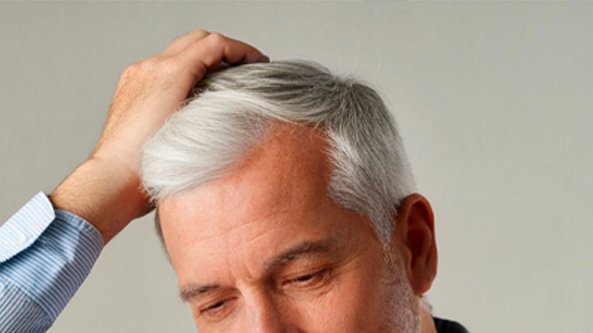

I commenti dei lettori