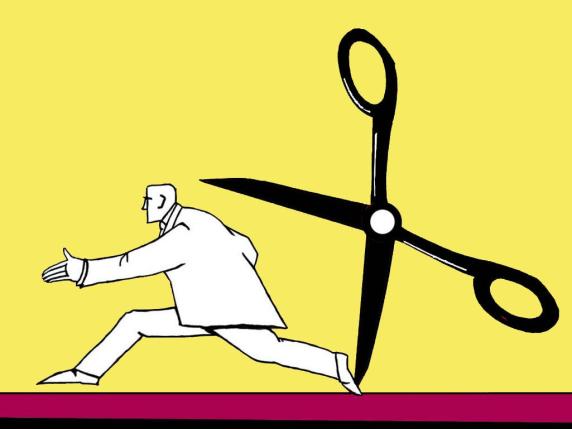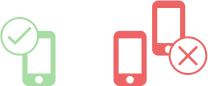Censura: espressione del potere, era una magistratura nell'antica Roma
L'evoluzione la porta a diventare strumento per limitare la libertà di espressione
Se un esponente del potere si lamenta e grida contro la censura è sempre una buona notizia. Dato che la censura può essere esercitata solo da un potere o dai delegati del potere stesso, la protesta di uno di loro contro qualunque forma prenda questa parola, non può essere che un'autocritica, meritevole d'essere accolta con un applauso.
È sempre questione di ricchezza. Il significato di censura, ciò che fa parte a buon diritto delle parole che crediamo di conoscere completamente e che invece qualche sorpresa la riservano sempre, è strettamente legato alla sua origine latina. Prende questo nome, infatti, una magistratura istituita nel 443 a.C. – siamo agli albori dell’epoca repubblicana dopo la cacciata degli ultimi re – per organizzare e sovraintendere i censimenti della popolazione, stabilire quanti fossero i cittadini romani e soprattutto di quali beni potessero disporre. E quella magistratura si chiamava così perché derivata da census, dal verbo censere, valutare, contare. Che abbiamo ereditato in italiano nel nostro censire.
Una vera autorità. Scrive Tito Livio nella storia Ab urbe condita (Dalla fondazione della città): «La censura si era resa necessaria non solo perché non si poteva più rimandare il censimento che da anni non veniva più fatto, ma anche perché i consoli, incalzati dall'incombere di tante guerre, non avevano il tempo per dedicarsi a questo ufficio. Fu presentata in senato una proposta: l'operazione, laboriosa e poco pertinente ai consoli, richiedeva una magistratura apposita, alla quale affidare i compiti di cancelleria e la custodia dei registri e che doveva stabilire le modalità del censimento.»
Non solo conti. Progressivamente il compito dei censori si ampliò dal registro del censimento alla verifica delle infrazioni alla disciplina militare, al controllo degli abusi dei magistrati nei loro ruoli fino alla riprovazione per gli eccessi del lusso. Pensate, nella nostra storia gli eccessi del lusso sono stati motivo di riprovazione e di ignominia. La “nota censoria” è nata proprio esprimere questa riprovazione morale che poteva portare perfino all’espulsione dall’ordine dei senatori e dei cavalieri. Altri tempi…
Il significato moderno. Proprio quell’evoluzione di controllo nelle prerogative dei magistrati dell’antica Roma, ci accompagna al moderno significato di censura “controllo esercitato da un’autorità civile o religiosa su pubblicazioni, spettacoli, mezzi di informazione, per adeguarli ai principi della legge, di una religione o di una dottrina morale”, secondo la perfetta definizione del dizionario di Tullio De Mauro. Attività di controllo ed eventualmente repressione che presuppone sempre la presenza di una struttura e delle articolazioni tecniche e umane per essere operativa. Struttura di cui solo il potere dispone. Come dicevamo all’inizio.
Un percorso di specializzazioni. Seguiamo sempre l’elenco ordinato del dizionario di Tullio De Mauro (che risorsa importante e insostituibile sono i nostri amici dizionari) vediamo che “in tempo di guerra, controllo che l’autorità politica o militare esercita sulla corrispondenza per impedire lo spionaggio o la diffusione di notizie disfattiste”, e nel diritto canonico la censura è la “condanna di una dottrina come eretica o erronea” o il “provvedimento punitivo, consistente nella scomunica, sospensione, interdizione inflitto a un fedele che persevera nel peccato”. Meno grave, nel linguaggio burocratico è la censura “scritta inflitta a un impiegato per lievi mancanze”.
E una storia di pene severe. La censura religiosa ha una storia antica e ricca di decisioni drastiche: nel 325, il Concilio di Nicea dichiarò eretici i libri di Ario, e Costantino prescrisse la pena di morte per chiunque avesse cercato di sottrarli al rogo da lui stesso ordinato; nel 496 papa Gelasio promulgò un indice papale dei libri condannati come eretici e proibiti. Nel 1231-35 Gregorio IX fondò l’Inquisizione, destinata a individuare, giudicare e condannare gli eretici e distruggere ogni loro testo. Nel 1501 una bolla di Alessandro VI proibì di stampare senza autorizzazione, introducendo così il principio della censura preventiva sulla stampa.
La svolta delle rivoluzioni. La rivoluzione francese proclama nel 1789 la Dichiarazione dei diritti dell’uomo che riconosce la libertà di stampa. Nel 1791 il congresso degli Stati Uniti ratificò l’ormai famoso primo emendamento alla Costituzione americana: «Il congresso non promulgherà alcuna legge per imporre una religione o per proibirne la libera professione; o per ridurre la libertà di parola o di stampa, o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente e di presentare petizioni al governo per ottenere la riparazione di torti subiti». Secondo la Costituzione americana gli individui hanno sempre il diritto di indagare su argomenti di pubblico interesse e di criticare l’operato del governo.
La censura fascista. Tra i primi provvedimenti adottati da Mussolini appena preso il potere ci furono severe limitazioni alla libertà di parola per stroncare ogni attività antifascista. Ricorda l‘enciclopedia Treccani: “la prima legge contro la libertà di stampa fu adottata dal governo fascista già nel 1923, anche se entrò in vigore un anno dopo. Dopo l’assassinio di Matteotti, invece, lo smantellamento delle vecchie strutture del periodo liberale assunse un ritmo accelerato. La fascistizzazione integrale della stampa seguì due linee generali. I quotidiani più influenti che godevano di notorietà e prestigio all’estero, come il Corriere della Sera e La Stampa, furono fascistizzati dall’interno con un radicale cambio di proprietà e l’allontanamento dei vecchi direttori. Per quanto riguarda gli altri giornali dell’opposizione, il governo Mussolini si pose come obiettivo la loro radicale eliminazione; applicò la legge del 1923 e, procedendo con sequestri e diffide a ritmo crescente, cominciò a far devastare le sedi di giornali dei partiti d’opposizione”.
Le garanzie della Costituzione. Se la censura è sempre appannaggio di un potere, dobbiamo ringraziare sempre la carta fondamentale della nostra Repubblica che pone argini molto precisi a chi si trova in posizione di comando. L’articolo 21 è molto chiaro, anche per i tanti che fanno finta di non ricordarselo: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
E già che ci siamo. Ricordiamo a tutti (anche agli smemorati che possono permetterselo grazie a questa Costituzione e agli esponenti del potere che gridano alla censura quando vengono contestati e non conoscono il significato della parola) che le manifestazioni in Italia non devono essere autorizzate ma solo comunicate, e alle forze dell’ordine spetta il compito di garantirne lo svolgimento in sicurezza. La Corte Costituzionale ha affermato che occorre garantire anche lo svolgimento delle manifestazioni spontanee”.