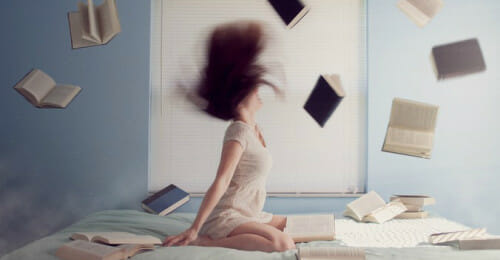Una riflessione a partire dalla nuova edizione dei “Racconti” e di “Visione e preghiera – E altre poesie scelte” di Dylan Thomas, gigante della letteratura del Novecento, il cui dirsi poeta germina da un’esercitazione alla metamorfosi
Una questione di sguardo
Durante la lettura dei Racconti di Dylan Thomas (Einaudi, 2024, traduzione di Floriana Bossi, Lucia Rodocanachi, Angelo Fauno e Claudia Canale; prefazione di Gabriele Frasca), una nota a piè di pagina rapisce la mia attenzione.
Siamo all’inizio del racconto intitolato L’albero, nella sezione dei primi scritti; l’apice si abbarbica, all’interno di un dialogo, sopra la parola “albero”, in inglese tree, che, viene spiegato, “ha anche il significato di ‘croce’, nell’accezione per antonomasia della ‘croce di Cristo‘”.
Sorvolo su quanto sia significativo questo dettaglio per la lettura del brano, che finirà con una vera e nuova crocifissione (la crocifissione di un “idiota” da parte di un bambino), perché vorrei soffermarmi su di una domanda, che sembra essere sospinta dallo stesso autore. Questa domanda si può tradurre così: cosa vediamo noi quando vediamo un albero?

Vediamo una corteccia, vediamo delle foglie, vediamo del muschio, vediamo delle radici. E poi? Ci chiede Thomas: riusciamo a vedere anche la croce? Ovvero: riusciamo a vedere il presente e la sua trasformazione? L’istante e il suo futuro? L’attimo e la sua fine? Siamo consapevoli che ciò che osserviamo è quello che è esattamente davanti a noi e, nello stesso tempo, il suo eterno passato e il suo eterno divenire?
Ecco, da questa esperienza di sguardo, in questa continua esercitazione alla metamorfosi, germina il dirsi poeta di Dylan Thomas. E il dirsi poeti di tutti noi, in fondo. Perché quell’albero sta lì, fermo e immobile, e anche la croce sta lì, ferma e immobile dentro di lui. Aspettano entrambi di essere visti, visti davvero, e ancora di più, di essere chiamati, chiamati davvero. Come fa Thomas in queste poche righe:
«Il giardiniere amava la Bibbia. Quando il sole tramontava e il giardino era pieno di gente, si sedeva nella sua capanna con una candela e leggeva la storia del primo amore e la leggenda su mele e serpenti. Ma soprattutto gli piaceva la morte di Cristo sull’albero. […] Il giardiniere sedeva nella sua capanna e leggeva della crocifissione, guardando al di sopra dei vasi sul davanzale della finestra nelle notti d’inverno. Pensava che è in simili notti che l’amore viene meno, e che molti figli vengono abbattuti». (i corsivi miei vogliono evidenziare la compresenza del rapporto tra albero e croce, tra l’essere e il suo avvenire)
Il tempio di Gerusalemme
Questo effetto ottico possiamo ritrovarlo anche nelle pagine dei vangeli e, in particolare, in un discorso emblematico del Cristo, quello che viene ricordato come il discorso escatologico. Leggiamo da Marco (Mc 13, 1-2):
«Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: “Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!”. Gesù gli rispose: “Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta”».
Ancora una volta lo stesso problema: cosa vediamo noi quando vediamo un albero? Cosa vediamo noi quando vediamo un tempio?
Il Cristo e il suo discepolo sono di fronte al maestoso tempio di Gerusalemme, la prospettiva è la medesima, a cambiare è la capacità della loro visione. Il discepolo si ferma alla corteccia dell’albero: esalta le pietre e l’architettura. Il Cristo, invece, gli dice che non basta. Che bisogna osservare la realtà perché essa includa, sempre, in ciascun momento, la vita e la morte, il vertice e l’abisso, la maestosità e la distruzione: questo tempio è insieme la più grande costruzione dell’umanità e la sua maggiore rovina. E non c’è una linea temporale a separare questi due eventi. Un prima e un dopo. Noi siamo il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro in qualsiasi istante della nostra vita. Quel tempio, quando è sorto, ha cominciato a conservare la sua distruzione; non riusciamo a vederlo forse, ma è già pietra su pietra.
Il discepolo e i suoi compagni non lo capiscono e vinti dalla paura l’unica cosa che riescono a chiedere è:
«Dicci, quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?» (Mc 13, 4).
Hanno bisogno di sapere quando; non capiscono che è già ora. Hanno bisogno di vedere un segno; non capiscono che è già tutto lì. Come dicevamo prima, è solo una questione di sguardo.
E se…
Adesso, potremmo facilmente lasciarci scoraggiare. Non riusciamo a vedere la croce nell’albero, non riusciamo a vedere le macerie del tempio. Non possediamo lo sguardo dei poeti. Rassegniamoci.
Eppure, l’opera di Dylan Thomas non si concentra sulla “possibilità che no” ma sulla “possibilità che sì“, sull’idea che ci sarà un momento, nel corso delle nostre esistenze, che noi quella croce la vedremo; che non avremo più la paura che ci ostacola la visione, la paura della morte, la paura dell’inatteso, la paura del bambino; che non ci basterà soltanto il presente; che saremo tanto dentro al turbinio delle nostre metamorfosi da essere in grado di riconoscere quelle che ci stanno attorno. Perché, in realtà, è solo un unico grande movimento di trasformazione, tutto muta, e noi siamo il tutto.
Ma restiamo sul punto: quindi, se riuscissimo a vedere, cosa succederebbe? Diventeremo persone nuove? La paura esisterà ancora? Avremo ancora bisogno di segni?
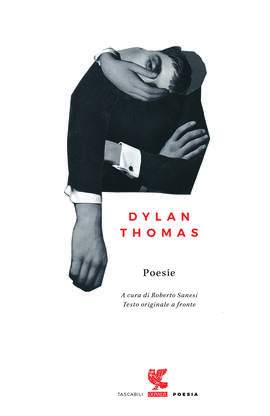
C’è una poesia dell’autore di Swansea – l’ho letto nella splendida, nuova edizione di Visione e preghiera – E altre poesie scelte (Giometti&Antonello, 2023, a cura di Tommaso Di Dio) – che sembra essere scritta appositamente per questa occasione. L’occasione della vista. Della vista profonda, quella che oltrepassa, trafora.
Proviamo a fare questo esperimento. Proviamo a dire quel “se” e farlo seguire dalla prima strofa di questa poesia.
Se riuscissimo finalmente a vedere… Scrive, allora, Dylan Thomas:
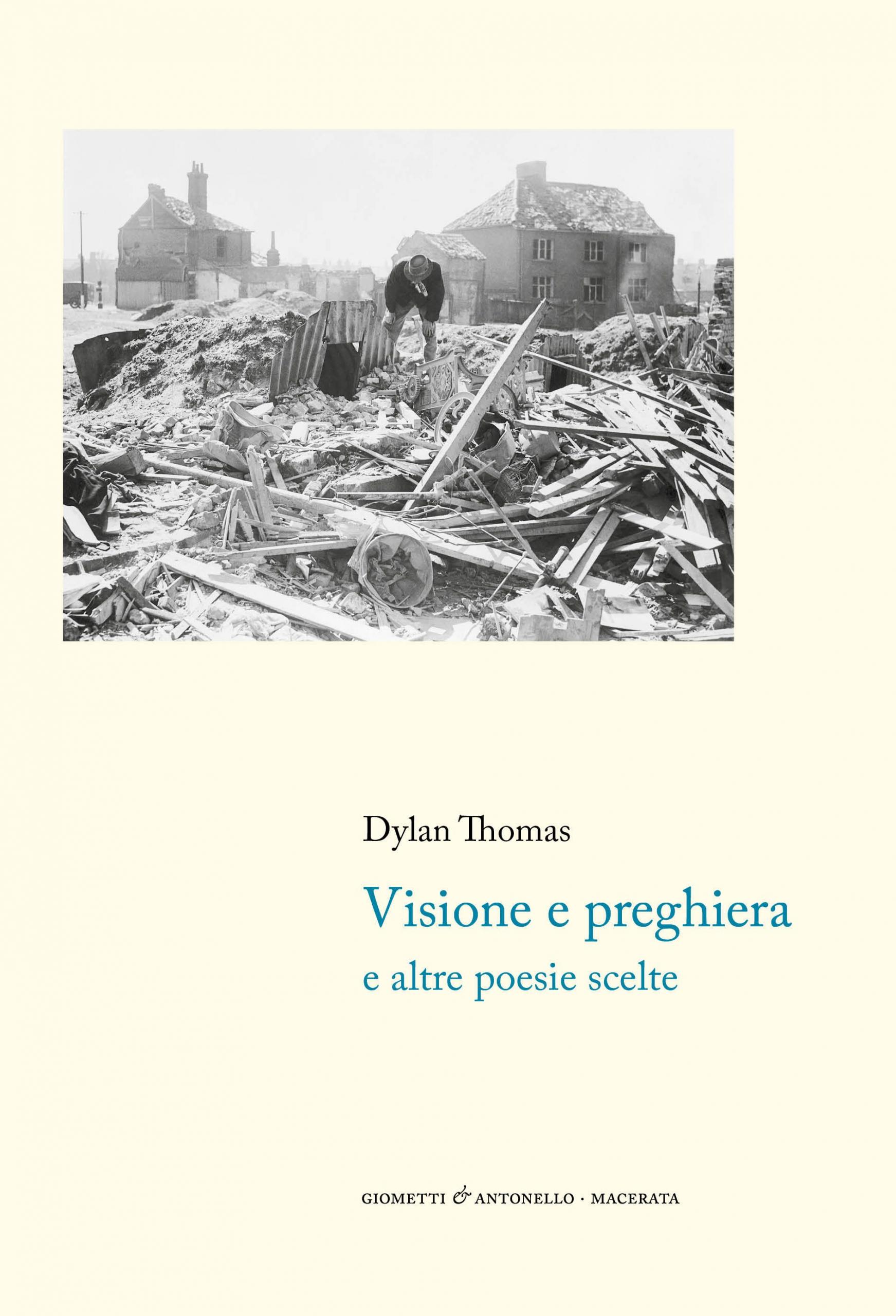
«E la morte no, non sarà più sovrana.
Gli uomini nudi e morti saranno una cosa sola
con l’uomo nel vento e con la luna dell’Occidente.
Quando le loro ossa saranno bianche fra le mani e le bianche
ossa saranno dissolte, avranno stelle ai gomiti e ai piedi.
Sebbene diventati pazzi, saranno santi.
Sebbene immersi nei mari, risorgeranno.
Sebbene saranno persi gli amanti, amore mai lo sarà.
E la morte no, non sarà più sovrana».
A margine, bisogna fare una puntualizzazione. Come sapientemente ci guida il curatore della nostra edizione, sarebbe un altro il “se” a cui si ispira il poeta gallese, ripreso dalla Lettera ai romani di Paolo di Tarso (Rm 6, 8): “Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui”.
A questo punto, le domande che mi pongo, riflettendo sulla poetica di Dylan Thomas, e con le quali concludo, sono due: la prima, per questo gigante della letteratura del Novecento, quel credere non significa vedere davvero l’albero? La seconda, vedere davvero l’albero (o qualsiasi altra cosa) non significa smettere di morire?
Scopri le nostre Newsletter

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it