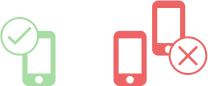Le lunghissime code al controllo passaporti dell'aeroporto JFK sono solo uno dei segnali dell'inefficienza dei servizi pubblici americani
È ormai un classico. Gli amici che mi vengono a trovare dall’Italia mandano il primo messaggio dall’aeroporto John Fitzgerald Kennedy (JFK): «Atterrati». Segue un silenzio di tre, talvolta anche quattro ore, prima che suonino al campanello di casa mia. Nell’intervallo, sono stati catturati nel girone infernale del JFK (due ore di attesa al controllo dei passaporti sono diventate “normali”), poi nel traffico assurdo dal Queens a Manhattan. Hanno cioè sperimentato sulla propria pelle un indizio minore e banale, ma molto concreto, del declino americano.
Gli Stati Uniti hanno smesso da tempo di essere una vetrina di modernità e di efficienza. Mentre ci interroghiamo sui grandi scenari della geopolitica, sul vertice fra Putin e Xi, è anche nelle piccole cose quotidiane che si misura lo stato di una nazione. Lo stato dell’America non è esaltante. Non lo è da molto tempo. Evitiamo il vizio di dare la colpa a questo o quel presidente in carica, i problemi si accumulano da tempo.
Torno agli amici in visita e al calvario che si chiama JFK. I più sfortunati, almeno nella mia piccola casistica personale, di solito sono quelli che prendono il volo Emirates che parte da Malpensa alle quattro del pomeriggio e atterra qui alle sette di sera locali al terminal 4 di JFK. Forse a quell’ora c’è un cambio di turno nel personale della polizia di dogana. Fatto sta che al controllo passaporti – soprattutto per chi non ha la cittadinanza Usa – si crea una fila inverosimile, assurda. A volte ci sono centinaia di passeggeri in attesa e i poliziotti allo sportello si contano sulle dita di una mano.
A poco serve l’intelligenza artificiale, l’uso di macchine per la lettura digitale o il riconoscimento delle pupille, il fattore umano è quello che blocca tutto. È una sofferenza assurda per chi ha viaggiato molte ore sull’Atlantico, questa fila immensa e immobile. Ai nuovi arrivati offre un primo segnale tangibile dell’inefficienza americana. Nessuno osa protestare perché gli agenti in divisa hanno il coltello dalla parte del manico, sono suscettibili, e se gli stai antipatico possono assoggettarti a un controllo aggiuntivo, facendoti perdere altro tempo. È una vergogna che l’aeroporto usato da tanti stranieri come porta d’ingresso agli Stati Uniti li accolga in modo così orribile. E sorvolo sullo stato del terminal stesso: brutto, vecchio, fatiscente, inefficiente.
Io non subisco questi disservizi quindi non sto montando un caso personale. Ho il passaporto blu dei cittadini Usa e inoltre in quanto viaggiatore ultra-frequente mi pago di tasca mia un “pass” speciale che dà il diritto a una corsia veloce. Mi faccio interprete dell’indignazione di tanti italiani che arrivano qui con un’idea dell’America che crolla subito davanti al disastro JFK.
E comunque anch’io non sono esente da disagi. Ieri sono atterrato da Porto Rico, volo domestico, niente passaporto, ma al terminal 5 per raggiungere l’area dei taxi bisogna fare un altro viaggio: fra cantieri infiniti, con pubblicità che vantano i «19 miliardi spesi per rinnovare l’aeroporto». Peraltro non c’è quasi alternativa ai taxi o a Uber. New York è nel mondo intero l’unica grande metropoli di queste dimensioni a non avere un vero collegamento diretto – treno veloce, metrò – fra il centro e i suoi aeroporti.
L’uso dei trasporti pubblici implica diversi cambi di treno, e per lo stato delle stazioni della Subway non è consigliabile avere bagagli pesanti. Eppure ho perso il conto di quante decine di miliardi sono stati prelevati dalle nostre tasche, stanziati e poi spesi per migliorare la viabilità. Cantieri ce ne sono sempre e ovunque, il che spiega il traffico da lumaca fra Queens-JFK e Manhattan; raramente questi cantieri sfociano in un vero miglioramento. Da quando vivo in questa città – anno 2009 – gli scali newyorchesi (JFK, LaGuardia, Newark) sono delle voragini di fondi pubblici, continuano a ingoiare le nostre tasse, con scarsi benefici. La gente di qui subisce, più o meno come i turisti stranieri.
Lasciate perdere le vostre personali antipatie per Biden oppure per Trump. Tutti sono colpevoli – aggiungiamoci sindaci e governatori locali – ma il disastro è ben più antico di questi due presidenti. E non si limita alla città di New York, per quanto sia un laboratorio speciale di inefficienze (vi risparmio la metropolitana e la spazzatura).
Per me una “rivelazione” personale accadde vent’anni fa. Quando andai a vivere a Pechino nel 2004, moglie e figli rimasero negli Stati Uniti. Quindi facevo il pendolare per rivederli. Più viaggiavo a cadenza regolare fra l’Estremo Oriente e l’America, più venivo colpito da questa sgradevole scoperta. Ogni mio ritorno sul suolo degli Stati Uniti aveva l’aspetto di un salto nel passato. Tutto funzionava peggio qui. Gli aeroporti cinesi erano solo un esempio, ma non un esempio da poco: continuavano a migliorare proprio mentre quelli americani sprofondavano nel dissesto. Un altro esempio: l’alta velocità ferroviaria avanzava in Cina mentre in America è un progetto fermo da vent’anni (ma continua a dissanguare i contribuenti, per esempio in California).
Vent’anni fa cominciai a segnalare ai miei amici americani questa mia sensazione che la “nazione leader” stava perdendo colpi in molti settori: infrastrutture, trasporti, servizi pubblici. Spesso la prendevano male, qualcuno mi accusava di essere diventato «filo-cinese e anti-americano» per via della mia nuova collocazione. Scoprii una delle concause della decadenza americana: delle élite autoreferenziali, profondamente provinciali, incapaci di fare confronti onesti e ravvicinati con i progressi in corso in altre parti del mondo.
Poi arrivò una opinionista ed aspirante politica di sinistra, Arianna Huffington (la fondatrice dell’Huffington Post), che scrisse un saggio intitolato America, paese del Terzo mondo. In seguito, del tema si impadronì, da destra, Donald Trump: nei suoi comizi del 2016 cominciò a dire che gli aeroporti americani sembravano appunto quelli del Terzo mondo, se paragonati agli scali del Golfo (Dubai eccetera). Una banalità per chi viaggia, ma quelle parole di Trump sembrarono aprire gli occhi a molti. Biden è corso ai ripari… sulla carta. La sua Amministrazione ha speso molte centinaia di miliardi per investimenti in infrastrutture. Risultati? Chi li ha visti me li segnali per favore. Il crollo del ponte di Baltimora poche settimane fa è stato l’ultimo segnale che tutto va a pezzi.
Ho scritto in passato sulle cause profonde del disastro americano nelle infrastrutture. Questa nazione fu all’avanguardia nell’Ottocento nel costruire le grandi ferrovie intercontinentali e oggi i suoi treni sono una barzelletta che non fa ridere nessuno. Le buche stradali di New York inghiottirebbero una utilitaria europea. In California, lo Stato più ricco di tutti e con un Pil superiore a Francia o Italia, gli incendi accadono ancora perché le linee elettriche penzolano dai pali come cinquant’anni fa.
Eppure abbiamo un deficit pubblico vicino al 7% del Pil, non è vero che questa sia una nazione iperliberista dove tutto viene affidato ai privati e al mercato. L’incapacità del settore pubblico ha cause che possono suonarvi familiari: ipersindacalizzazione, dirigenti che non esercitano autorità sui dipendenti, normative ambientaliste che paralizzano i cantieri. Su tutto regna una classe politica che è troppo impegnata da guerre ideologiche tribali, per occuparsi di cose terra a terra come far funzionare una metropolitana, un treno o un aeroporto.
È anche sconcertante il divario di modernità e di efficienza con le punte avanzate del settore privato. Le aziende migliori del mondo stanno qui in America. Tutto ciò che riassume il progresso tecnologico ed economico degli ultimi cento anni si è concentrato quasi sempre qui, con una particolare accelerazione innovativa negli ultimi quarant’anni. È pazzesco constatare l’abisso che separa la sfera del capitalismo privato da quella di tanti servizi pubblici.
Ripeto: non diamo la colpa al liberismo perché è scomparso da tempo, New York e la California hanno una pressione fiscale europea e un Welfare scandinavo (almeno nella capacità di spesa).
Chi osserva l’America da lontano, chi la visita da turista o per lavoro, può divertirsi di fronte a certi segnali d’inefficienza. È anche questa la maledizione del JFK: la Grande Mela continua ad attirare turisti nonostante li tratti malissimo, i flussi di visitatori sono sopra i massimi storici pre-pandemia. Chi se ne importa se stanno due ore in fila al controllo passaporti?
Questa indifferenza ai tanti segnali del degrado, del declino, concorre a formare un’impressione che dietro ci sia qualcosa di più grande, quello che chiamiamo decadenza. I vertici fra Putin e Xi, le votazioni all’Onu dove il Grande Sud globale è sistematicamente anti-americano, tutto questo contribuisce al grande scenario di sfondo, ai macro-trend della geopolitica. Ma i doganieri che non fanno il loro lavoro al JFK sono la versione modesta e prosaica di un mondo che non è più all’altezza delle aspettative.
15 maggio 2024, 16:36 - modifica il 15 maggio 2024 | 17:34
© RIPRODUZIONE RISERVATA