Un romanzo forte, che tratta tematiche complesse e non cerca facili soluzioni ma spinge il lettore ad allenare l’empatia, mettersi nei panni – molto scomodi – dell’altro. Cuore nero (qui la recensione di Gloria Ghioni), l’ultimo romanzo di Silvia Avallone in libreria per Rizzoli, esplora quello che viene dopo la colpa e il carcere. Una storia che contiene molti temi urgenti e spunti di riflessione. In occasione del Salone del libro di Torino ho avuto la possibilità di intervistare l’autrice in esclusiva per Critica Letteraria.
Ho letto che hai tenuto un laboratorio in un carcere minorile mentre scrivevi questo romanzo. In Cuore nero scegli di raccontare però soprattutto il dopo, la vita che viene. Come mai questa angolatura particolare?
Il romanzo nasce proprio dall’idea di interrogare questo “dopo”. Io sono partita dall’immagine di una mulattiera da risalire e di una giovane con alle spalle una lunga pena e un delitto di cui io stessa ho scelto di sapere il meno possibile fino alla fine perché volevo seguirla in questo “dopo”, senza avere pregiudizi. Volevo lasciarmi e lasciarle un’apertura verso il futuro che sappiamo essere difficilissima. Un po' perché la società ti marchia, ci marchia tutti, ci definisce per i nostri errori e in quella definizione ci ingabbia. E un po’ perché è difficilissimo convivere con un senso di colpa enorme per qualcosa che hai compiuto e che non potrai mai e poi mai riparare, eppure, nonostante ciò, sei viva. Quindi ho voluto tenere insieme questa complessità tra la colpa e la vita. E forse vivere e onorare la vita è un modo davvero bello di rispondere di quella colpa senza ridimensionarla, senza offuscarla. Il tema del carcere minorile si inserisce in realtà felicemente, era un mio desiderio da tanto tempo entrare in quel contesto, a pochi passi da casa mia c’è un istituto penale per minorenni, e le cose si sono incastrate, come sempre succede nei romanzi che sono in qualche modo magici, mentre scrivevo. Fare esperienza di quel luogo è stato fondamentale per ricostruire l'adolescenza negata di Emilia. Il carcere che ho frequentato è un carcere minorile maschile e nella scrittura è stato trasformato in femminile. Non vedo l'ora di rincontrare quei ragazzi, che nel frattempo hanno avuto modo di leggere il libro, per sapere se si sono riconosciuti trasposti al femminile.
La rappresentazione di questo luogo ti è uscita fuori molto vera, non si percepisce alcuna sovrastruttura. Non era facile secondo me.
In realtà questo libro per me è stato al tempo stesso facilissimo da scrivere, e difficilissimo da sostenere emotivamente: da una parte avrei voluto che Emilia riuscisse a riparare l'irreparabile, cosa che sapevo essere impossibile, dall'altra ci sono state delle occasioni, per esempio il periodo Natale o prima dell'estate, in cui i ragazzi detenuti erano particolarmente giù di morale e in quelle giornate era arduo tornare a casa dopo gli incontri con questo forte senso di impotenza. Ci sono stati anche momenti più sereni, in cui li vedevo ringalluzziti, e in quelle occasioni sono nate le pagine più felici e piene di speranza. Una speranza che ho respirato in prima persona: ho visto naturalmente le difficoltà che ci sono all’interno del carcere, ma anche le possibili speranze, che passano sempre attraverso una relazione. Sempre attraverso l'incontro con qualcuno che ti dà fiducia e ti tende la mano, altrimenti non ti salvi. Non si salvano loro e non ci salviamo neanche noi.
È un romanzo che è anche un po' un canto d'amore disperato nei confronti della cultura, delle opportunità che dà la cultura.
Assolutamente, perché se non hai le parole per pensarti diverso, non sarai mai diverso. Se non hai le parole per dire quello che hai fatto, non riuscirai mai ad affrontarlo. Emilia affronta davvero la sua colpa non in carcere ma fuori, quando finalmente è chiamata – guarda caso da una storia d'amore – a nominare quel male. Finché non lo nomina, ci è dentro. Vale lo stesso per il discorso della pena: se non hai le parole, come fai a far sì che la pena sia un riscatto? Anche la Costituzione dice che la sofferenza deve portare a una luce, altrimenti è il male per il male ed è l'inferno, una vera prigione. Abbiamo bisogno di parole per fare pace con la nostra storia e poterne raccontare un capitolo nuovo. Per me la cultura è anzitutto una questione di linguaggio. Però soltanto incontrando questi ragazzi ho capito quanto le parole possano cambiare le cose. Nel romanzo c’è una scena in cui al termine detenute viene affiancato quello di studentesse. In quel contesto infatti senti concretamente il peso della parola detenuto, la gabbia mentale che la parola produce in contrasto con lo spiraglio di futuro, di imprevedibile, di libertà che evoca invece la parola studente. Per loro si tratta di fare il passaggio da un linguaggio di violenza e illegalità, emarginazione, a un altro tipo di linguaggio, che cambia. E se cambia il modo di raccontare te stesso e quello che potresti essere, cambi anche tu.
Molto interessante la costruzione di questo romanzo: c'è questa grossa tensione di fondo, perché noi a inizio del libro abbiamo una certa curiosità di sapere che cosa ci sia nel passato di Emilia, quale colpa. Allo stesso tempo però da un certo punto in poi ti viene a mancare quella curiosità, perché soppiantata da altro più importante.
Ogni volta che leggiamo sui giornali di un fatto di cronaca, quel singolo evento raccontato inchioda per sempre i protagonisti della vicenda a quel reato, a quel delitto. Vale anche per chi lo subisce, non solo per chi lo compie, e perciò per me era importante tenere sempre il doppio punto di vista: quello del colpevole e quello della vittima. Se tu inchiodi una persona al suo male, subìto o compiuto che sia, le stai negando l'umanità, la possibilità di cambiamento. Eppure lo facciamo tutti i giorni. C'è solo un luogo, che è la letteratura, in cui smettiamo di farlo: quando per esempio leggiamo i Promessi Sposi e vogliamo bene a fra’ Cristoforo. Dentro la letteratura torniamo alla complessità dell’umano. Per questo, nella stesura del romanzo, ho voluto che il lettore scoprisse quale male Emilia avesse fatto solo verso il finale, quando oramai le voleva già bene, e bisogna tenere assieme questo insieme di possibilità e contraddizioni, ti devi sobbarcare il peso di voler bene a una persona che è tantissime cose, è la figlia, la fidanzata, è la restauratrice, la studentessa e tantissimo altro. È tutto questo, ma non solo questo, ed è devastante, ma bisogna tenere insieme tutto.
Accennavi prima alle parole, alle etichette che appiccichiamo addosso alle persone. Quel momento in cui Bruno ascolta un fatto di cronaca e usa parole che tutti abbiamo pensato e usato e tu le citi puntualmente a più riprese.
È una reazione normale, di fronte a certi casi. Ogni storia però è diversa, ogni persona è diversa. Ci sono persone che rimangono nel male, che non hanno la forza o la capacità o la volontà di costruire un pezzo di bene, di percorrere un percorso faticosissimo. Serve tempo, questo è il punto. Noi siamo fatti di tempo, per capire ogni storia ci dobbiamo prendere quel tempo. Per questo per me la letteratura può cambiare e salvare il mondo, perché funziona con il tempo e con l'empatia. Io entro dentro di te, penso come te, non ti giudico da fuori.
La letteratura costruisce ponti, allena all’empatia.
È così. Inoltre, l'empatia per chi dobbiamo provarla? Per il vincente? Ma chi se ne frega. Dobbiamo provarla per le persone che hanno bisogno di noi.
La scrittura è anche un po’ incoscienza?
Deve esserlo. Il problema semmai è raggiungere quel grado di libertà per cui non pensi più, stai solo dentro la storia. Vuoi trovare risposte alle tue domande che restano aperte perché proprio sono certe domande. Io me ne rendo conto adesso che, per esempio, la figura del padre di Emilia era difficilissima da portare a compimento senza cadere in uno stereotipo, ma, mentre scrivevo, per me era puramente naturale che lui fosse lì a portare la sua croce, con la volontà di stare accanto a questa figlia. La scena della pila, e anche quando dice «non si ringraziano i genitori», è una scena che viviamo anche noi, nel nostro piccolo, come genitori e come figli. Racconto una storia particolarmente drammatica, che però, in realtà, ci riguarda tutte e tutti.
È un romanzo che, nonostante tutto, parla di futuro e di speranza, senza scadere appunto nel sentimentalismo.
Grazie, me lo stai facendo capire tu che era pieno di ostacoli! Non me ne sono accorta mentre lo scrivevo.
Mi piace questa idea della scrittura selvaggia, in qualche modo scrittura inquieta. Ma è una tua caratteristica? È sempre stato così, scrivere senza pensare al pericolo?
Sì, perché altrimenti si finisce per non scrivere niente. Questo romanzo l’ho scritto in uno stato particolarmente di grazia, per le storie e le persone che ho incontrato: i ragazzi in primis ma anche i giudici, gli assistenti sociali, le educatrici, il direttore del carcere. Una serie di incontri che mi hanno dato speranza e anche ispirazione. Diverse frasi del romanzo non le ho inventate io, ad esempio «ripartiamo dal buono, cerchiamo il buono», perché bisogna ricominciare, perché qualsiasi cosa sia successa siamo vivi e quindi abbiamo il dovere di vivere. Non è una cosa banale, perché uccidersi o morire di sedativi sarebbe molto più semplice e purtroppo a volte capita. E invece se tu incontri una persona, come è accaduto a me con un’assistente sociale che mi ha detto «andiamo a cercare il buono, cerchiamo di percorrerlo» ecco che torna la speranza. Noi possiamo veramente fare tanto per cambiare le cose, anche con piccoli contribuiti, uscendo e incontrando gli altri, banalmente, cosa che la nostra società non ci insegna più a fare. Io personalmente ho ricevuto estremamente di più di quello che ho dato nei miei laboratori al carcere minorile di Bologna, ne sono certa: incontrare un'altra persona a cui tu dai fiducia e ne ricevi in cambio, è meraviglioso.
Era quello che ci mancava fino a quattro anni fa, in quel momento buio?
Dopo le batoste uscirne migliori è una scelta, faticosa, che dobbiamo compiere insieme e non da soli, aiutandoci perché altrimenti diventiamo pieni di rabbia e rancore, sentimenti che se restano fini a loro stessi non risolvono niente, anzi ci peggiorano. Se invece quella rabbia, quel rancore, quella voglia di rivalsa la si impiega in un progetto di costruzione e di solidarietà, se ne esce solo insieme. Nessuno dei personaggi, isolato, avrebbe potuto combinare alcunché. Da soli siamo tutti persi, non perdenti me persi, che poi la vita non si vince e non si perde.
Com’è secondo te la ricezione di questo libro? Perché è una storia anche difficile da accogliere.
Tutti i miei romanzi a modo loro sono stati divisivi ma questo penso abbia avuto la ricezione più bella, non me l’aspettavo e sarò felicissima di poterlo riportare ai ragazzi in carcere. Per noi lettori è davvero uno sforzo di empatia grosso, è un uscire dalla comfort zone. Così come lo è stato per Bruno, il personaggio maschile. Io penso che dobbiamo oltrepassare tutti gli stereotipi, anche quello della vittima. Siamo tutti storie e dobbiamo ascoltarci, senza giudicare, dobbiamo entrare uno nell'altro per cercare di aiutarci.
Fai anche una scelta stilistica interessante che è quella di alternare piani temporali e punti di vista e un uso differente proprio del mezzo narrativo. Credo che ponga il lettore nella condizione appunto di allenare l'empatia verso questi personaggi. Ed è anche un modo rispettoso di raccontare Emilia.
Per scrivere di un male così grande ho dovuto avvicinarlo a me, pur rispettando i miei limiti. Non avrei potuto scrivere di un femminicidio o di un adulto che fa male a un bambino, quindi ho scelto un personaggio a cui sono molto affezionata e su cui ho lavorato anche nei miei altri libri: una ragazzina, un’adolescente. Perché l’adolescenza è un tempo di possibilità e trasformazione e volevo affrontare il tema della colpa nell’ottica del dopo, della convivenza con le conseguenze del male, senza ridurre il personaggio a ciò ha commesso, anche se responsabile di una cosa così grave. Allo stesso tempo ho dovuto raccontare la storia di Emilia in terza perché non mi era possibile calarmi in quel gesto, pur volendolo guardare il più vicino possibile.
È anche una forma di grande rispetto.
Sì, sia dei miei limiti personali, sia della storia e dei lettori.
Da lettrice ho grande predilezione per i luoghi letterali. Mi piace moltissimo vedere dove una storia nasce, dove è calata. Dei luoghi appunto, che fanno la storia stessa, perché secondo me non sono semplici sfondi. Il luogo dice moltissimo. E questo luogo della tua storia, soprattutto Sassaia, è un luogo assolutamente particolare, ma allo stesso tempo con delle dinamiche che sono facili da riconoscere. Ecco, vorrei quindi fare due riflessioni su questo, sul luogo, su come e se ha influito sulla costruzione dei personaggi, ma anche sulla scrittura e la scrittrice.
Avevo da tempo l’idea di indagare il “dopo” di questa giovane donna. Però è stato solo quando ho scoperto Sassaia che mi sono detta “questo è il posto, è lui”: da lì viene l’immagine della mulattiera da cui è iniziata la storia. Il borgo esiste ed è nella mia valle, era nascosto da sempre in un posto che io conosco benissimo, in cui praticamente sono nata eppure non l'avevo mai visto. Ci sono capitata solo dopo la pandemia, assetata di spazi aperti e sentieri diversi. Ho incontrato questo luogo e da subito mi si è rivelato come un piccolo paradiso. Viviamo in un mondo che ci chiama sempre altrove, non siamo mai presenti a noi stessi e agli altri, e io avevo bisogno invece di un posto in cui ci fosse silenzio, lontano dal rumore del mondo, dalla pandemia e le guerre, avevo bisogno di un posto pulito che ti ricorda che miracolo è essere al mondo. Un posto in cui, appunto due persone come Bruno ed Emilia potessero incontrarsi.
Io all'inizio ho fatto fatica a capire la scelta, mi intrigava ma ho fatto fatica a capire la scelta di Emilia, di tornare proprio in questo luogo, perché sarebbe stato molto più facile confondersi nella folla di una grande città, nell'anonimato che le poteva concedere. È come se fosse un’ulteriore punizione.
È proprio così, perché lei non vuole in realtà darsi una vera possibilità. Vuole sopravvivere in un piccolo borgo disabitato che le ricorda le estati della sua infanzia, ma in cui crede non ci sia futuro. Però, quando incontri un'altra persona, il futuro arriva, ed è esattamente quello che accade sia a lei che a Bruno quando si guardano, e poi trovano il coraggio di parlarsi, di conoscerci. In più, nella scrittura, è pesato anche il fatto che io stessa avevo voglia di starci, a Sassaia. Da Bologna, mi mancava quell’isola di sassi senza wifi, tecnologia, rumore, traffico. Quindi mi sono anche regalata un posto in cui io desideravo stare, ritrovarmi. Patisco molto questo momento storico: per le guerre, i drammi epocali la violenza, ma anche per tutto questo virtuale che ha preso il posto degli incontri in carne e ossa, e per la velocità che non aiuta il tempo lento della comprensione e dell’amore. A Sassaia questo tempo lento, l’incontro, la meraviglia per il mondo che può essere un posto felice, sono possibili.
Quindi la scrittura è anche nata realmente lì?
In realtà no. La scrittura è possibile, forse, solo nella distanza, nel desiderio. Ma ci torno sempre, passo tutta l’estate in quella valle.
Ringraziamo l'autrice Silvia Avallone, la casa editrice Rizzoli e l'ufficio stampa per l'organizzazione e il supporto. Intervista a cura di Debora Lambruschini.
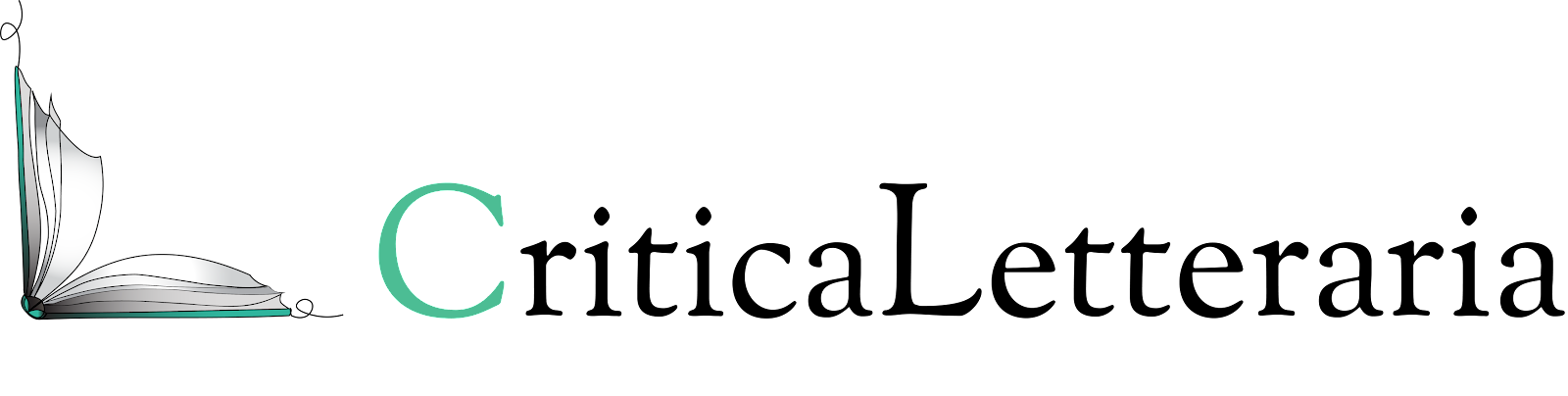

.png)
Social Network