Era il 1948 e le stradine polverose intorno alla Veneria di Lignana sembravano la Croisette di Cannes. Attori famosi, esordienti di talento, un pullulare di tecnici e un viavai continuo di intellettuali, scrittori, giornalisti. Durarono 75 giorni le riprese di Riso amaro, lungometraggio del regista Giuseppe De Santis che sarebbe uscito nelle sale cinematografiche l'anno successivo, ottenendo un clamoroso successo al botteghino, grazie a una trama che mescolava i generi e accendeva i riflettori sul duro mondo della risaia vercellese. In quei 75 giorni, sul set arrivarono Cesare Pavese, Italo Calvino, il fotografo Robert Capa e il senatore Giovanni Agnelli che, in realtà, era il padrone di casa dato che la storica tenuta, nel cuore delle Grange vercellesi, apparteneva all'Ifi, di cui Agnelli era presidente.
Il cast
E poi c'erano gli attori, bellissimi: Vittorio Gassmann, che raggiungeva la Veneria a bordo di una coupé bianca, dalla quale saltava fuori senza neanche aprire la portiera; Doris Dowling, star di Hollywood; l'esordiente Silvana Mangano, 18enne di statuaria bellezza la cui immagine sarebbe diventata iconica, e Raf Vallone, per il quale il film avrebbe segnato il trampolino di lancio dopo una vita nella quale l'allora 32enne aveva già brillato in altri settori. Calciatore di serie A, cresciuto tra i «Balon Boys» del Torino, dopo essersi laureato in filosofia e giurisprudenza Vallone aveva combattuto nella Resistenza e si era poi dedicato al giornalismo culturale per l'Unità. Riso amaro fu lo spartiacque di una carriera di attore che, fino a quel momento, si era sviluppata per lo più a teatro e in piccoli ruoli cinematografici.
75 anni di Riso Amaro, Giorgio Simonelli: "Quando a Vercelli arrivò anche Robert Capa"

«Un film epocale, che segnò la fine del neorealismo puro per aprire la stagione di pellicole grandiose, che guardavano a soluzioni tecnicamente molto più avanzate», dice Giorgio Simonelli, docente alla Cattolica e studioso di nuovi media. Settantacinque anni dopo la trionfale accoglienza ricevuta al botteghino, Riso amaro resta uno dei capisaldi della cinematografia italiana: l'immagina iconica di Silvano Mangano in shorts e calze nere, in mezzo alle risaie è entrata nell'immaginario collettivo, ispirato pubblicità ed è diventata il tema di uno dei murales recentemente restaurati a Legro, «paese dipinto», che si affaccia sul lago d'Orta.
Le mondine e le battaglie per i diritti
Attorno a quel nucleo di protagonisti, un cast fatto di comprimari di lusso e di centinaia di comparse, pagate 150 lire al giorno. Tra loro figuravano moltissime autentiche mondine, provenienti dalle zone limitrofe. Loro, la vita di risaia la conoscevano bene: schiena piegata e gambe nell'acqua a strappare le infestanti, tra zanzare, sanguisughe, bisce e rane. Erano figlie e nipoti delle donne, mondariso pure loro, che, all'alba del 1900, avevano sfidato gli agrari e la cavalleria, dando vita agli scioperi e alle manifestazioni che, il 1° giugno del 1906, portarono alla stipula del contratto che limitava a 8 ore l'orario di lavoro in risaia. Un passo epocale per i lavoratori e una pagina storica nelle lotte sindacali del bracciantato vercellese in cui spicca la figura di Modesto Cugnolio, avvocato e poi parlamentare socialista, difensore delle istanze di una massa anonima di lavoratrici coraggiose.

Furono le donne a guidare la battaglia per i diritti, come testimonia la foto di una manifestazione, scattata da Andrea Tarchetti e oggi impressa sulla lapide che, sotto il portico del Municipio di Vercelli, ricorda la conquista delle 8 ore. E sempre le donne, all'epoca di Riso amaro, arrivavano a migliaia nella stagione della monda per ripulire le coltivazioni da erbacce e «riso crodo». Alla sola Veneria, «cascina modello» ristrutturata nel 1938, dove esistevano una chiesa, una scuola materna e una elementare, i quattro capannoni dormitorio, dotati di impianti sanitari che per l'epoca erano all’avanguardia, potevano ospitare 800 mondine. La Veneria, come anche la tenuta Selve di Salasco, dove vennero girate le scene iniziali del film, hanno mantenuto la propria vocazione risicola. Ma la loro natura, da allora, è profondamente mutata, così come è cambiata la risicoltura.

Le risaie
Nessun'altra coltivazione trasforma il paesaggio quanto il riso: in primavera il vercellese è un «mare a quadretti» che si estende per oltre 80mila ettari, nel quale galleggiano solitari cascinali e la catena del Monte Rosa si specchia nella distesa delle risaie allagate. Con il passare dei mesi è il verde intenso delle piantine a colorare una pianura che sembra infinita, poi tocca all'ocra del riso maturo, e infine al grigio delle stoppie secche e un po' spettrali tra le nebbie d'autunno. Una tavolozza di ambienti e colori che, per secoli, ha scandito il susseguirsi dei giorni e delle stagioni. In questo scenario, la fila delle mondariso al lavoro ritratte in Riso amaro non è poi così diversa dal quella che, 50 anni prima, il pittore Angelo Morbelli aveva fissato sulla tela del suo capolavoro Per ottanta centesimi!, oggi esposto al Museo Borgogna. Un contesto in apparenza immutabile che, solo una decina d'anni dopo le riprese del film di De Santis, sarebbe stato spazzato via dalla meccanizzazione e dallo sviluppo dei prodotti fitosanitari. L'evoluzione che De Santis aveva anticipato sul fronte artistico – mescolando i generi e gli attori per dare vita a una trama innovativa per il tempo – avrebbe visto, nella vita reale, un'accelerazione verso la meccanizzazione del lavoro agricolo e la decisa virata verso l'industrializzazione.
Riso amaro, Natalia Bobba: "Perché dovremo essere per sempre grati alle mondine"

Chi vuole capire quale fosse la vita di risaia fino a 75 anni fa può visitare il Conservatorio della risicoltura, allestito alla Tenuta Colombara di Livorno Ferraris, «patria» del riso Acquerello: qui, grazie all'impegno della famiglia Rondolino e di Mario Donato, sono stati recuperati macchinari, arredi originali e riallestite la camerate nelle quali le mondariso trascorrevano il tempo del riposo. Le visite, su prenotazione, vanno concordate telefonando allo 0161.477.832 e consentono di immergersi in un'epoca che sembra distante anni luce dalla nostra. Oggi il mondo dell'agricoltura è fatto di mezzi a controllo satellitare, di tecnologia di precisione, ma anche di semine in asciutta per fronteggiare gli anni in cui piogge e acqua sono merce rara. E le squadre di mondariso, che pure parzialmente vengono ancora utilizzate, sono composte da lavoratori che arrivano da Paesi lontani. «Eppure è alle mondine che dobbiamo tanto della nostra storia - dice con convinzione Natalia Bobba, imprenditrice agricola e presidente di Ente Risi -: è a loro che dovremmo dire grazie per come è diventata la risicoltura di oggi».



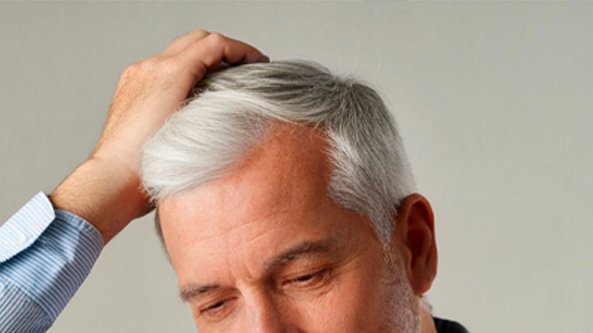

I commenti dei lettori