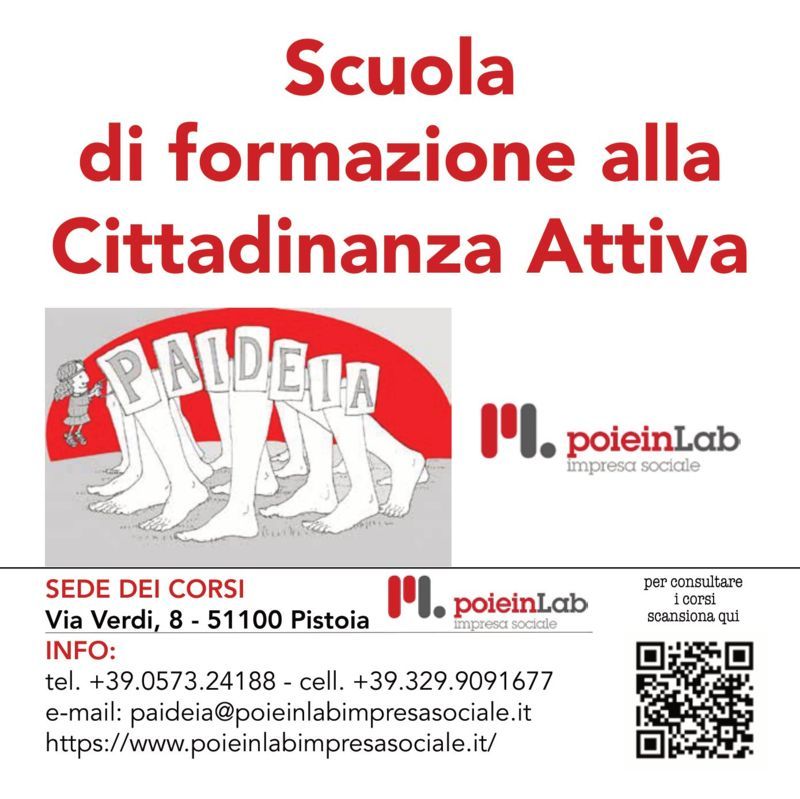FORLÌ – Un lungo percorso espositivo attraverso una vasta selezione di opere per una vera e propria “immersione” nell’arte dei Preraffaelliti, dalle origini e dai modelli fino allo sviluppoi e alla sua eredità culturale.
C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per visitare la grande mostra “Preraffaelliti: Rinascimento moderno” presso il Museo Civico di San Domenico di Forlì: un evento che si è aperto lo scorso mese di febbraio e che ha avuto un’ampia risonanza a livello mediatico, giustificata dalla vastità della collezione presentata e della complessità del lavoro di ricerca storica, artistica e archivistica alla base dell’allestimento dell’esposizione.
Curata da Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Cristina Acidini e Francesco Parisi con la consulenza di Tim Barringer, Stephen Calloway, Charlotte Gere, Véronique Gerard Powell e Paola Refice, la mostra, attraverso oltre trecento opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli intende narrare la storia delle tre generazioni di artisti associati o ispirati alla corrente dei Preraffaelliti, che rappresentò senza dubbio un’esperienza significativa nel contesto variegato dell’arte europea nella seconda metà dell’Ottocento.

Il Preraffaellismo, la cui data di inizio può essere fissata con certezza al 1848, ma la cui conclusione non è facile da individuare perché sfuma nei movimenti decadente e simbolista, non fu, al contrario di un’opinione comune, un ritorno reazionario e in senso “romantico” e nostalgico agli stili del passato, ma un progetto visionario capace di creare opere decisamente moderne, restituendo forza e presenza alla tradizione artistica del Rinascimento italiano.
Nato come “confraternita” di artisti nel contesto dell’Inghilterra vittoriana, il movimento già nel proprio nome evidenzia il richiamo programmatico all’arte esistita “prima di Raffaello Sanzio”: quest’ultimo è infatti visto in chiave negativa, colpevole a loro giudizio di aver sacrificato la realtà in nome della bellezza e di aver dato inizio a dei modelli che ancora nell’Ottocento erano alla base dell’arte accademica.
In aperta polemica contro il mondo delle accademie e i modelli della pittura “ufficiale” dell’età vittoriana, i Prereaffaelliti si dedicano a un’indagine artistica che guarda ai capolavori italiani del primo Rinascimento, adottando uno stile pittorico presto divenuto caratteristico: il panneggio morbido e delicato, la luminosità dei soggetti raffigurati, la presenza di figure femminili eleganti e sensuali, i frequenti richiami simbolici e allegorici.
Gli artisti di questo movimento non rimangono impassibili di fronte al fascino esercitato dal Medioevo, spesso “rivisitato” nelle loro opere in chiave fantastica e fiabesca, e si rivelano avidi lettori con frequenti richiami letterari al mondo biblico, al teatro di Shakespeare e soprattutto alla “Commedia” di Dante, vera e propria “pietra miliare” che diventa per essi una fonte quasi inesauribile di ispirazione.
Elemento caratteristico dell’intera mostra è il continuo e diretto confronto tra gli artisti moderni e i maestri italiani dal Trecento al Cinquecento, evidenziando come lo sguardo al Rinascimento storico sia stata la premessa per questo nuovo Rinascimento artistico portato avanti dai Preraffaelliti inglesi. Ecco dunque affiancati per la prima volta con questa estensione i grandi maestri del passato come Beato Angelico, Giovanni Bellini, Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi, Michelangelo, Guido Reni, Luca Signorelli, Mantegna, Veronese, Verrocchio, Cosimo Rosselli e gli inglesi Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, William Holman Hunt, John Ruskin, Edward Burne-Jones, William Morris, Ford Madox Brown, Elizabeth Siddal, Evelyn De Morgan, John William Waterhouse, George Frederic Watts, Henry Holiday, William Dyce, Charles Haslewood Shannon, Frederic Leighton, Simeon Solomon, Charles Ricketts, Frederick Sandys. I Preraffaelliti attinsero infatti a un’ampia gamma di influenze ed elementi storici, in momenti diversi si ispirarono all’arte e all’architettura gotica veneziana, a Cimabue, oltre che a maestri del Rinascimento, come Botticelli e Michelangelo, rivolgendosi infine con altrettanto entusiasmo all’arte veneziana del Cinquecento di Veronese e Tiziano.

Altra peculiarità della mostra è l’attenzione per le importanti figure femminili che animarono la Confraternita. Le opere di artisti come Rossetti, Leighton e Burne-Jones presentavano figure femminili dalla sensualità enigmatica, passioni tristi e bellezza sfuggente e “decadente” che entrarono indelebilmente nell’immaginario collettivo collegato al movimento. Ma donne come Elizabeth Siddal, Christiana Jane Herringham, Beatrice Parsons, Marianne Stokes o Evelin de Morgan non furono solo “muse”, ma contribuirono attivamente a plasmare l’identità estetica dei Preraffaelliti con una produzione che è qui ampiamente rappresentata e valorizzata.
Seguendo il corso di un movimento che si è sviluppato per vari decenni, la mostra si articola in dodici sezioni che hanno come filo conduttore il concetto di “reinvenzione” nelle sue varie declinazioni: esse sono documentate da opere di artisti britannici poco noti al grande pubblico, ma in grado di restituire con inedita chiarezza i tratti peculiari di questo passaggio storico.
Il percorso si apre con una sezione dedicata direttamente ai grandi maestri italiani con opere di artisti come Cimabue, Beato Angelico, Filippo Lippi, Luca Signorelli e Sandro Botticelli, in modo da far immergere subito il visitatore nella cultura visiva a cui ha guardato il Preraffaellismo.
La sezione successiva è invece dedicata al “revival gotico”, e ospita opere di John Rorgers Herbert e William Dyce, diretti precursori dei pittori preraffaelliti. Ma è presente anche una serie di disegni di architetture italiane realizzati da John Ruskin, critico d’arte, poeta e pittore, appassionato dell’architettura di Venezia, che ebbe un ruolo fondamentale per il movimento preraffaellita e di cui fu il teorico di riferimento.
Seguono le prime opere della vera e propria “Confraternita preraffaellita”. Questa parte, suddivisa per piccoli nuclei, inizia con Ford Madox Brown – importante trait d’union con movimenti precedenti, come il gruppo dei pittori tedeschi dei Nazareni – e prosegue con i disegni e i primi dipinti di Dante Gabriel Rossetti, uno dei protagonisti del movimento. Si tratta di opere raramente inserite in mostre dedicate ai Preraffaelliti, ma che danno modo di apprezzare la capacità artistica dell’artista. Esse vengono messe in dialogo con i disegni di Elisabeth Siddal, modella e musa ispiratrice di Rossetti, che fu anche a sua volta artista e poetessa.
La mostra procede con John Everett Millais, William Holman Hunt, Walter Deverell e Charles Allston Collins, mentre la “sala degli affreschi” è interamente dedicata a Edward Burne-Jones, di cui si può ammirare la “Small Briar Rose Series” e l’incompiuta “Venus Discordia”. Queste tele documentano la forte influenza esercitata dai capolavori di Michelangelo che l’artista ebbe modo di studiare nel 1871 quando, nel suo terzo viaggio in Italia, realizzò anche copie fedelissime degli affreschi della Cappella Sistina. Ecco perché completano la sezione disegni dello stesso Michelangelo, accanto a opere notevoli di Bernardino Luini, Filippino Lippi e Cosimo Rosselli.
La successiva sezione dedicata alle arti applicate si propone di mostrare che cosa si intendesse già a quel tempo per “arte diffusa”, in una sorta di anticipazione dell’interesse verso le arti cosiddette “minori” che sarà poi fatto proprio dalla Secessione: qui si trovano i primi esempi di carta da parati disegnata da William Morris e altri preziosi oggetti che fanno parte del “revival rinascimentale” che caratterizzò il gusto britannico dell’epoca.
Il percorso procede con sezioni dedicate alla pittura di Dante Gabriel Rossetti, che interpreta con le sue figure femminili un tema caro ai Preraffaelliti, per i quali la donna è figura ambivalente: dell’amore essa infatti incarna tanto la vita edonistica quanto la forza distruttiva, dualità che rende manifeste le fragilità umane su cui si interroga continuamente questo movimento. Da non perdere il celebre dipinto “La vedova romana” (1874), posto in “copertina” della mostra, efficace sintesi degli elementi e dei princìpi che caratterizzano l’arte preraffaellita, con la raffigurazione della modella Alexa Widding nelle vesti di una nobildonna romana dalla sensualità romantica e sfuggente, in un’opera intrisa di richiami classici e simbolici.
Nelle stanze successive troviamo la sezione dedicata alle opere di George Frederic Watts e di Frederic Leighton, che fu presidente della Royal Accademy e svolse un ruolo straordinario nel diffondere la cultura italiana in Gran Bretagna, le cui opere sono messe a confronto con quelle di Paolo Veronese e Tiziano.

Ad aprire l’ultima parte dell’allestimento sono gli artisti che esposero alla Grosvenor Gallery, fondata nel 1877 come alternativa progressista alla Royal Accademy, ossia tele di Evelyn De Morgan, John Roddam, Spencer Stanope, Fred Appleyard, Phoebe Anna Traquair, opere decorative di William De Morgan e Walter Crane, sculture di Alfred Gilbert e William Reynolds-Stephens.
Il percorso si conclude con una sezione dedicata agli artisti italiani che subirono la fascinazione per le tendenze neorinascimentali attraverso i progetti architettonici come la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (1865) e i portici di Piazza della Repubblica di Firenze (1885-95), oppure da opere d’arte decorative come i mobili presentati alle esposizioni universali di Parigi e Milano a cavallo tra i due secoli.
Una mostra, quella forlivese, sicuramente da visitare, con l’unico difetto dovuto proprio alla sua complessità e alla vastità di materiale esposto: perchè la visita non risulti superficiale e consenta di poter ammirare le opere principali e comprendere lo sviluppo storico e artistico del movimento preraffaellita, sono necessarie almeno due ore. Per una visita completa e approfondita di tutte le opere esposte, il tempo stimato raddoppia. È tuttavia possibile usufruire di un’ottima audioguida, inclusa nel biglietto d’ingresso, che consente a tutti i visitatori di selezionare la sala o l’opera interessata per avere una spiegazione abbastanza sintetica e allo stesso tempo esauriente.