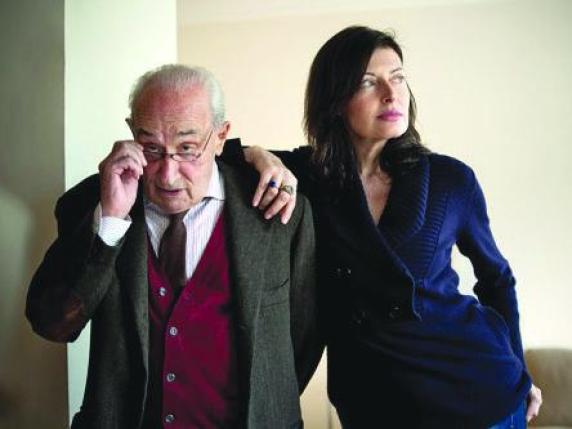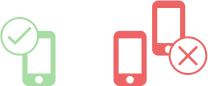Isabella Gherardi, la moglie di Giovanni Sartori: «La cena fatale? Una scatoletta di zuppa. Lui sprigionava carisma»
L'artista: «La differenza di età tra noi? Lui sprigionava carisma». I racconti: «Agnelli, Kissinger e Bush: ecco cosa pensava di loro»
Il primo incontro?
«Più che un incontro, un flash fotografico. Nei primi anni Novanta, a Firenze, vidi sfrecciare Sartori in bicicletta. Il tempo di un fugace sguardo, mi girai ma nulla, era già scomparso nei vicoli della città».
E come vi rincontraste?
«Fui invitata a una festa, lui era l’ospite d’onore. Lo riconobbi e colta da un attacco di panico mi rifugiai in una terrazza, sbirciando ogni tanto all’interno. La padrona di casa, la marchesa Geddes da Filicaia, mi invitò più volte a entrare in salotto perché voleva presentarmelo ma io, paralizzata dalla timidezza, resistetti all’esterno».
E poi?
«Dovevo intervistare Philippe Daverio, che si trovava a Firenze per ritirare un premio. Arrivai in ritardo, pioveva a dirotto. Entrai nella sala dove si svolgeva la conferenza e mi accorsi che stava parlando Sartori. Mi sedetti in una delle ultime file, tramortita».
E Daverio?
«Gli chiesi di presentarmi il professore e così fece. Io e Vanni ci ritrovammo a parlare nella terrazza del museo Bardini, sotto il mio enorme ombrello e sotto la pioggia. Ci scambiammo i numeri telefonici».

Un giovane Giovanni Sartori
Vanni è Giovanni Sartori, che nel Novecento è stato uno dei politologi italiani più famosi al mondo, nato esattamente cent’anni fa e scomparso nel 2017, per anni uno degli editorialisti di punta del Corriere della Sera. Lo racconta la moglie, l’artista Isabella Gherardi, sommersa da un mastodontico archivio di ricordi che sta mettendo in ordine nella loro casa romana.
Tra lei e Sartori c’era una grande differenza di età.
«Era un uomo che sprigionava un immenso carisma. Un mix di straordinaria semplicità espressiva, enorme cultura e un incredibile sense of humor. L’incontro fatale avvenne a New York, nella sua casa al ventisettesimo piano del Century Building su Central Park West. In una serata di pioggia, io e lui ci ritrovammo a dividere una scatoletta di zuppa di pomodoro e una mela, le uniche cose commestibili della sua cucina».
Che tipo era?
«Vanni era un uomo di grande vigore, aveva un passato da sportivo, grande sciatore e amante del mare, della pesca senza bombole e della vela. Pensi che mi raccontava di una crociera alle Baleari sulla barca del suo amico d’infanzia Emilio Pucci, durante la quale salvò, tuffandosi, Margaret d’Inghilterra, la principessa inavvertitamente era caduta in acqua, forse per una dose eccessiva di whisky mattutino. Ma in gioventù Vanni aveva fatto gli incontri più impensabili, ad esempio Jaqueline Kennedy».
In quale occasione?
«Vanni frequentava la villa di Marlia, a Lucca, allora dei Pecci Blunt. Jacqueline Kennedy, da poco vedova, passeggiava solitaria nei giardini della villa e Vanni se la trovò davanti all’improvviso; per rompere il ghiaccio se ne uscì con la frase pronunciata dal giornalista Stanley sul lago Tanganica, quando aveva ritrovato l’esploratore scomparso da anni: “Doctor Livingstone, I presume”. La Kennedy evidentemente non aveva colto l’ironia ed era passata oltre, quasi fuggendo via».
Che infanzia aveva avuto Sartori?
«La madre Emilia, detta Titina, era di origine belga. Il padre Dante era l’erede di un importante lanificio che il nonno, aveva fondato a Schio, in Veneto, e poi trasferito a Stia. Due caratteri opposti: concreto e schivo il padre, mentre Titina, donna bellissima ed elegante, era mondana, amica di Montanelli, Colette Roselli e Lord Acton. Vanni imparò presto tre lingue oltre l’italiano e questa conoscenza fu determinante per i suoi studi e la sua carriera. Con me parlava in francese solo quando era arrabbiato per non far capire alla cameriera».
Infanzia dorata, insomma.
«Diciamo di sì. I suoi amici erano Spadolini e i giovani aristocratici della Firenze che d’estate si ritrovava in Versilia e che sarebbero rimasti suoi amici di tutta la vita. Da Giulia Maria Crespi a Marella Caracciolo. Anche se la distruzione della fabbrica del padre a opera dei tedeschi, nel 1944, cambiò molte cose. Il padre si interessò dopo anche di cinema, come produttore e finanziò lo Sceicco Bianco di Fellini».
Conosceva anche l’Avvocato Agnelli?
«Sì. Ma Vanni mi diceva che non amava un lato del carattere di Gianni, quello di avere una sorta di attenzione limitata; ti stava ad ascoltare per quei cinque minuti in cui destavi il suo interesse, poi repentinamente cambiava argomento. All’Avvocato, che era un suo amico di gioventù, questa cosa non la perdonava. Quando la stessa cosa gli capitò con Berlusconi, diciamo, non gliene importò granché».
Gli editoriali di Sartori su Berlusconi erano senza sconti, senza freni.
«Gianni Letta lo invitò ad un pranzo per farglielo conoscere. Berlusconi, appena diventato presidente del Consiglio, evidentemente voleva irretirlo. Quando si rese conto che non era cosa, il Cavaliere aveva smesso di ascoltarlo e cominciato a pensare ai fatti suoi. Ma guardi qua (Gherardi prende una foto in bianco e nero, ndr). Li riconosce?».
Sinceramente no.
«È la foto di un convegno organizzato da Raymond Aron nel 1959 sul tema della Guerra Fredda. Erano vicino a Basilea, solo pochi relatori. (Indica due persone, ndr) Questo è Sartori, questo qua Oppenheimer».
Il padre della scienza politica italiana e quello della bomba atomica.
«Alla scienza politica era arrivato passando dalla filosofia, a causa di uno straordinario incidente di percorso. Nel 1950, il preside della Facoltà di Scienze politiche di Firenze, Giuseppe Maranini, aveva offerto la cattedra a un suo portentoso pupillo venticinquenne, Giovanni Spadolini; Pompeo Biondi, per non restare indietro, aveva schierato in campo accademico Sartori, che a sorpresa si sarebbe ritrovato professore incaricato di Storia della filosofia».
Ma l’incidente di percorso qual era?
«L’8 settembre del 1943, la resa di Badoglio. Essendo nato nel ‘24, all’inizio di quell’anno Vanni avrebbe dovuto essere reclutato. Ma la chiamata alle armi avvenne in ritardo, autunno inoltrato. Come molti coetanei cercò di salvarsi disertando. Due suoi amici furono scoperti e fucilati. Lui si nascose prima in campagna, poi a Firenze in casa di uno zio dove c’era una biblioteca molto fornita di libri filosofici e, per svagarsi, si era messo a leggere Hegel, Croce e Gentile».
In America suo marito era una celebrità.
«La prima volta c’era stato nel Dopoguerra per un periodo di studi. Poi Stanford, la migliore facoltà di Scienze politiche d’America, dove gli offrirono la cattedra di Gabriel Almond; e infine, per quasi vent’anni, fino al 1994, alla Columbia di New York».
Le frequentazioni americane?
«Henry Kissinger ma anche i presidenti che, di volta in volta, lo ricevevano alla Casa Bianca. Di Jimmy Carter Vanni diceva che era un uomo noioso; dei coniugi Reagan ricordava invece come la passione per la chiromanzia di Nancy influenzasse tantissimo le scelte politiche del marito Ronald, che non di rado dipendevano dal parere dei maghi consultati dalla moglie. Stimava tantissimo Bush senior, conosciuto da vicepresidente, perché diceva che avesse una conoscenza perfetta della macchina economica e militare degli Usa».
Come mai alla fine degli anni Sessanta era stato richiamato all’Università di Firenze?
«Perché il preside dell’epoca non riusciva a tenere a bada la contestazione. Inverno freddo, facoltà occupata da mesi, Sartori scoprì che dentro gli studenti erano occupati sostanzialmente in due attività: fare lunghe telefonate intercontinentali in Cina ai compagni maoisti e praticare al caldo l’amore libero. Così, per far smettere l’occupazione, da preside impose due scelte: prima fece staccare le linee telefoniche, poi i termosifoni. L’occupazione finì».
Non aveva paura per la sua incolumità?
«Non credo. Girava con una bicicletta che il custode chiamava “la presidenziale”. Quando andavano a chiedere di lui, costui rispondeva “fatemi controllare se c’è parcheggiata la presidenziale”. I visitatori pensavano chissà a quale macchina blindata; poi vedevano che era una semplicissima bici».
Salottiero?
«Quanto basta. Ma aveva rifiutato, per esempio, di ricevere a casa a New York, Imelda Marcos. Una volta, durante una di queste serate, un importante critico cinematografico di cui non ricordo il nome, evocando in maniera figurata l’elezione di Barack Obama alla Casa Bianca, gli chiese che cosa ne pensasse del “cappuccino alla Casa Bianca”».
E lui?
«Rispose che alla Casa Bianca c’era stato tante volte ma che un cappuccino non gliel’avevano mai offerto. Comunque sia, di Obama non aveva una grande stima».
Perché?
«Perché alla Columbia non aveva frequentato il suo corso. Per Vanni era impensabile che un futuro presidente degli Stati Uniti d’America, avendone avuta la possibilità, avesse deciso di non apprendere i fondamenti della democrazia».
Parties and Party Systems, nel 1976, gli aveva dato la notorietà accademica mondiale.
«Poi a New York successe una cosa che visse come una tragedia. Mise in una borsa la Lettera 22 e le bozze del libro successivo, che era quasi completato, con l’obiettivo di andare a lavorare qualche giorno fuori città. Prese la macchina dal garage, si fermò, scese di nuovo e risalì in casa perché aveva dimenticato non so che cosa, chiedendo al portiere di controllare l’auto. Quando fece ritorno al piano terra, dopo pochi minuti, l’auto c’era ma la borsa era sparita. E con essa il libro nuovo, andato perso per sempre».
Sartori è morto il 3 aprile 2017 ma la notizia è stata data tre giorni dopo, a esequie avvenute. Perché?
«Aveva deciso così. Non voleva un funerale pubblico, non voleva celebrazioni, non voleva lacrime di coccodrillo. A segnarlo in questo senso era stato un funerale al quale aveva assistito un anno prima».
Il funerale di chi?
«Di Umberto Eco».